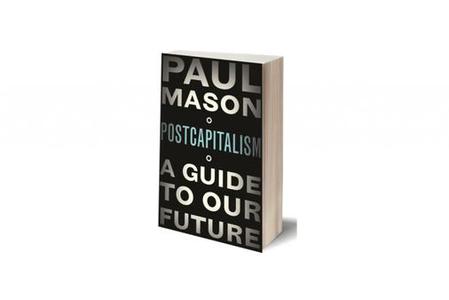di GIROLAMO DE MICHELE.
coi bottoni dorati e gli ottoni lucenti
fischiando la Marsigliese
mentre il vento fa il solletico ai sogni
rimasti incastrati nel cancello dei denti
Credo che tutti quelli che hanno amato o continuano ad amare Claudio abbiano qualcosa di profondo in comune.
Io ho scritto un romanzo ambientato a Bologna, nel quale passa Claudio. Non sto a spiegarvi come e perché, e a cosa serva dal punto di vista narrativo. Ma a un certo punto il protagonista, a Parco Nord, vede passare Claudio Lolli. Questo gli servirà più avanti, si ricorderà di questa immagine che gli farà scattare un’associazione libera. Lolli non c’entra niente con la trama. Ma passa. E sembra finita lì. A questo personaggio sono capitate delle brutte cose, e gliene stanno capitando altre: si è chiuso in se stesso, è un ex zingaro felice che ha smesso di essere ambedue le cose. È solo a casa e come fa sempre quando è solo, beve. E quando beve si intristisce, perché rivede tante persone che non vede più, che forse non vorrebbe rivedere, ma che forse vorrebbe anche rivedere. Casa sua diventa un’assemblea: c’è la sua ex ragazza che è morta, c‘è il suo grande amico che è in carcere, fine pena chissà quando. È entrato nella lotta armata e ha ucciso qualcuno più farabutto di lui, è stato preso, e dal carcere non risponde più neanche alle lettere. C’è un altro suo amico che, dal giorno in cui hanno scoperto che il loro amico comune era entrato nella lotta armata, ha quasi smesso di parlargli. Era il vecchio gruppo del ’77.
 E poi c’è Claudio Lolli che parla con Anna di Francia: l’ho voluta mettere come se fosse una persona reale. Se dovessi parlare del senso di questo mio contributo, è spiegare perché Anna di Francia per me è l’immagine della libertà; lo è sempre stata, da quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone. E dopo trent’anni di ascolti credo di avere capito perché, tra le tante belle canzoni di Claudio, è quella che mi è rimasta più impressa.
E poi c’è Claudio Lolli che parla con Anna di Francia: l’ho voluta mettere come se fosse una persona reale. Se dovessi parlare del senso di questo mio contributo, è spiegare perché Anna di Francia per me è l’immagine della libertà; lo è sempre stata, da quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone. E dopo trent’anni di ascolti credo di avere capito perché, tra le tante belle canzoni di Claudio, è quella che mi è rimasta più impressa.
La prendo un po’ per una via laterale. Ricordo che una volta, a un concerto, Claudio disse: «Secondo me la malinconia è di sinistra. Quando ho iniziato a cantare si pensava che la malinconia fosse di destra; e invece io volevo spiegare perché è di sinistra».
Io credo che sia una cosa vera e anche profonda, che la malinconia sia di sinistra. Credo che Leopardi fosse un grande malinconico, di sinistra. Credo che Michelangelo sia stato il più grande dei malinconici e credo sia importante dire che fosse di sinistra perché era malinconico. Così come Leonardo era di sinistra perché era ateo.
In questo momento credo che queste cose vadano dette. Perché la malinconia è di sinistra? Perché la malinconia non è mai realismo; il malinconico è uno che vive sempre una possibilità, non una realtà.
Prima parlavo di Michelangelo: mi sono riletto tutti i suoi versi, è uno dei miei poeti preferiti. Proprio ai tempi di Michelangelo il malinconico aveva smesso di essere la figura del maledetto: è nato sotto il segno di Saturno, poveretto, è fatto così, è una mela bacata. No, invece al tempo di Michelangelo il malinconico era quello a cui Saturno aveva dato una diversa possibilità. Poi stava a lui realizzarla o no. Michelangelo era un personaggio notturno; da qualche parte dice
…el vulgo volle
notte chiamar quel sol che non comprende.
Dice che la notte è quel sole che altri chiamano notte. Per lui la notte era il sole, lui la notte usciva e viveva la notte in modo diverso, come una diversa possibilità. Ecco, il malinconico è questo.
Anche Leopardi era malinconico, però anche lui parlava di felicità, sembra strano, però se andate a guardare nello Zibaldone, all’8 febbraio 1821 Leopardi scrive che «lo scopo dei governi (siccome quello dell’uomo) è la felicità dei governati», ossia «la felicità pubblica e privata, in somma la felicità possibile degli uomini come uomini […] cioè la felicità relativa e reale, e adatta e realizzabile in natura, tal quale ella è, non riposta nelle chimeriche e assolute idee, di ordine e perfezione matematica», che è anche una bella idea politica, se ci pensate. Qual era la felicità di cui parlava Leopardi? I filosofi del ‘700 che Leopardi leggeva, dicevano: la felicità è quella condizione nella quale sono libero di realizzare i miei scopi. Non è il benessere, non è la ricchezza; è la libertà. Lo scopo della politica dovrebbe essere realizzare la massima libertà possibile, il maggiore allontanamento dalle costrizioni.
Invece un realista cosa dice? Che la felicità è la ricchezza, il benessere, un mondo pieno di oggetti.
Allora, torniamo ad Anna di Francia.
Cosa c’entra con tutto questo? Anna di Francia è una persona che non vive né di parole né di cose: esce dall’osteria perché si sta riempiendo di parole, che parlano di parole, che quindi non significano molto. Questo non le basta più:
Anna si arrabbia, basta parlare,
Anna si alza, andiamo via
e mentre la strada mi fa perdonare
c’è Anna che brinda alla sua anarchia.
Nel gesto di Anna imprendibile più di un momento c’è il rifiuto di un linguaggio che si è irrigidito nell’ideologia, nello slogan, nella frase fatta: nell’univocità dei significati.
Però poi, nella seconda parte della canzone, c’è un lungo elenco di quello che l’io narrante – Claudio o la voce che parla di Anna – promette ad Anna, e fa un lungo elenco di oggetti che lui non sarà. La nostra vita non sarà quell’orologio, quel reggiseno appeso al lampadario, quel manico di scopa, quello specchio, la nostra vita non si ridurrà a cose, non sarà parole vuote ma non sarà nemmeno cose. A me all’università avevano insegnato che i poeti italiani vanno classificati tra quelli che parlano di parole e quelli che parlano di cose. Questa semplificazione mi sembrava davvero banale, non mi ci ritrovavo. Tempo fa, rileggendo Claudio, ho capito perché. Perché uno dei poeti che mi è più caro, che è Claudio Lolli, non sta né con le parole né con le cose, sta a metà strada, cerca di collegarle tra di loro.
Il fatto è che il linguaggio non è fatto né di parole univoche, né di cose naturali: è fatto di oggetti variabili che intessono relazioni tutte da costruire tra cose e parole, è fatto di significanti fluttuanti, eccessivi rispetto al loro oggetto (parole come libertà, felicità) e di significati fluttuati (parole come robo, coso, suoni come eh…, espressioni come vuoi che ti dica, dove il significato è in difetto rispetto a ciò che ancora dev’essere conosciuto). La lingua che usiamo perde la propria libertà, cioè il regno del possibile, quando si blocca nella convenzione linguistica o quando si fa didascalia di un’esistenza che si esaurisce nella descrizione della funzione, nella tranquillizzante sicurezza degli oggetti. Se ora rileggete il testo di Ho visto anche degli zingari felici, noterete che Lolli non usa parole univoche, né immagini materiali:
il meraviglioso equilibrio
di un’obesità senza fine,
di una felicità senza peso;
oppure:
è vero che spesso la strada sembra un inferno
una voce in cui non riusciamo a stare insieme.
Per contro, quando le immagini sembrano cose, avviene subito uno spiazzamento, uno slittamento laterale, come nella serie gobbo-tredici-ubriaco:
È vero che sputiamo per terra
quando vediamo passare un gobbo,
un tredici o un ubriaco…
L’astrattezza del tredici (avete mai visto un tredici per strada?) contraddice la naturalità della cosa-gobbo, l’ubriaco fa slittare il senso dello sputo, che non è evidentemente scaramantico, giacché gli ubriachi non portano sfortuna, ma provocano disgusto: sputo diventa allora una parola-baule che racchiude un intero mondo di parole, quel mondo nel quale
non vogliamo pagare
la colpa di non avere colpe,
o nel quale
non vogliamo cambiare
il nostro inverno in estate.
E il Vietnam di cui canta Lolli quale sarà, dove sarà? Di là dal mondo, sull’altra faccia dell’atlante, o qui, nella cucina familiare della mia gente, nei sogni del poeta o sulle prime pagine dei giornali?
Ecco, la poetica di Claudio secondo me è questa: se rileggete gli Zingari felici, vi rendete conto che le sue metafore non sono mai astratte. Però non sono neanche assolutamente concrete: restano indeterminate. Questo è lo sguardo del malinconico. È una vita possibile. Perché la vita possibile è qualcosa che dobbiamo realizzare, il senso che noi diamo alla luna.
Dall’altra parte cosa c’è, invece? Dall’altra parte c’è la felicità preconfezionata, quella che ci promettono i governi. Sembra un programma politico interessante, forse lo abbiamo già visto, forse a Bologna Claudio lo vede quotidianamente, può darsi che a breve ce lo riproporranno, non lo so. Le ragioni di questo programma sono in Incubo numero zero, mentre Ulrike Meinhof viene lentamente suicidata e la luna ha una faccia da strega e il sole ha lasciato i suoi raggi in cantina, e un aereo scrive VIVA IL LAVORO nel cielo, col sangue:
Provate ad ascoltare questo programma politico precotto, preconfezionato – e sorprende, o forse no, che queste parole siano contemporanee all’inizio della riflessione di Foucault sulla governamentalità. Claudio lo descriveva così:
Disoccupate le strade dai sogni
Sono ingombranti, inutili, vivi
Topi e rifiuti siano tratti in arresto
Decentreremo i formaggi e gli archivi
Disoccupate le strade dai sogni
Per contenerli in un modo migliore
Possiamo fornirvi fotocopie d’assegni
Un portamonete, un falso diploma, una ventiquattrore
Disoccupate le strade dai sogni
E arruolatevi nella polizia
Ci sarà bisogno di partecipare, ed è questo il modo
Al nostro progetto di democrazia
Disoccupate le strade dai sogni
E continuate a pagare l’affitto
E ogni carogna che abbia altri bisogni
Dalla mia immensa bontà sia trafitto
Da oggi è vietata la masturbazione
Lambro e Lambrusco vestiti di nero
Apriranno le liste di disoccupazione
Chiudendo poi quelle del cimitero
E poi costruiremo dei grandi ospedali
I carabinieri saranno più buoni
Assistenza forzata e gratuita per tutta la vita
E un vitto migliore nelle nostre prigioni
Disoccupate le strade dai sogni
E regalateci le vostre parole
Che non vi si trovi nascosti a fare l’amore
I criminali siano illuminati dal sole.
Sicuramente Anna di Francia qui è una criminale, illuminata dal sole, come i personaggi che vengono arrestati in Brazil. Però vedete com’è bello concreto questo programma, tanti begli oggetti, la ventiquattrore, il libretto d’assegni.
Qui tutto è quantificabile, parcellizzabile, misurabile. I valori saranno espressi da indici numerici, diagrammi cartesiani li descriveranno sotto forma di curve calcolabili: avremo indici di soddisfazione degli utenti, qualità dei servizi, certificazioni delle competenze acquisite da conservare in un apposito portfolio, certificati di esistenza in vita – persino la bontà dei carabinieri sarà misurabile, quantificabile e descrivibile graficamente. I sogni no, non sono certificabili né quantificabili: sono ingombranti, inutili, vivi. Anche vita non è un designatore, ma una parola-baule, o un significato fluttuato: nello sguardo malinconico sulla vita c’è sempre un di più di vita possibile che ancora non conosciamo da aggiungere alla vita vissuta.
Ma – Attenzione – anche i sogni, la fantasia, l’utopia possono diventare una prigione:
Però ci si affeziona anche alla propria fantasia
alla propria confusione
al proprio essere persi in mezzo al mar
e le vele e le reti e le prigioni sono calde
e danno sicurezza
proprio come dei santi incorniciati.
Attenzione: che non ci si risvegli una mattina
con qualche cosa da salvare.
…
Attenzione a non lasciarsi per la strada i gesti
le parole necessarie per parlare
attenzione a non svegliarsi una mattina
senza la voglia di cambiare.
Queste canzoni sono state scritte ai tempi delle barricate di Bologna, non dieci o quindici anni fa quando prima in Inghilterra e poi in Italia ci è stato detto: vi permettiamo una vita così – l’arrivismo, il yuppismo, arricchitevi, qualcuno resterà indietro, pazienza. Ecco, no, lo sguardo melanconico è sempre uno sguardo che fa un passo indietro rispetto a tutto questo: non mi basta l’oggetto ben preconfezionato, l’oggetto preciso. Non mi bastano neanche le parole precise, uso parole indeterminate.
In fondo Claudio ci ha dato delle chiavi di lettura: in Analfabetizzazione ha scritto che la semantica o è violenza oppure è un’opinione. Io il testo di questa canzone l’ho letto a quindici anni; me lo sono ritagliato e l’ho attaccato nella mia stanza. Io a quindici anni non sapevo cosa volesse dire che la semantica o è violenza oppure è un’opinione. Però sentivo che doveva essere così. Oggi la insegno, questa frase. Tutti gli anni a scuola inizio, la prendo lunga, arrivo agli stoici e poi scrivo questa frase alla lavagna. C’è stato un anno in cui l’ho scritta nella scuola in cui insegnava Claudio, perché eravamo colleghi. La cosa strana è che i ragazzi sapevano chi era il professor Lolli, ma non sapevano chi era il cantautore Lolli. Forse adesso lo sanno, o almeno spero.
E oggi che gli dei ci sono nemici, vale ancora lo sguardo malinconico, lo sguardo sul possibile, sulla libertà dalla servitù della mente e del corpo?
Negli Zingari avevamo trovato la parola inferno, ricordate?
È vero che spesso la strada sembra un inferno…
 Fortini, in quel gran libro che è Verifica dei poteri, parla dell’inferno come del «male divenuto tranquillo»: in un mondo ridotto a parole-scheletro e a cose tranquillizzanti, il linguaggio non viene messo in discussione, i bauli restano chiusi perché non sono visti come tali, e la stessa precisione delle parole – ci vogliono parole molto precise per contenere in esse interi mondi – si ammala della peste del linguaggio e dell’immaginario: e allora non distinguiamo più l’inferno dal paradiso, non combattiamo più «l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme». L’alternativa è data con facilità: «accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più». Al malinconico questo esercizio di addomesticamento non riesce: il suo sguardo vede il possibile, il non-ancora-reale che eccede il reale, pratica l’arte di «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». Diventa uno sguardo che si sdoppia, che vede ciò che c’è e ciò che non c’è (ancora). Noi viviamo in un’epoca che probabilmente è sempre stata inferno, anche quando negli anni ’70 la rivoluzione sembrava che fosse lì dietro l’angolo. Claudio ci metteva in guardia: attenzione a non crogiolarci in questa felicità, che non diventi anch’essa una prigione, e forse poi alla fine lo è diventata.
Fortini, in quel gran libro che è Verifica dei poteri, parla dell’inferno come del «male divenuto tranquillo»: in un mondo ridotto a parole-scheletro e a cose tranquillizzanti, il linguaggio non viene messo in discussione, i bauli restano chiusi perché non sono visti come tali, e la stessa precisione delle parole – ci vogliono parole molto precise per contenere in esse interi mondi – si ammala della peste del linguaggio e dell’immaginario: e allora non distinguiamo più l’inferno dal paradiso, non combattiamo più «l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme». L’alternativa è data con facilità: «accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più». Al malinconico questo esercizio di addomesticamento non riesce: il suo sguardo vede il possibile, il non-ancora-reale che eccede il reale, pratica l’arte di «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio». Diventa uno sguardo che si sdoppia, che vede ciò che c’è e ciò che non c’è (ancora). Noi viviamo in un’epoca che probabilmente è sempre stata inferno, anche quando negli anni ’70 la rivoluzione sembrava che fosse lì dietro l’angolo. Claudio ci metteva in guardia: attenzione a non crogiolarci in questa felicità, che non diventi anch’essa una prigione, e forse poi alla fine lo è diventata.
Però adesso a distanza di trent’anni è sempre lo sguardo malinconico che permette a Claudio di dire (Ulisse) che
il destino, il fato è cambiato
e oggi gli dei ci sono nemici
e certamente non basta più viaggiare
per sembrare degli zingari felici.
Però al tempo stesso dice anche, in una poesia che è dedicata a un suo amico, che a modo suo è anche lui un poeta (è poeta chi vive da poeta, e sa scovare dio che si materializza, / si transustanzia in un / campari soda):
La tua rivoluzione non c’è stata
ma ci sarà, perché il futuro è lungo.
È oscillando continuamente tra queste due dimensioni che Claudio riesce a essere quel poeta che ascoltiamo da una vita.
sia lieve la terra ai poeti e ai comunisti che sanno aprire le finestre sbagliate
* * *
Questo omaggio è stato scritto in occasione del convegno Piazza bella piazza. Gli Zingari compiono 30 anni (Perugia, 2 giugno 2006), e pubblicato nel volume degli atti Da una finestra sbagliata. Gli zingari felici di Claudio Lolli, a cura di Gianluca Veltri, Luciano Vanni Editore, Collescipoli, 2006 (una versione provvisoria fu pubblicata qui). Ho modificato qualcosa. L’immagine in alto è uno dei disegni di Enzo De Giorgi che illustrano l’ultimo disco di Claudio, Il grande freddo; la foto di Claudio Lolli è di Silvia Lelli