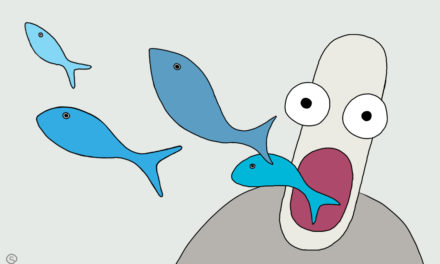Di NON UNA DI MENO ROMA
Qualcosa si muove tra le macerie della pandemia. Siamo separate, ma oggi più di prima congiunte dal desiderio di cambiare tutto. Un evento devastante come il Covid-19 richiede risposte potenti e un’ambizione smisurata. L’epidemia ha messo a nudo che la riproduzione della vita è incompatibile con il progetto neoliberale di estendere la logica del mercato a ogni ambito dell’esistenza. Ripartiamo dai saperi e dalle pratiche femministe e transfemministe che proprio della riproduzione sociale hanno fatto il terreno di conflitto prioritario. Ripartiamo da un tessuto collettivo e situato, mutevole nelle alleanze trasversali in cui prende sempre nuovo corpo. Perché se il presente è catastrofico, il futuro non è ancora scritto e le nostre lotte dovranno determinare le forme della convivenza dopo la pandemia.
Per trovare risposte potenti a eventi devastanti torniamo all’«arcano della riproduzione», ossia a quell’insieme di attività che rigenerano la vita umana in una determinata formazione storico-sociale: oltre la riproduzione delle generazioni, le cure psico-fisiche e sanitarie di tutt*, adult*, bambin* e anzian*, la gestione degli spazi e dei beni domestici, l’educazione e la formazione, l’accesso alla cultura, ai servizi, lo svago, le relazioni sociali. Sono stati i movimenti femministi a svelare la centralità del lavoro riproduttivo: condizione di esistenza della società tutta, della sua prosecuzione nel tempo.
A partire dagli anni Settanta il movimento Salario al lavoro domestico ha documentato come la stessa transizione al capitalismo, agli albori della modernità, sia stata possibile solo attraverso l’occultamento, la naturalizzazione e dunque la svalutazione del lavoro di riproduzione. Senza le attività di cura e domestiche che assicuravano la sussistenza dell’operaio, non si sarebbe data forza lavoro. Senza forza lavoro, non si sarebbero dati né fabbrica né profitto. Eppure, la riproduzione è stata misconosciuta come lavoro, ascritta all’ambito delle risorse naturali disponibili all’appropriazione. Così si è giustificata, e ancora si giustifica, l’estorsione di un’immane fetta di ricchezza. È questo il filo rosso che lega il lavoro gratuito delle donne all’interno delle case e l’espropriazione delle risorse del pianeta.
E, come sottolineato dalle femministe afro-americane e antirazziste, lavoro domestico e riproduttivo ed espropriazione delle risorse sono sempre stati attraversati dalla linea del colore. Le donne migranti e razzializzate continuano a farsi carico di estenuanti attività di cura dentro e fuori l’ambito della famiglia; le popolazioni e i territori indigeni sono, ieri come oggi, prese d’assalto dalla violenza predatoria del capitalismo. Questa, l’eredità della storia schiavista e coloniale.

Per trovare risposte potenti a eventi devastanti guardiamo alla trasformazione della riproduzione nelle società neoliberali prima e dopo la pandemia. Il modello neoliberale si fonda sull’esaltazione del mercato e della competitività sociale, sulla responsabilità individuale nell’adattamento al rischio, sulla privatizzazione e, insieme, sull’erosione di quelle istituzioni e politiche pubbliche attraverso cui, nel XX secolo, si è minimamente redistribuito a livello sociale anche il lavoro riproduttivo e di cura. Negli ultimi cinquant’anni, inoltre, lo smantellamento del welfare ha corrisposto a una trasformazione radicale del lavoro, definita anche “femminilizzazione del lavoro”: intermittenza e coazione a una piena disponibilità del tempo, sfruttamento e messa a valore delle capacità relazionali, linguistiche, di cura. Se, da un lato la riproduzione è diventata immediatamente produttiva, dall’altro, le catene del valore si alimentano con lo sfruttamento delle donne, delle soggettività razzializzate e non conformi, con la precarizzazione della vita di intere generazioni.
Con l’arrivo del Covid-19 le strutture della riproduzione sociale e della cura, prime fra tutte quelle sanitarie, hanno mostrato tutta la loro fragilità. In Italia, solo l’ultimo decennio di politiche neoliberali e di austerità ha cancellato 70.000 posti letto, 359 reparti e interi ospedali. L’esito più brutale, fallimentare, di queste misure è sotto gli occhi di tutt*. La pandemia ha rivelato la centralità della riproduzione sociale, ma anche la sua crisi profonda. Il virus, dice qualcuno, colpisce senza distinzione di classe. Ma le discriminazioni classiste, razziste, anagrafiche, abiliste, si manifestano nelle possibilità di accesso alle cure. Ci sono vite che hanno diritto all’assistenza e alla cura e vite che non lo hanno. Non “nude vite”, ma vite assolutamente determinate, stigmatizzate, dal punto di vista economico, sociale, della sessualità e del genere, della provenienza geografica, delle abilità/disabilità, dell’età. Ci sono corpi che subiscono la quarantena, e altri che la rendono possibile perché non hanno mai smesso di lavorare, dentro e fuori casa: infermier*, medic*, lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizie, lavoratrici domestiche, della cura, insegnanti, madri che accudiscono bambin*, figlie che assistono genitori anziani.
Per trovare risposte potenti a eventi devastanti ripartiamo dalla casa, principale luogo di sfruttamento delle donne, ma anche primo spazio dei conflitti femministi. Da settimane siamo a casa, ma non tutt* nello stesso modo. C’è chi una casa non ce l’ha proprio. Le mura domestiche restituiscono fotografie di disuguaglianze. Per alcune la casa non è un rifugio dalla pandemia, ma luogo di oppressione, di minaccia, di violenza, fino al femminicidio. Per molte lavoratrici domestiche e della cura, le case (altrui) rimangono il luogo di un lavoro sfruttato e non riconosciuto. Lo hanno confermato ancora una volta le stesse istituzioni, con il decreto “Cura Italia”, che ha escluso le lavoratrici e i lavoratori della cura da garanzie di reddito e da misure di protezione per la loro salute. L’80% delle lavoratrici della cura in Italia è straniera – oltre un milione in numeri assoluti. Perdere il lavoro per loro significa anche perdere un posto dove vivere, e rimanere ostaggio di un dispositivo di sfruttamento che vincola al permesso di soggiorno la possibilità di accettare o rifiutare condizioni di lavoro.
Ripartiamo dalle case come campo di battaglia, come luogo in cui tessere nuove (ma anche vecchie) alleanze, coalizioni sediziose e intersezionali. Tempo della cura, è insieme tempo di conflitto e di immaginazione. Giochiamo a nostro favore le difficoltà che stiamo vivendo: le case, che adesso sono anche ufficio, aule scolastiche e universitarie, zona di indistinzione tra produzione e riproduzione, dovranno esplodere.
Per alimentare risposte potenti a eventi devastanti guardiamo alle reti dell’educazione e del sapere. Per anni il neoliberalismo ha affamato scuola e università. Dall’inizio della pandemia, la didattica si è trasferita on-line, fornendo, da un lato, al “capitalismo delle piattaforme” nuove occasioni per appropriarsi del sapere, che sempre è prodotto in modo cooperativo, dall’altro, accentuando le differenze sociali e le discriminazioni abiliste. Le dichiarazioni dei decisori, tecnici o politici che siano, irridono alla scuola come relazione e cura, esaltando il lavoro agile e smart. Ma come stanno denunciando le/gli insegnanti questo è fonte di un nuovo sfruttamento, nonché di una profonda discriminazione verso chi porta sulle proprie spalle il carico della cura di bambin*, anzian*, disabili.
Bambin*, adolescenti, ragazz* stanno pagando un prezzo altissimo alla pandemia. La trasmissione del sapere non può essere separata dalla prossimità con coetanei e docenti, che svolge una funzione fondamentale nella costruzione di relazioni autonome, svincolate dalla famiglia. Il suo venire meno avrà conseguenze pesanti, oltre che sul piano affettivo e sociale, anche sul piano politico: scuole e università sono luoghi dove le generazioni scoprono e alimentano le proprie passioni erotiche e politiche.
Proprio attorno alla scuola si sono mobilitate da subito tante reti di solidarietà territoriali, da quelle che si sono adoperate per colmare il digital divide, a quelle che hanno sopperito ai bisogni primari. Le pratiche di mutualismo non sostituiscono gli interventi istituzionali, ma segnano la via per la costruzione di un nuovo spazio comune, oltre lo Stato, ma anche oltre la famiglia, che non può più essere assunta come unità di misura attorno a cui distribuire reddito e risorse.
Per alimentare risposte potenti a eventi devastanti mettiamo la libertà di movimento al centro della riflessione sulla riproduzione sociale. Fin dai primi giorni dell’emergenza è stato chiaro come la catena di somministrazione del cibo dipenda dalle lavoratrici e dai lavoratori migranti, impiegati nell’agricoltura, nella logistica, nella distribuzione, nei servizi. In molt* si sono rifiutati di lavorare in assenza delle condizioni di sicurezza, mentre altr* sono stati bloccati dalle limitazioni alla circolazione tra gli Stati imposte per contenere la pandemia. Quello stesso sistema dei confini, che quotidianamente produce morte tra le donne e gli uomini migranti, ci mette di fronte al nesso inscindibile che lega la libertà di movimento alle condizioni di riproduzione della vita.
Nei CPR, da Ponte Galeria a Gradisca d’Isonzo, nei CAS creati per il contenimento dei richiedenti asilo, nelle baraccopoli e nelle occupazioni informali, che sopperiscono all’assenza di accoglienza e casa, le restrizioni alla circolazione imposte nell’emergenza sociale e politica Covid-19, non sono misure che bloccano la pandemia, ma moltiplicano gli ostacoli alla libertà di salvarsi. È così per il vergognoso decreto che dichiara l’Italia “porto non sicuro”, come per gli accordi che bloccano i migranti in Libia o sulle isole greche. Oltre a numerose fabbriche non-essenziali, sono stati proprio i CPR, come anche le carceri, a essere rimasti in piena attività, mostrando il loro ruolo di istituzioni volte a riprodurre corpi destinati allo sfruttamento.
Gli eccidi in atto nel Mediterraneo, a cui la pandemia ha fornito una nuova scusa, ci mostrano che le politiche contro la libertà di movimento sono politiche di morte. Per alimentare risposte potenti è necessario mettere la libertà di movimento al centro delle nostre battaglie e costruire attorno a questa rivendicazione un nuovo universalismo di accesso ai diritti, al welfare, al reddito.
Per alimentare risposte potenti a eventi devastanti, guardiamo alle dimensioni socio-ecologiche della riproduzione. Il nesso tra riproduzione sociale e quella ecologica non è nuovo. Oltre al lavoro delle donne, il capitalismo dell’era industriale ha appropriato la biosfera come fonte di materia ed energia. Entrambe, attività riproduttive e biosfera, sono state ridotte a risorse gratuite per alimentare un modo di produzione guidato dall’imperativo del profitto e della crescita. Oggi, al collasso delle strutture della cura, corrisponde quello degli ecosistemi. La pandemia e i suoi effetti devastanti sono frutto di questa doppia dinamica. La crescita fuori controllo di deforestazioni, coltivazioni intensive, allevamenti industriali di animali e insediamenti urbani hanno aumentato la frequenza dei salti di specie dei virus. Dopo aver trovato un nuovo ospite, il Sars-Covid-2 si è propagato attraverso i circuiti dell’economia globalizzata. Il virus, dicono alcune ricerche scientifiche, viaggia nelle particelle di smog e si trasmette con più facilità nelle aree dove l’aria è fortemente inquinata, a grande densità abitativa, oltre che produttiva, da Wuhan alla Pianura Padana. In Italia l’infezione si è estesa nei luoghi di lavoro chiusi troppo tardi e riaperti troppo in fretta. La curva del contagio è cresciuta in un sistema sanitario indebolito dai tagli e dalle privatizzazioni. La pandemia ha confermato su scala inedita, ciò che alcune lotte femministe e conflitti socio-ecologici sostengono da tempo: non possiamo ignorare, o declinare come secondario, il nesso tra riproduzione sociale e quella ecologica e le sue implicazioni politiche. La scommessa è estendere la cura dai corpi singoli a ciò che permette loro di persistere: la relazione, gli ecosistemi, la biosfera, il pianeta intero. Questo è terreno di incontro, e convergenza possibile, tra movimenti femministi e transfemministi ed ecologisti.
Per alimentare risposte potenti a eventi devastanti è necessaria una redistribuzione radicale della ricchezza. Mentre in Europa e a livello globale si consuma lo scontro sugli strumenti da mettere in campo per gestire una crisi economica, oltre che sanitaria, di dimensioni immani, quel che inizia a emergere è che sarà inevitabile, per Stati e istituzioni economico-finanziarie, rilanciare la spesa sociale. Il punto è come. Quanti e a chi verranno destinati i fondi pubblici? Questo rilascio si darà sempre attraverso il meccanismo del debito?
Non ci accontentiamo di misure di emergenza. In tant* in questo momento stanno rilanciando la rivendicazione di un reddito di base, da quello di cura a quello di quarantena. In modo affine, siamo convinte che sia necessaria una misura strutturale e redistributiva. Da anni infatti rivendichiamo un reddito di autodeterminazione: universale e incondizionato, rivolto alle singole persone e non al nucleo familiare, slegato da prestazioni di lavoro, dalla cittadinanza e dalle condizioni di soggiorno, che sia garanzia di autonomia economica, strumento di fuoriuscita dalla violenza di genere, dallo sfruttamento lavorativo ed ecosistemico. Rivendichiamo reddito di autodeterminazione insieme al salario minimo europeo, per evitare che il primo divenga uno strumento in mano a imprese e datori per comprimere gli stipendi e al fine di contrastare le paghe da fame, le disparità salariali tra donne e uomini, nativ* e migranti.
Vogliamo che le istituzioni del welfare vengano strutturalmente rifinanziate e che siano istituzioni universali, gratuite e solidali, a cui tutt* possano accedere: sanità pubblica e laica, moltiplicazione dei presidi territoriali, assunzioni a tempo indeterminato e stabilizzazioni del personale; investimenti in scuola, formazione e ricerca; servizi per l’infanzia; a sostegno e per la cura delle persone più vulnerabili; garanzia del diritto all’abitare; previdenza sociale.
Allora le lotte per il welfare, oltre a essere lotte per la redistribuzione della ricchezza, emergono in tutta la loro importanza come lotte per la democrazia, per la riappropriazione democratica delle infrastrutture sociali. La difesa del pubblico è immediatamente immaginazione di istituzioni comuni e di libertà oltre lo Stato.

Per alimentare risposte potenti è necessario costruire in comune nuove alleanze della cura. «Ridurre la curva e aumentare la cura», è lo slogan del collettivo di artiste e attiviste Pirate Care, che restituisce, a nostro avviso, il senso profondo della scommessa femminista e transfemminista: contenere il contagio non basta, occorre invece lottare per riorganizzare le infrastrutture della cura, sottrarne il controllo al mercato. Solo così i corpi oggi più esposti agli effetti (anche economici e sociali) del Covid-19 troveranno quei margini di sicurezza che al momento sono privilegio di pochi.
Le reti di mutualismo e solidarietà create in molti centri urbani d’Italia vanno in questa direzione: adottano forme di cura dal basso che spostano l’attenzione oltre gli individui. A Roma, come in altre città, i centri anti-violenza femministi, da Lucha y Siesta a BeFree, a D.i.Re alla Casa Internazionale delle Donne, continuano a operare, a distanza, a sostegno di donne vittime di violenza, costrette a casa con uomini che abusano e minacciano. Così la rete di solidarietà tra e verso le sex workers che è riuscita a superare barriere di stigmatizzazione e criminalizzazione, mettendosi al fianco di chi, in questa emergenza, è più esposta sia al contagio che allo sfruttamento. Così anche gli sportelli e le organizzazioni sindacali che tutelano i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precar*, migranti, informali, senza tutela, disoccupat*, fornendo assistenza legale o per l’accesso agli ammortizzatori sociali; o, ancora, gli spazi e le reti sociali e territoriali che stanno organizzando le spese e distribuzioni solidali.
La cura diventa così terreno di sperimentazione. Oltre gli spazi chiusi degli ospedali, di certo essenziali nella crisi sanitaria, oltre il privato della famiglia, la cura si fa diffusa e promiscua, nutrita da reti di intimità che non coincidono con le parentele biologiche. Occorre ripensare forme e istituzioni della cura oltre il modello familistico ed eteronormato, individualista e patriarcale. Occorre ripensare le relazioni e la vita in comune, abbattendo una volta per tutte la violenza del modello neoliberale, machista e predatorio nei confronti della vita.
Le lotte che si prefigurano richiedono forza, determinazione, creatività. Abbiamo aperto una pista con la risignificazione dello strumento dello sciopero. Un processo che è ancora in atto. In questa direzione dobbiamo proseguire. E le lavoratrici e i lavoratori che hanno scioperato un mese fa, in piena emergenza Covid-19, ce lo hanno già dimostrato. Ce lo hanno dimostrato le sollevazioni nelle carceri.
Ora più che mai è il momento di tornare a battersi per la redistribuzione della ricchezza che da secoli ci viene estorta, rubata. Come le compagne argentine, prima della quarantena, è il momento di gridare con tutta la forza che ci anima che “noi siamo in credito e non in debito!” e “ci vogliamo vive, libere e sdebitate!”.
Questo articolo è stato pubblicato il 28 aprile 2020 sul blog di Non Una Di Meno