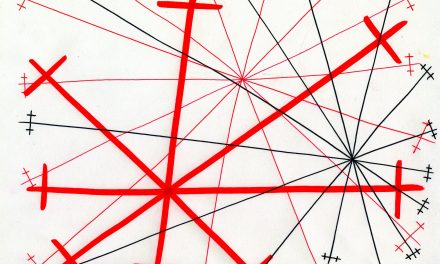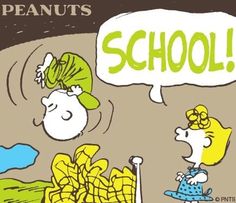di FEDERICO TOMASELLO.
(Domanda-Federico Tomasello) Continuiamo il nostro discorso sulla metropoli iniziato un anno fa con l’intervista La comune della cooperazione sociale, e proseguito poi con Il polmone comune della metropoli (entrambi pubblicati su EuroNomade). Riprendiamo il dispositivo teorico fondamentale da cui siamo partiti, il tuo adagio secondo cui la metropoli sta oggi alla moltitudine come una volta la fabbrica alla classe operaia, per provare a rivolgerlo verso un ulteriore orizzonte di analisi. Vorrei che tu sviluppassi alcuni aspetti nuovi di questa analogia fra fabbrica e metropoli interrogando le trasformazioni che hanno investito il capitale fisso e il ‘posto di lavoro’. Ha ormai statuto di ovvietà sostenere che oggi parte del lavoro del general intellect avviene dentro l’abitazione, che la casa stessa diviene in qualche modo un luogo di lavoro: come si colloca questo elemento all’interno della tua prospettiva sulla metropoli? È possibile condurre l’analisi dei nessi e delle discontinuità fra il paradigma di fabbrica e la realtà metropolitana contemporanea fin dentro la casa come luogo in cui, in misura sempre maggiore, avvengono momenti di lavoro e produzione di valore? È possibile ripercorrere l’analogia fabbrica/metropoli – l’estensione del meccanismo di produzione di valore all’intero tessuto metropolitano – a partire dalla dimensione micro della casa, delle tecnologie dell’abitare e dell’abitazione?
(Risposta-Antonio Negri) Rispondere a domande tanto generali comporta sempre delle approssimazioni, che permettono tuttavia di avvicinare l’oggetto. Così, tanto per cominciare, ricordo che, visitando l’anno scorso la Biennale di Architettura curata da Rem Koolhaas, mi sono imbattuto in una sua nota programmatica che era sviluppata poi lungo il percorso della mostra. Una sorta di vocabolario della casa, che recitava Dove gli elementi architettonici diventano macchine, una enciclopedia degli oggetti meccanici (dai rubinetti agli ascensori) che organizzano la nostra quotidianità, interpretandone i bisogni. E mi veniva in mente quella formidabile mostra del ’69, “Dove le attitudini diventano forme”, ora riportata da Basel a Venezia, nella Fondazione Prada, dove le opere, le immaginazioni, le affettività si fanno figure formali (segni, cumuli, topografie ecc.) di una massima astrazione dell’immaginazione e del desiderio. Ora, nel caso di questa Biennale (ma in generale per i temi di cui parliamo), le attitudini prese in considerazione sono ben diverse, eppure utile è il riferimento alle passioni ed alle forme in cui sono espresse. Sono le attitudini di chi abita e si serve della macchina abitativa per vivere e lavorare, in un rapporto ormai coerente con l’astrazione macchinica della produzione artistica – come Boltanski-Chiapello a suo tempo avevano raccontato. Dove dunque il concretissimo vivere e lavorare divengono forma. Una nuova forma del valore. Di fatto, quando si parla della casa, dal punto di vista oggettivo, si devono tenere presenti, in prima approssimazione, due elementi: le attitudini che diventano forme, e gli elementi architettonici che diventano macchine. Tanto più ciò vale quando consideriamo l’abitazione dal punto di vista soggettivo: attraverso la digitalizzazione della società e l’informatizzazione della città è possibile lavorare a casa in una situazione in cui gli elementi architettonici e le reti comunicative sono innestati nel tessuto della stessa abitazione. E se la città ha mille tempi, mille temporalità diverse che hanno a che fare con il lavoro, ciò è dovuto non semplicemente a precarietà e mobilità della forza-lavoro ma alla penetrazione materiale del comunicare nelle abitazioni ed al singolarizzarsi in esse. Il General Intellect abita, ha trovato casa. Ma è una dimora miserabile. A partire dalla crisi del 1973, i ritmi della città non sono più quelli del fordismo – cioè le 3 otto: lavoro, tempo libero, riposo, con trasporti e bordelli organizzati secondo questa sequenza – ma sono connessi alla generalizzazione urbana della cooperazione lavorativa e ad una nuova gestione del lavoro da parte degli stessi lavoratori. La fabbrica si è trasferita nell’abitazione. Analizzare gli scarti prodottisi fra il vecchio posto di lavoro in fabbrica e una situazione nella quale l’abitazione diventa l’“involucro” del nuovo posto di lavoro significa interrogare le forme di vita contemporanee – se è vero che la produzione è ormai legata interamente alle forme di vita. Questo nesso intimo, profondo fra forme di lavoro e forme di vita ha conseguenze enormi, che toccano in particolare il modo in cui si lavora: poiché quando tu sei nella tua casa e lì lavori in maniera autonoma, tu giochi il tuo lavoro nell’ambito di una cooperazione astratta, che è profondamente diversa dalla contiguità fisica che vigeva nella fabbrica. Sulla contiguità fisica il padrone poteva esercitare disciplina, sulla cooperazione astratta può al massimo esercitare controllo. E ciò perché ormai non si lavora più su indicazioni precise e determinazioni seriali, ma piuttosto dentro un certo ambito di libertà, una costituenza di vita e di lavoro, un dispositivo di progettualità autonoma, per così dire, collocata e riparata dall’abitazione stessa. Naturalmente quando si riesca a fare della casa un riparo – sottolineo questo solo per dirne la difficoltà.
Rileggendo alcuni segmenti della riflessione foucaultiana, Gilles Deleuze ha proposto un paradigma particolarmente fortunato di lettura dei processi che ridislocano lungo l’intera filiera sociale elementi che prima erano propri solo a luoghi, momenti e istituzioni specifiche. Un paradigma sintetizzabile – come tu dicevi or ora – sotto l’etichetta del passaggio dalla disciplina al controllo: quanto, a tuo avviso, esso è in grado di descrivere e restituire gli elementi che abbiamo mobilitato parlando di fabbrica/metropoli e del “divenire posto di lavoro” dell’abitazione?
Questa giustapposizione disciplina/controllo è stata una chiave di lettura utile ed importante. È però in qualche modo superata a fronte delle forme di sfruttamento che hanno ormai invaso il biopolitico. Le cosiddette funzioni di controllo anticipavano la figura biopolitica del lavoro: da questo punto di vista, oggi, si può parlare di un controllo “bio-politico” in cui l’accento gioca sul bios, e quindi su una serie di determinazioni molto più ampie di quelle del puro controllo. Qui è molto difficile fare distinzioni nette, definitive, perché è chiaro che sia gli strumenti macchinici, di cui la vita si attornia, sia le strutture del Welfare e le condizioni monetarie, sono intrecciati in un medesimo processo. Perciò è difficile ridurli direttamente, senza mediazioni, alla distinzione fra disciplina industriale e controllo biopolitico. Ciò premesso, va aggiunto che questa tendenza – sviluppatasi in maniera progressiva ed ora attuale – mentre si rivela paradigma nell’esercizio delle attività domestiche, si mostra in forme ben più complesse – ed ovunque – quando la valorizzazione post-fordista si coniuga alla dimensione biopolitica. La forma più esplicita di questa “speciale” forma di controllo la possiamo descrivere nelle fasi di crisi quando al lavoratore sono imposte, ad un tempo, forme di lavoro precarizzato e condizioni di miseria salariale – in un’atmosfera di paura ed insicurezza. Vita e sopravvivenza son qui messe in relazione. E l’abitazione può, da luogo e strumento di lavoro, divenire luogo del debito, dello sfruttamento finanziario più esoso e mortifero. Il biopolitico, da ambito di espansione del desiderio e di nuove pratiche di produzione, diviene prigione e forza distruttiva del vivere. Non sarà inutile qui ricordare che le teoriche e militanti femministe, un tempo raccolte attorno all’obbiettivo del salario al lavoro domestico, avevano inteso e descritto, con molto anticipo, questa ambiguità del biopolitico, che poteva diventare distruttiva. Molto prima che il biopolitico fosse divenuto la chiave centrale del lavoro produttivo sociale, queste donne hanno percepito nella struttura patriarcale del salario operaio e nella schiavitù del lavoro domestico (in quella iniqua composizione della struttura del salario fordista e della sua convivenza con la vita familiare) la complessità del controllo del biopolitico. Pretesero allora, con le lotte, che la distribuzione salariale fosse riorganizzata sull’intero ambito sociale, dove il lavoro della donna diventava essenziale e doveva essere riconosciuto come tale. Salario e diritti non solo per garantire la sopravvivenza ma l’emancipazione in una società dove tutto era legato al profitto. Vi riuscirono? Non è questo il punto. L’esempio serviva solo a mostrare quanto nel post-fordismo, nell’età neoliberale, le condizioni dello sfruttamento e del controllo biopolitico siano divenute complesse e quanto l’antagonismo sia divenuto profondo.
 Proviamo allora a declinare due elementi chiave del tuo discorso sulla metropoli su questo spostamento verso l’interno dell’abitazione di alcuni momenti che prima erano propri alla fabbrica. La questione dell’ambivalenza della realtà metropolitana contemporanea: credi che questo tema possa essere utilizzato per inscrivere nel divenire-domestico di parte del lavoro cognitivo un dispositivo che è di invidualizzazione e di sfruttamento da una parte, ma anche di singolarizzazione e autonomia dall’altra? E penso poi alla questione della riappropriazione di capitale fisso da parte dei lavoratori metropolitani: come svilupperesti questa tematica fin dentro i momenti di produzione che avvengono all’interno della casa?
Proviamo allora a declinare due elementi chiave del tuo discorso sulla metropoli su questo spostamento verso l’interno dell’abitazione di alcuni momenti che prima erano propri alla fabbrica. La questione dell’ambivalenza della realtà metropolitana contemporanea: credi che questo tema possa essere utilizzato per inscrivere nel divenire-domestico di parte del lavoro cognitivo un dispositivo che è di invidualizzazione e di sfruttamento da una parte, ma anche di singolarizzazione e autonomia dall’altra? E penso poi alla questione della riappropriazione di capitale fisso da parte dei lavoratori metropolitani: come svilupperesti questa tematica fin dentro i momenti di produzione che avvengono all’interno della casa?
Dentro questa linea di ragionamento, parlare di recupero o di riappropriazione di capitale fisso da parte del lavoratore acquista senso quando, da un lato, si insiste sul fatto che nell’abitazione ci sono dei mezzi tecnologici che permettono di programmare e di partecipare ad un insieme, ad un flusso di cooperazione lavorativa, e, d’altro lato, che questi mezzi tecnologici sono stati “risistemati” fuori dalla fabbrica, a casa e così, appunto, parzialmente o totalmente riappropriati dal lavoratore. Non si tratta semplicemente delle strutture architettoniche che son divenute macchine, ma anche di una struttura macchinica dell’abitazione – da cui una serie di conseguenze. La prima riguarda il lavoro specificamente domestico, su cui torniamo subito; l’altra è la meccanizzazione della casa, che è, alla prima, strettamente connessa. Pensa a cos’era una casa – non dico cento ma cinquanta anni fa: un’abitazione in cui non esistevano macchine e tutto era organizzato dalle persone che si occupavano del lavoro domestico. Dentro un’abitazione non attrezzata meccanicamente, le donne erano costrette ad una pesante, quotidiana e ripetitiva fatica, camuffata nelle forme dell’amore e degli affetti. Ma in realtà lavoro effettivo, materiale ed immateriale, affettivo e schiavo: dal preparare il cibo ai compiti più pesanti senza qualsiasi tipo di aiuto meccanico – il bucato, per esempio – e naturalmente l’allevamento dei figli. Il contesto è oggi completamente mutato: si è trattato di un processo di liberazione della donna, di una generale trasformazione macchinica che deve perciò essere colta nel suo carattere positivo, progressivo. È un passaggio che determina una sostanziale modificazione dello spazio e del rapporto familiare: è con riferimento agli elementi macchinici che l’emancipazione della donna comincia a determinarsi – seppur evidentemente in maniera del tutto parziale finché non diviene discorso politico ed interviene nella struttura dell’affettivo, sulle soggettività. Ma è chiaro che alcune possibilità materiali di liberazione sono comunque date in questo processo, e passano attraverso una riappropriazione femminile del capitale fisso nell’abitazione. Con ciò evidentemente non si vuole celare o mistificare l’ambiguità del rapporto di capitale che apre tali spazi di liberazione, ma al tempo stesso li assoggetta al consumo. È un’ambiguità che vediamo operante lungo tutto il passaggio dal fordismo al post-fordismo, che è intrinseca alla struttura del salario, e che qui rivela la funzione specifica dell’abitazione nel processo lavorativo. E tuttavia lo spazio è de-essenzializzato e aperto alla virtualità di un rapporto che non è più semplicemente fissato dal genere, dal fatto di essere donna, di essere sottoposta esclusivamente al salario del marito, commisurato alle figure ed alle vicende della schiavitù familiare. E non è neppure uno spazio di libertà ma solo una possibilità di emancipazione.
La metropoli è anche il luogo in cui i meccanismi dell’indebitamento a fini immobiliari assumono i tratti più intensi, e in cui perciò diventano sempre più significative le lotte che insistono su tale terreno. Penso a esperienze come la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca di Barcellona – una lotta straordinaria il cui rilievo ha contribuito alla vittoria di Ada Colau nella corsa a sindaco della città. Vuoi dire ancora qualcosa su queste lotte metropolitane contro il capitale finanziario?
Così arriviamo davvero al centro del problema: al tema della soggettivazione nel nuovo rapporto di capitale, una soggettivazione che coinvolge direttamente l’abitazione quand’essa è divenuta un luogo di lavoro – il che vuol dire di sfruttamento e di possibile emancipazione. C’è una duplicità forte in questo caso, corrispondente alla doppia natura dello sfruttamento cui il capitale sottopone il lavoro domestico (fatto in casa, dall’uomo o dalla donna, dentro réseaux sociali) nella sua configurazione di lavoro produttivo, autonomo e sfruttato, alienato – genericamente post-fordista. Due sono le direzioni dello sfruttamento e dell’alienazione qui definite. Da una parte, lo sfruttamento diretto del lavoro compiuto in questa casa meccanizzata, in questa abitazione che è immersa nel capitale fisso. Dall’altra parte, i meccanismi di estrazione di valore, articolati attraverso quell’indebitamento che spesso sono costretti a subire i lavoratori cognitivi, immateriali, che pongono il loro luogo principale di attività nell’abitazione. Da un lato, il lavoratore, il valore della sua forza-lavoro, è consumato quando il capitale lo assorbe nello sfruttamento diretto; dall’altro, il capitale estrae – in maniera indiretta, finanziaria – il valore prodotto dal lavoro cooperativo – sociale, intellettuale, affettivo. E tuttavia, per recuperare il filo del nostro discorso, c’è sempre, a fungere (per il capitale) da avversario, l’accresciuta autonomia del lavoro. Su questa base, da questo punto di vista, la lotta per l’emancipazione del lavoro e la liberazione dal lavoro deve essere duplice – come sempre lo è stata e come oggi può esserlo con maggior forza, data la maggiore produttività e la relativa autonomia del lavoratore. Da una parte, lotta specifica contro lo sfruttamento e, d’altra parte, lotta generale contro l’estrattivismo capitalistico. Il quadro è – come si è detto – complicato dalle nuove figure di sfruttamento ed estrattività, poiché esse si danno sullo sfondo di un’attività comune del produrre – che vuol dire confluenza di produzione di beni e di produzione di soggettività, di valori collettivi e di singolarità produttive. Se le cose stanno così, sarà probabilmente possibile comprendere come i subordinati, gli sfruttati, i lavoratori in genere, oggi comprendano che lo sfruttamento (estrattivo) è sfruttamento del comune, cioè delle reti di cooperazione dei lavoratori socialmente produttivi. Le lotte sociali del nuovo proletariato metropolitano sembrano ormai svolgersi su questo nuovo terreno. Le lotte attuali del proletariato metropolitano sembrano averlo immediatamente colto. Da un lato, infatti, ci sono lotte sempre più importanti per imporre il riconoscimento del lavoro sociale (e tanto più per quello condotto in casa): lotte contro le imposte dirette e indirette, che toccano il salario, rivendicazioni di reddito generalizzato (che implica il riconoscimento del lavoro sociale e tanto più di quello domestico). Dall’altro lato, ci sono le lotte contro l’indebitamento, in particolare quand’esso sia legato all’acquisto dell’abitazione. Come le lotte di Barcellona, condotte da Ada Colau contro l’ipoteca, cioè contro le sanzioni che intervenivano sui debitori insolventi, fino alla perdita del capitale investito da parte di chi non riusciva a pagare interamente il debito. Lotte gigantesche, condotte in una forma diretta – un nuovo sentire metropolitano. Lì non c’è più semplicemente la difesa contro lo sfratto, ma la messa in luce degli sfruttatori “istituzionali”, della natura di classe della funzione dei giudici, degli ufficiali giudiziari, della polizia impiegata nelle operazioni di sgombero, dei banchieri, anche di quelli di primo livello. E questa lotta viene condotta in maniera generale, non più legata alla difesa di un bene specifico, ma del comune. Qui si misura la sfida del comune, fra lavoratori e capitalisti.
L’idea di metropoli rimanda anche a una specifica “forma di produzione dello spazio”, e a quest’altezza interseca il discorso sull’urbano tanto in voga in questi anni, sui processi di colonizzazione del territorio da parte di tecnologie urbane…
…A me pare che queste problematiche vengano solitamente poste in maniera errata, costruendo teoria sulla semplice evidenziazione di problemi particolari. Ma se il problema è particolare, anche la teoria quasi sempre lo è. Dunque, da una lato, nell’ideologia borghese (e nella testa della maggior parte degli architetti), la città si presenta come un grande servizio, messo a disposizione della speculazione e della rendita immobiliare. La metropoli – o la città in genere – diviene terreno di colonizzazione o di produzione di una spazialità che, attraverso i grandi lavori e le grandi dimensioni dello sfruttamento urbano, è gerarchizzata e suddivisa secondo moduli classisti. Questa operazione si incarna in primo luogo nelle figure della “gentrificazione”: si afferma attraverso continui processi di deterritorializzazione e gerarchizzazione di topoi nello/dello spazio urbano. In questo modo prende corpo, attraverso il decisivo esercizio di violenza estrattiva, quasi un’accumulazione originaria dispiegata su questi spazi. Tutto ciò è determinato dalla predilezione finanziaria per la speculazione nella metropoli.
E tuttavia parecchie cose cambiano se, in secondo luogo, osserviamo questi nuovi processi urbani non più semplicemente dal punto di vista capitalistico, ma anche dal punto di vista dei lavoratori. Credo che Henri Lefebvre avesse intuito la proposta che, negli anni ’70, i lavoratori facevano alla città: il suo discorso sul “diritto alla città” fu, sì, un discorso nettamente d’epoca fordista, e quindi oggi forse insufficiente, ma ebbe il vantaggio di mostrare quale rapporto stretto esistesse fra la macropianificazione urbana e la microsociologia degli spazi abitati. E come dal godimento della città si potesse arrivare al godimento dell’abitazione, della casa, ad un’autonoma produzione di soggettività. Salvo poi, con una seconda mossa, invertire tale rapporto, affermando la “gioia di vivere” come obiettivo che deve attraversare la città intera, la metropoli. Rispetto alle teorie della produzione di spazio – che capitalizzavano in maniera radicale l’intero spazio urbano – con Lefebvre abbiamo dunque la rivendicazione, estremamente importante, di un concetto troppo spesso dimenticato: quello di una città che è innanzitutto collettività umana, luogo di incontro, di sapere, di piacere. Sempre mutante, certo, ed anche incompiuta – ma questo riconoscimento della complessità umana della città era proiettato dalla gioia del foyer, dell’abitazione, a quella dell’insieme urbano. Soprattutto per quell’enorme strato di nuovo proletariato metropolitano (soprattutto, ma non solo, immigrato) che non aveva mai goduto di spazi modernamente meccanizzati e civilmente attrezzati. A questo proposito vorrei ricordare un libretto magnifico, che ho letto recentemente: L’imaginaire de la Commune di Kristin Ross, dove, oltre a documentare come i settantadue giorni della Comune siano stati un evento il cui racconto, nel secolo successivo, valse a determinare nuove conoscenze e creazioni nell’arte, nell’educazione e nella letteratura – bene, oltre a ciò, esso documenta una straordinaria esperienza nel rispecchiarsi e nel moltiplicarsi continui dell’azione rivoluzionaria sulle forme di vita dei suoi attori. Immaginazione e felicità determinano una “redistribuzione del sensibile” (à la Rancière) che può essere descritta nella sua abbondanza e creatività come un “lusso rivoluzionario” della/nella città. Credo che quando si parla di produzione dello spazio urbano dal punto di vista dei subordinati, dei lavoratori in generale, si debba riprendere con forza l’idea di una programmazione moltitudinaria, cioè di una capacità di tenere insieme bisogni della moltitudine e gioie della singolarità, ed organizzare la città al servizio di una loro sintesi. Sono anche convinto che una tale rivendicazione stia, in qualche maniera, affermandosi. E che le istanze del potere siano costrette – sempre di più e sempre più fragilmente – alla mistificazione ideologica ed alla programmazione repressiva a fronte della pressione/desiderio dei governati di vedere soluzioni collettive e felici dei problemi della città. Quando vita e lavoro si sovrappongono, il problema della città/metropoli si presenta come quello della sovrapposizione di ecologia e produzione. E qui sta il problema centrale della spazialità urbana: hic rhodus, hic salta.
Veniamo ora a un dispositivo discorsivo centrale nel modo in cui la contemporanea invenzione e produzione di spazio metropolitano viene narrata: la nozione  di smart city nel suo doppio versante di formazione ideologica volta a descrivere l’immagine di città delle classi agiate, ma anche di vettore materiale di enormi investimenti che ridisegnano secondo questa logica il volto delle città come enormi cantieri capitalisti.
di smart city nel suo doppio versante di formazione ideologica volta a descrivere l’immagine di città delle classi agiate, ma anche di vettore materiale di enormi investimenti che ridisegnano secondo questa logica il volto delle città come enormi cantieri capitalisti.
Quando si cominciò a parlare di smart city, si intendeva una città completamente attraversata da sistemi, prima cibernetici poi informatici, che dovevano in qualche modo riorganizzarla interamente. Dietro a questa definizione di spazio urbano smart, intelligente, furbo, ci sono due elementi narrativi fortemente ideologici. Si tratta di vecchi assunti positivisti, di un positivismo ottocentesco, meccanicista e padronale, sulla cui base si ritiene, in primo luogo, che la città possa essere conosciuta dall’alto e posseduta intensivamente, in modo totale, e, in secondo luogo, che ogni relazione urbana possa essere organizzata attraverso mezzi razionali o informatico-cibernetici. Narrazione puramente ideologica. Di fatto, l’elemento narrativo, la smart city, è, per ben che vada, commerciale quando non sia speculativo: si cerca, con l’imbroglio, di vendere un prodotto ad un prezzo più alto di quanto meriti. Quell’intelligenza che tutto percorre e avvinghia – che la pubblicità presenta – non è altro, in realtà, che controllo – controllo sul lavoro che si sviluppa nella città, necessario allo sfruttamento sociale, e controllo attraverso la violenza necessaria a garantire un processo ordinato. La smart city, la smart land sono, a mio avviso, pure mistificazioni. Tuttavia, esse si confondono, in maniera antagonista, ad un processo reale, legato all’inedita centralità che i flussi comunicativi conferiscono al lavoro nella struttura della metropoli. L’aumento delle connessioni strutturali della comunicazione produce plus-valore che viene direttamente estratto dal capitale e, al tempo stesso, resistenza – e quindi possibilità di attaccare il capitale, costretto a questo alto livello di mistificazione. Una resistenza che di certo non si dà come risultato di una presa di coscienza ma come continuità di elementi di rottura quotidiani, di un’azione molecolare, legati al malessere del vivere urbano. Per conquistare una vita decente, bisogna scuotere la vita metropolitana che il capitale vorrebbe ridotta alla quiete dei paesotti di diecimila abitanti del primo Novecento, ad una quiete rinnovata dalla TV che ha sostituito il parroco nelle funzioni di guida spirituale. Perciò, la smart city ha paradossalmente bisogno di hackers urbani. E, d’altra parte, senza hackers urbani non sarebbe mai nata la possibilità di resistenza e di incontro che costituisce il piacere del vivere nella metropoli.
In posizione speculare alla retorica della smart city troviamo la rappresentazione delle periferie urbane, delle favelas, degli slums, delle banlieues – nella potenza evocativa che a questo ultimo termine è conferita dalla sua radice etimologica legata all’istituto feudale del “bando”. Nelle precedenti interviste hai voluto sottolineare il carattere produttivo di questi luoghi di lavoro/resistenza comune e il rilievo dei conflitti che vi prendono forma. Vuoi aggiungere qualcosa su questo tema alla luce della traiettoria di indagine intrapresa oggi?
Quando si parla di queste periferie non basta tenere presenti le indagini, gli studi e le opinioni sviluppati da autori importanti come, ad esempio, Mike Davis. Si tratta di ricerche che hanno puntato essenzialmente sull’estraneità dei cittadini poveri, considerando la loro pericolosità sociale come provocazione ad un sempre più approfondito controllo e, d’altro lato, come dispositivo di emancipazione in questi luoghi estraniati. Credo invece che, lungi dall’estraneazione, quei luoghi proletari e poveri rappresentino, in modo forte, una qualità comune della vita urbana e del lavoro metropolitano – qualcosa che è difficilmente cancellabile. Si fanno troppe fenomenologie dei senza-diritto o dei fuori-casta, scorgendo nelle banlieues un luogo di esclusione totale. La mia esperienza di ricercatore nelle banlieues mi ha sempre condotto ad escludere totalizzazioni e mi ha sempre mostrato, al contrario, una ricchezza di capacità lavorative e una qualità di convivenza e di cooperazione, spesso creative. Queste banlieues sono periodicamente assorbite o periodicamente respinte dalle grandi imprese capitalistiche, che le investono sia dal punto di vista del mercato del lavoro, sia dal punto di vista dei beni d’uso che vi si producono – soprattutto beni culturali, musica, forme del vivere ecc. Vediamo quindi la continua alternativa tra integrazione e bando, tra assorbimento ed esclusione, ed è importante insistere sulla centralità antagonista che assumono le banlieues fra miseria accumulata e determinazione rivoltosa. Non c’è nuda vita, qui, il ritmo biopolitico è piuttosto pieno di contraddizioni, talora antinomiche (religione/integrazione, per esempio) – la vita è, anche nella sua interiorità, piena di conflitto e pronta ad esplodere.
Il tema dell’estrattivismo che tu collochi al cuore del discorso sulla metropoli contemporanea è, nel lavoro di molti autori, strettamente legato al carattere ininterrotto e mai compiuto di ciò che Marx chiamava la «cosiddetta accumulazione originaria» descrivendo il modo in cui il capitale è «venuto al mondo grondante di sangue dalla testa ai piedi» attraverso processi di espropriazione spietati e sanguinari. Ti pare che nella metropoli contemporanea sia possibile descrivere i tratti di un’analoga violenza inerente ai processi di estrazione di valore? Qual è la violenza specifica della metropoli contemporanea nel senso soggettivo del genitivo?
Credo che l’insistenza, se non esclusiva certo predominante, sulla violenza del controllo neoliberale, abbia falsato alcune immagini della metropoli post-fordista contemporanea. E in particolare ritengo che la ricorrente analogia con l’accumulazione primitiva possa produrre grossi fraintendimenti. È infatti chiaro, da un lato, che la singolarizzazione abitativa di cui abbiamo parlato è tutta interna ai meccanismi estrattivi ed alla sussunzione della metropoli nel ciclo del capitale finanziario. È anche chiaro, tuttavia, che esistono varie risposte, varie episteme, che si oppongono con forza all’estrattivismo. È vero che nel regime della “grande fabbrica” quello che si chiamava “sussunzione reale” – unitaria e compatta imposizione del processo di valorizzazione – oggi si sfrangia e si riapre con evidenti discontinuità spaziali e ritmi temporali multipli. Tuttavia, nella metropoli del general intellect, si dovrà essere molto prudenti nel parlare di una nuova “accumulazione primitiva” o anche di nuovi episodi di “sussunzione formale”: perché se essi si danno, si danno comunque nelle metropoli del general intellect, dentro le condizioni poste da questo ultimo passaggio nella/della struttura del capitale – dopo, appunto, gli stadi dell’accumulazione primitiva in senso proprio, della cooperazione semplice e della grande industria. Se si danno fenomeni che possono ricordare l’“accumulazione primitiva” e la “sussunzione formale”, si dovrà notare che essi si danno non come fenomeni ripetitivi di quello che Marx aveva descritto centocinquant’anni fa ne Il Capitale ma come nuovi processi dei quali tutti gli ingredienti sono modificati. A me sembra soprattutto che se la metropoli del general intellect è senz’altro una realtà sulla quale la violenza capitalista interviene, tale violenza è trattenuta, condizionata, dialettizzata, dalla necessità di costruire cooperazione produttiva – traendone gli strumenti dalla forza-lavoro disseminata sul territorio. La violenza capitalista trova limiti formidabili a fronte del general intellect e dell’organizzazione del lavoro nella metropoli del general intellect. Non a caso il controllo è riorganizzato attraverso un esercizio della violenza che – agli strumenti produttivi e finanziari – integra quelli polizieschi e quelli culturali: fondamentalmente produzione di paura. Moltiplicata in tutte le forme che la paura può assumere e introiettata attraverso i media – è probabilmente questa la violenza maggiore esercitata sulla metropoli contemporanea. La paura dell’altro, dell’epidemia, dell’inquinamento ecc. Fermo restando che l’estrattivismo rappresenta non solo l’ultima forma (in senso progressivo) ma anche la più alta, di violenza – eppure ancor squilibrata nei suoi risultati se si pensa a quel che la violenza capitalista riusciva ad ottenere nelle precedenti fasi dello sviluppo. Insomma, questa violenza non deve essere confusa con vecchie narrazioni, perché, nel processo che ha condotto all’attualità, anche la forza della moltitudine diventa sempre più inquieta e pericolosa per il capitale, per l’esercizio del suo comando – e ciò soprattutto nelle metropoli.
Molti anni prima di redigere il XXIV capitolo del libro primo del Capitale sulla cosiddetta accumulazione originaria, Marx si era già interessato ai processi di espropriazione del comune naturale: scrivendo sulle leggi contro i furti di legna perpetrati dai contadini nelle terre un tempo comuni, egli rivendicava il tema dell’uso, il diritto consuetudinario delle genti. Pensi che la questione degli usi, dal punto di vista del suo rapporto con il comune, possa avere un qualche valore di attualità nel tessuto metropolitano contemporaneo segnato dai meccanismi di accumulazione estrattiva?
Credo che la formazione sociale produca, e nel medesimo tempo sia il prodotto, del processo produttivo. Il comune, dunque, accompagna lo sfruttamento estrattivo, lo produce e ne è prodotto. Ma la tua questione mi immerge in una realtà della quale assumo la conoscenza immediatamente come per un dispositivo di lotta. E allora stipulo, decido che il comune precede l’estrattivismo. Da questo punto di vista, non si dà estrattivismo se non c’è comune. La “sussunzione reale” della società nel capitale produce questo effetto, di comunalizzare il lavoro. Ma è un lavoro biopolitico, un lavoro che assume cioè tanto più valore quanto più è comune, socializzato e cooperativo. Siamo dentro ad un processo rovesciato rispetto a quello analizzato da Marx riguardo all’accumulazione primitiva e all’espropriazione del comune “naturale”. Oggi, la contraddizione dello sfruttamento capitalista si organizza nell’urgenza di espropriare il comune attraverso il pubblico, comandato dal privato – il pubblico non è più difesa o baluardo contro le privatizzazioni. Ormai la Corte suprema americana legittima l’esproprio per le necessità dello sviluppo capitalistico. Cioè il pubblico (Corte suprema) legittima l’espropriazione del comune (spazi, attività) per permettere al privato (una multinazionale, nel caso) di svilupparsi. Una volta il pubblico era suppletivo e poteva divenire sussidiario rispetto al privato: laddove non arrivava il privato – nel costruire strutture, ferrovie, aeroporti, scuole, ospedali ecc. – era il pubblico che procedeva. Oggi, queste grandi strutture di servizio – questo comune che ha integrato quello naturale – devono essere sottratte al pubblico e riprivatizzate. Il comune è più forte? Riuscirà a difendersi? A ribellarsi contro un comando diretto a privatizzare, a bloccarne lo sviluppo? Questo è oggi il terreno di lotta, già fortemente pregiudicato – ma terreno di lotta, comunque.
Chiudiamo questo nostro dialogo in tre momenti sulla metropoli con una domanda inerente alla possibilità di pensare la specificità di un “politico metropolitano”, di una specifica forma dell’agire politico dentro queste totalità “comuni” articolato sulle contemporanee forme di produzione di soggettività e di comune.
È immediatamente politico il fatto che gli architetti oggi sempre di più pensino a “muoversi in situazione”. Ci sono compagni che si occupano di architettura provando a tradurre nel loro lavoro opzioni operaiste, rilette in termini sociali (per esempio Aureli e il suo gruppo), e tendono a spingere l’architettura a posizionarsi in termini ‘ancillari’ rispetto alle necessità di liberazione, cioè ai bisogni moltitudinari e alle lotte politiche. Finora il carattere ancillare dell’architettura è sempre stato appannaggio del grande capitalismo immobiliare. Adesso, anche a livello della professione, si intende invece la necessità, non ingenua né utopica, di costruire secondo norme comuni. E con ciò si intende la possibilità di incentivare cooperazione e libertà, eguaglianza e solidarietà, e di strappare la città, nella sua pluralità singolare, all’omogeneizzazione coatta che il capitale le vuole imporre. È su questo spazio, su queste scadenze, che le lotte ecologiche, per esempio, ritornano dalla difesa della natura alla “Carta delle foreste”, alla difesa ed alla costruzione del comune metropolitano. Un procedere che propone alternative al disegno capitalista deve qui farsi antagonista. È su questo terreno che la moltitudine si organizza come figura fisica e cittadina. Io credo – secondo il buon insegnamento operaista – che le lotte precedano sempre le strutturazioni capitaliste: oggi, sul terreno metropolitano, questo rapporto non più dialettico ma antagonista diventa centrale. Le metropoli diventano terreno privilegiato della lotta di classe come lotta sociale. La metropoli è effettivamente fabbrica, ma fabbrica del general intellect. E la forza lavoro del general intellect è tanto dinamica, mobile, flessibile, e potente quanto era quella della gloriosa classe operaia. E probabilmente di più.
Per finire. Abbiamo cominciato insistendo sul fatto che, nella metropoli di oggi, macro- e micro- sono in corrispondenza dentro una relazione funzionale e, al tempo stesso, in un confronto duro. Abbiamo continuato cercando di vedere, su vari livelli, come il rapporto di dominio che il capitale esercita nel suo agire sulla metropoli, possa essere resistito, interrotto, rovesciato in forme alternative; ed anche come la subordinazione al capitale fisso possa essere invertita e la resistenza all’alienazione vincerla sulle passioni tristi. Queste considerazioni ci conducono a vedere nella città/metropoli non solo il luogo fondamentale nel quale si esercita lo sfruttamento estrattivo – ma anche lo spazio possibile di ricomposizione politica delle resistenze. La cooperazione produttiva, fortemente accentuata dalle trasformazioni tecnologiche attuali, che la metropoli promuove e impone, costituendo dunque un eccezionale spazio di sfruttamento – bene, quest’accentuazione della cooperazione produttiva apre però la possibilità di un’organizzazione antagonista e di un’alternativa radicale. Ancor più interessante tuttavia l’analisi del “tempo della metropoli”. Più di due terzi dell’umanità vive ormai in realtà metropolitane estremamente massificate: la trasformazione dell’uomo che Machiavelli descriveva, proprio a proposito della città, da “bestia” a “cittadino” si realizza in questi spazi – meglio, si è realizzata. Ora è necessario che i cittadini si scoprano come produttori del luogo che abitano. Che prendano nelle loro mani le chiavi di lettura, di costruzione e di azione della e nella città. Ma il rovesciamento della condizione di produttori sfruttati a quella di produttori creativi non è né automatica né spontanea e però neppure una via impossibile, troppo ardua da percorrere. È una via che può reggersi solo su una trasformazione radicale dell’essere-comune, del vivere in comune. Per percorrere questa via, per far sì che il percorso sia esso stesso rivoluzionario, occorre costruire forme di vita mutualistiche, sindacati del sociale, laboratori dell’incontro e dell’azione. Dove? Come? Nella metropoli, sulle strade e nelle piazze. Il municipalismo (cioè l’organizzarsi e il lottare nelle municipalità) indica il dove. È un’indicazione generica ma spesso molto utile. Quanto al come, è la storia delle lotte operaie che ci indica la maniera di muoverci, traducendo lo sciopero che “fa male al padrone” in lotta che fa male ai padroni della città. Tradurre la lotta di fabbrica e quelle politiche del socialismo di un tempo in modi di attacco al capitale estrattivo: questa è la via di un comunismo di domani. Nella città, nella metropoli. E non sarà difficile se ricorderemo, come ce lo ricorda Kristine Ross, quella previsione marxiana che già il movimento operaio rivoluzionario aveva ripreso come traccia della propria scrittura della storia – ora è a noi cittadini farla nostra: “quando il tempo di lavoro cesserà di essere la misura del lavoro e il lavoro la misura della ricchezza, la ricchezza non sarà più misurabile in termini di valore di scambio. E allo stesso modo nel quale, per Marx come per i pensatori della Comune, il vero individualismo non era possibile che sotto il comunismo, che esige e riconosce il contributo di ciascuno: ecco, allo stesso modo, il vero lusso non può che essere il lusso comunale”.
Parigi, giugno 2015
*Illustrazioni Di SANDRO MORETTI