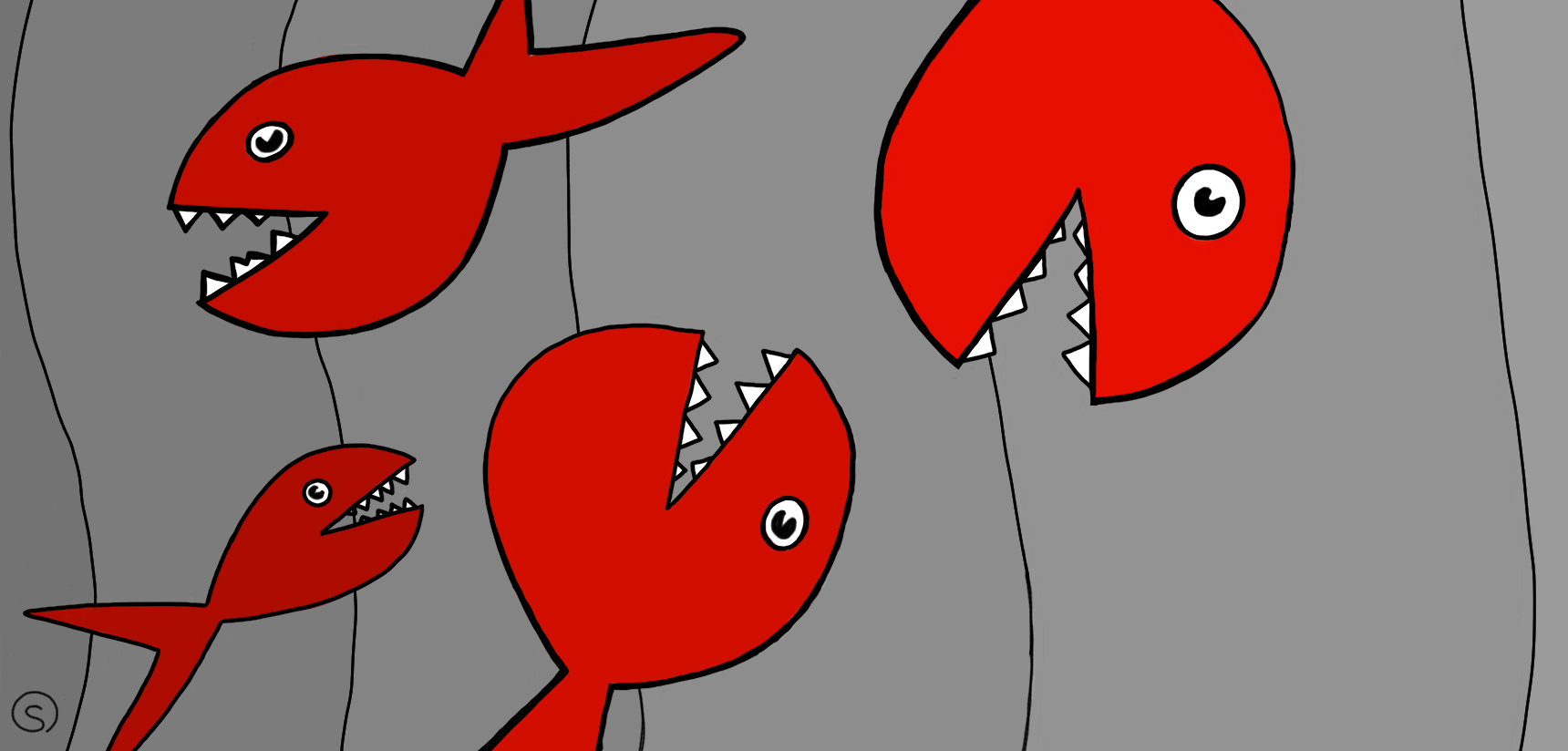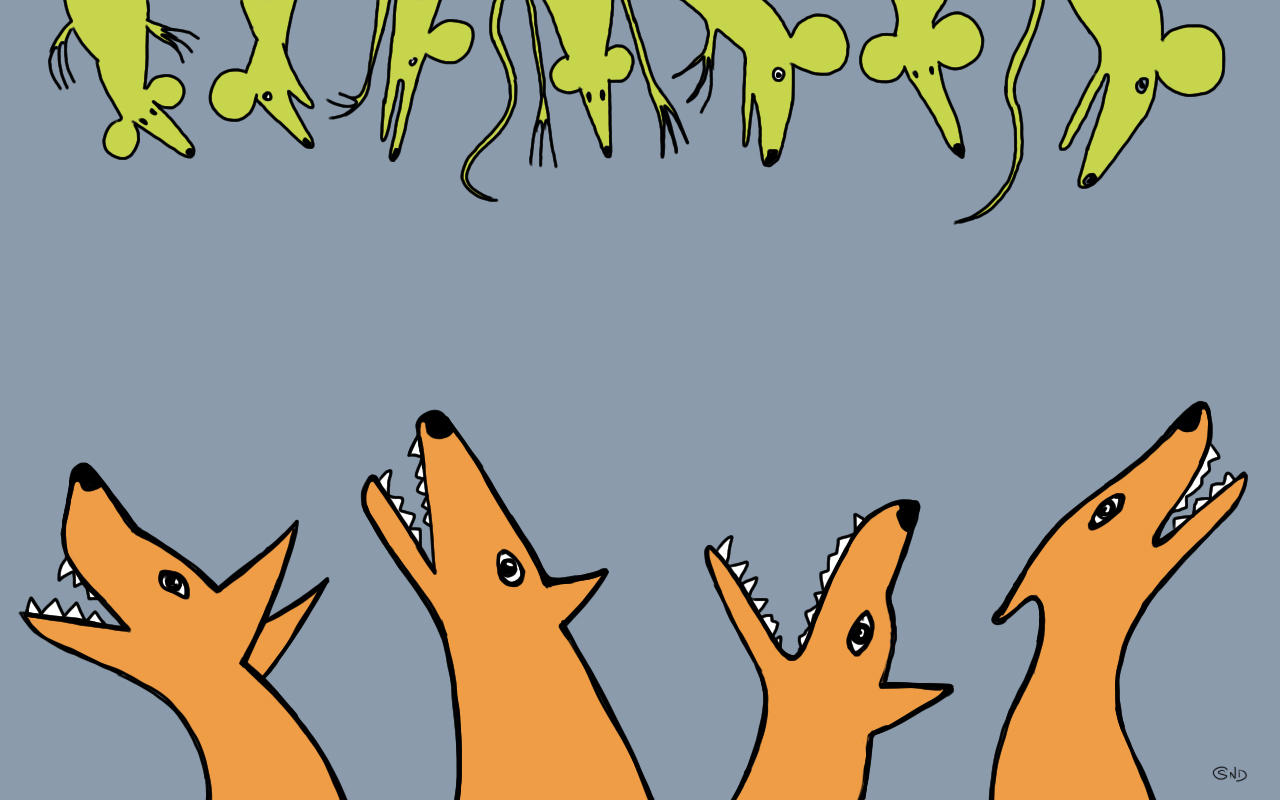di FRANCESCO RAPARELLI*.
Riduzione del salario, fisco, carità: l’agenda neoliberale del governo Renzi. Il rapporto 2015 dell’Ocsel, l’osservatorio sulla contrattazione di secondo livello della CISL, ha censito 4.100 accordi siglati tra il 2009 e il 2014. Tanti. La lezione è semplice: non è vero che con la crisi si è fermata la contrattazione; è vero che si contratta diversamente. La contrattazione di secondo livello, neanche a dirlo, ha come obiettivo principale il contenimento o la riduzione del salario. Nel 2009, infatti, la contrattazione sugli aumenti salariali ricorreva nel 53% degli accordi, nel 2014 nel 13%. La CISL, lo stesso sindacato che paga ai suoi funzionari compensi superiori ai 300 mila euro l’anno (circa 25 mila euro al mese, poco meno di 1.000 euro al giorno), si compiace per il lavoro fatto. La CISL, esperimento riuscito di sindacato neoliberale, dalla parte dei più forti.
Tra i target autunnali delle imprese, conseguentemente di Renzi, c’è proprio la contrattazione. Ridurre al minimo quella nazionale, liberandola dai contenuti redistributivi; estendere al massimo quella aziendale. Spostando interamente – salvo i minimi (?) – la contrattazione salariale sul piano aziendale, il salario si trasforma in variabile dipendente dai risultati. Di più, si scambia salario conwelfare aziendale: meno soldi ma il nido per i bimbi, tanto quello pubblico, distrutto dalla spending review, non sarà mai disponibile. Tutto torna.
E sarà proprio la spending review, di 10 miliardi quella prevista per il 2016, a favorire la nuova politica fiscale del governo: 35 miliardi di tagli nei prossimi 3 anni. Si comincerà dalla Tasi e dall’Imu agricola, si proverà a disinnescare l’aumento Iva previsto dalla clausola di salvaguardia, poi Irap (nel 2017) e Irpef (nel 2018). Mentre proseguirà, seppur lievemente ridotta, la decontribuzione (5 miliardi l’anno circa) per le imprese che accendono contratti a tutele crescenti, siano essi nuovi o semplici trasformazioni. Sembrerebbe mossa positiva, perché di certo la pressione fiscale italica è insostenibile, ma a pagarla saranno nuovamente i poveri, tanta sarà la riduzione dei servizi pubblici essenziali, in primo luogo la Sanità. Seppur non dichiarata come tale, è una mossa che rende l’imposta regressiva, in pieno stile thatcheriano. Poco o niente, inoltre, si fa per il mondo del lavoro professionale non imprenditoriale (3,5 milioni circa, tra professionisti atipici e ordinisti), quel mondo sempre più stremato da compensi bassi (il 50% circa dei freelance fattura non più di 15-18 mila euro l’anno), completa assenza di welfare, fisco e previdenza troppo onerosi (in particolare l’aliquota della gestione separata INPS).
Fermi tutti, il “ganzo” fiorentino si occuperà anche dei poveri, lo ha promesso a Caritas e Acli. Si chiama ReIS, Reddito di Inclusione Sociale, e piace a tanti, CISL e CGIL comprese. Una misura a dir poco marginale, rivolta alle famiglie che vivono in condizione di ‘povertà assoluta’, ovvero incapaci di accedere a beni primari quali la casa, l’acqua, la luce, il riscaldamento. Secondo i dati ISTAT, nel 2014 la povertà assoluta ha segnato il 5,7% delle famiglie, quella relativa il 10,3%. Va da sé che «tutti i membri della famiglia [che riceverà il ReIS] tra 18 e 65 anni ritenuti abili al lavoro devono attivarsi in tale direzione. Si tratta di cercare un lavoro, dare disponibilità a iniziare un’occupazione offerta dai Centri per l’impiego e a frequentare attività di formazione o riqualificazione professionale». Dunque: misura caritatevole, familiare, fortemente condizionata. Non solo welfare to work, ma workfare caritatevole.
 Quanto costa il ReIS? A regime, cioè solo a partire dal quarto e ultimo anno di transizione, il ReIS costa 6 miliardi di euro l’anno, lo 0,34% del PIL. Sappiamo che l’ISTAT reputa necessari 14 miliardi l’anno, per la proposta di Reddito Minimo Garantito del M5S, e 19 miliardi l’anno, per quella depositata da SEL. Quando parliamo di ReIS, parliamo di briciole, utili a tenere a freno il disastro e a sostenere la gabbia familiare italica, l’unico welfare che c’è per milioni di giovani disoccupati e precari. D’altronde Cameron, riferimento renziano tra i più importanti, sta per sostituire i sussidi di disoccupazione con «work boot camp», campi di addestramento obbligatori al lavoro. Gli echi nefasti delle parole, si sa, non spaventano neanche un po’ i vampiri neoliberali. Il sangue dei giovani disoccupati è così eccitante, no?
Quanto costa il ReIS? A regime, cioè solo a partire dal quarto e ultimo anno di transizione, il ReIS costa 6 miliardi di euro l’anno, lo 0,34% del PIL. Sappiamo che l’ISTAT reputa necessari 14 miliardi l’anno, per la proposta di Reddito Minimo Garantito del M5S, e 19 miliardi l’anno, per quella depositata da SEL. Quando parliamo di ReIS, parliamo di briciole, utili a tenere a freno il disastro e a sostenere la gabbia familiare italica, l’unico welfare che c’è per milioni di giovani disoccupati e precari. D’altronde Cameron, riferimento renziano tra i più importanti, sta per sostituire i sussidi di disoccupazione con «work boot camp», campi di addestramento obbligatori al lavoro. Gli echi nefasti delle parole, si sa, non spaventano neanche un po’ i vampiri neoliberali. Il sangue dei giovani disoccupati è così eccitante, no?
Questa è l’agenda, questa la merda che ci toccherà in sorte nei prossimi mesi. Vale la pena, senza girarci attorno, farsi le domande che contano. Saremo in grado di costruire una mobilitazione moltitudinaria capace di connettere lavoro precario e disoccupati, lavoro autonomo e stabile, cattolicesimo di base e sindacati conflittuali, ma soprattutto di pretendere reddito di base (incondizionato, rivolto ai singoli, per tutti, ecc.) e welfare universale? Saremo capaci di inventare e/o consolidare nuovi dispositivi sindacali in grado di organizzare (quotidianamente) i non organizzati (partite Iva, precari, lavoro migrante, ecc.)? Sapremo estendere sul piano europeo il conflitto anti-austerity e per l’uguaglianza (salario minimo europeo, imposta progressiva, tassazione delle rendite finanziarie, tetto ai compensi di manager privati e pubblici, ecc.)? Queste a me paiono le domande alle quali movimenti e coalizioni che non si rassegnano alla marginalità dovrebbero rispondere. O almeno provarci.
*pubblicato su DinamoPress