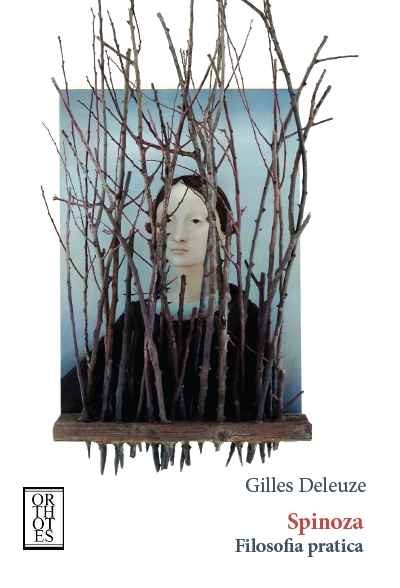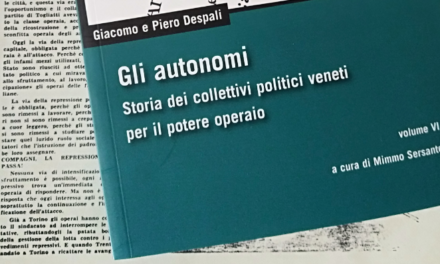di GISO AMENDOLA.
Nelle Conversazioni con Claire Parnet, Gilles Deleuze parla di Spinoza come una “corrente d’aria che vi soffia sulla schiena” o come una scopa di strega su cui saltare. I suoi incontri con Spinoza segnano tutte le fasi della sua opera: quella delle prime monografie, attraverso cui Deleuze fa i conti con la storia della filosofia, con Spinoza e la filosofia dell’espressione preparato già negli anni Cinquanta, e pubblicato poi solo nel ’68 (edito in Italia da Quodlibet), ma anche quella degli anni Ottanta, per esempio con il corso universitario dell’80-81 (Cosa può un corpo?, ombre corte).
Torna ora in libreria Spinoza. Filosofia pratica, grazie a Orthotes, che rende nuovamente disponibile l’edizione italiana, con traduzione e postfazione di Marco Senaldi (pp. 135, euro 17). In Francia, il volume uscì nel 1981, riprendendo due testi deleuziani su Spinoza del decennio precedente. Come nota Senaldi, si tratta di un lavoro di composizione e di ricombinazione di concetti spinoziani, e, allo stesso tempo, di invenzione di nuovi concatenamenti che si spingono là del pensiero spinoziano, per connettersi direttamente al lavoro teorico (e politico) di Deleuze.
Una filosofia pratica, leggiamo nel titolo: un’etica, molto lontana da una morale normativa e percorsa tutta da una sfida intensamente politica. Lo spinozismo, dice subito Deleuze, è infatti uno scandalo: ed è scandaloso perché mette in azione una macchina ontologica, una concezione dell’essere, che fa letteralmente esplodere tre grandi superstizioni, tre meccanismi mortiferi che avviliscono le nostre vite e le privano di autonomia, consegnandole docili all’obbedienza. La “tripla denuncia” – che accosta, nella lettura deleuziana, Spinoza a Nietzsche – mira a colpire le mistificazioni della coscienza, dei valori, e delle passioni tristi. Spinoza è anzitutto materialista: la centralità della coscienza è rotta dalla materialità dei corpi, o meglio dalla impossibilità di conoscere e limitare a priori la potenza dei corpi, di fissarne “trascendentalmente” le condizioni di possibilità. Nessuno sa cosa può un corpo, ripete Deleuze dall’Ethica di Spinoza: di qui, la rottura con ogni morale intesa come precettistica dei valori, per dirigersi verso una fisica degli incontri, verso la capacità di cercare quelle combinazioni che accrescono la nostra potenza e di evitare quelle che la deprimono. Una capacità compositiva che si svolge su un piano tutto affermativo, positivo: non si tratta di colmare vuoti o mancanze, come pretenderebbe la dialettica, che fa della negazione il motore della nostra determinazione, ma di sperimentare quegli incontri che accrescono il nostro potenziale e che producono gioia, evitando di marcire nella meditazione della nostra impotenza. È un’arte combinatoria molto strategica e dinamica, nulla di più distante da un ottimismo pacificato, o da quel senso di immobilità, di imperturbabilità orientale e quasi disumana che Hegel imputava a Spinoza.
Lo spinoziano rifiuto della negazione, chiarisce Deleuze, non ha nulla a che fare con l’opposizione tra ottimisti e pessimisti: è invece il rifiuto dell’idea che la negazione sia costitutiva di noi stessi. Certo che esiste il dolore, certo che esiste la morte: ma il male ci capita dal di fuori, ci affetta come una disavventura, un errore, un ostacolo, ma mai come un limite intrinseco, un nucleo costitutivo, o addirittura il motore della costruzione della nostra soggettività. Il male è sempre esterno, come esterni sono tutti i rapporti: lo Spinoza di Deleuze, oltre che “immoralista” accanto a Nietzsche, è anche un formidabile empirista, non lontano da Hume, non a caso altro “eroe” di Deleuze. E, per un empirista, il mondo non è fatto di colpa e di coscienza, di mancanze costitutive e di determinazioni attraverso la negazione: è fatto di contatti, rapporti, movimenti e connessioni, composizioni e decomposizioni. È questa specifica dimensione di gioia e di innocenza che è sempre andata di traverso a tutti i difensori delle tradizioni autoritarie e trascendenti del Politico, pronti, dai versanti più diversi, a ironizzare sulla denuncia spinozista delle passioni tristi, a scambiarla con una rimozione della durezza dello scontro politico. Uscire dalla trappola del negativo non è aggirare l’antagonismo, ignorare la ferocia di un mondo che “si è diviso in due”: significa, al contrario, sapere che le lotte non si radicano (almeno, non si radicano solo e sempre) nelle ferite del disconoscimento, e nei livori dei risentimenti, ma nella forza della scoperta della propria autonomia – anche e proprio quando è più sfruttata – e nella capacità di vivere potenziandola, sperimentandone le connessioni più felici.
Non è difficile riconoscere in questo Spinoza pratico l’andamento specificamente “macchinico” del pensiero deleuziano quale si andava elaborando tra Anti-Edipo e Millepiani. È l’etica della costruzione di linee, di rapporti e di combinazioni sul piano di immanenza: un piano dove non esiste alcuna trascendenza, alcuna direzione predeterminata che diriga i soggetti e le loro formazioni. L’essere – a differenza delle molte “ontologie” che ne fanno un fondamento trascendente, più o meno nascosto – si esprime tutto univocamente in ognuno dei suoi modi. Tutto quel che esiste è produzione/prodotto dell’essere allo stesso modo: il mondo non è un’immaginetta che si limiti a riflettere la luce pallida emanata da un’Origine distante e padrona. Al contrario, l’essere è qui una macchina ontologica che sovverte qualsiasi pretesa di fondare gerarchie indiscutibili, per riaprire continuamente un campo di concatenamenti e di connessioni tra singolarità.
L’ontologia dello spinozismo sta precisamente in questo doppio movimento: rifiuto di muoversi su un piano già finalisticamente orientato, e, contemporaneamente, capacità di leggere nel movimento delle singolarità non una debole danza nel vuoto, ma un conatus trasformativo, che, mentre ci attraversa, allo stesso tempo modifica e produce anche tutto l’essere in cui viviamo, l’unica sostanza di cui siamo fatti ma di cui siamo anche continui produttori. Altro che cattiva metafisica, come continuamente borbottano, al solo sentire parlare di ontologia, i custodi delle varie versioni mistiche o deboli della differenza: è, anzi, proprio questa ontologia che permette di confrontarsi con le dinamiche del capitalismo contemporaneo sul suo stesso piano. Questa concezione dell’essere come produzione immanente è infatti il solo terreno che permetta di comprendere a pieno un capitalismo dei flussi, che opera attraverso la connessione di dispositivi estremamente eterogenei, e che, allo stesso tempo, sa mettere a valore le differenze, ma anche utilizzare modalità estremamente dure, autoritarie e violente di espropriazione.
Deleuze e Guattari attraversarono tutti gli anni Settanta cercando appunto di costruire macchine da guerra all’altezza di questa nuova intensità biopolitica della produzione, macchine per connettere e potenziare le soggettività sociali che avevano fatto irruzione nelle città fin dagli anni Sessanta, per poi esplodere nel Sessantotto. Spinoza si è così felicemente incontrato con il Marx che leggeva il capitale come un rapporto sociale di continua trasformazione e, insieme, come una serie di dispositivi distesi ormai pienamente sull’intero campo sociale e innestati sul lavoro vivo, per captarne l’energia e succhiarne la potenza. Questo Marx/Spinoza forniva loro, e continua a fornire a noi, gli strumenti per collocarci su un piano intensamente materialistico e, al tempo stesso, attraversato e costituito da lotte, controcondotte e processi di soggettivazione, produttivi e capaci di fuggir via continuamente dalle mille trappole del negativo.
questo testo è stato pubblicato sul manifesto il 3 maggio 2017