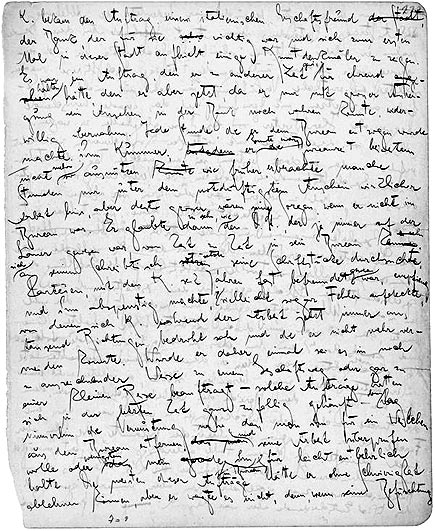1. Un terremoto spaziale
La crisi che si è aperta nel 2007/2008 non è una crisi ciclica, congiunturale. Al di là delle sue manifestazioni più eclatanti (dalla crisi finanziaria negli Stati Uniti alla crisi del “debito sovrano” in Europa al rallentamento della “crescita” nei Paesi “emergenti”), sono gli assetti complessivi – globali – del capitalismo contemporaneo a essere investiti da un’instabilità di fondo. Secondo modalità che in qualche modo erano state anticipate nei dibattiti sulla crisi dei primi anni Settanta attraverso formule come “crisi del management della crisi” (Claus Offe) e “Stato-crisi” (Toni Negri), la crisi sembra oggi rappresentare l’orizzonte stesso dello “sviluppo” – nonché di un processo di profonda riorganizzazione del capitalismo.
Questa riorganizzazione ha effetti estremamente rilevanti sotto il profilo degli spazi al cui interno si determinano l’accumulazione e la valorizzazione del capitale, riguarda cioè il sistema-mondo costruito da quest’ultimo. Le coordinate geografiche della crisi e dello sviluppo del capitalismo sono oggi esse stesse in movimento: antiche gerarchie spaziali (tradizionalmente descritte e cartografate nei termini di un insieme di rapporti tra centro e periferia) sono messe in discussione, le geografie dello sviluppo sono sconvolte per via dell’emergere di nuovi poli apparentemente trainanti (l’asse BRIC, per fare un solo esempio), nuovi regionalismi e nuovi modelli di multilateralismo stanno contraddittoriamente profilandosi (ad esempio in America Latina).
Anche sotto il profilo delle lotte, stiamo cominciando a fare esperienza delle conseguenze di questi processi. Mentre nell’Europa meridionale un insieme di movimenti si sviluppano dentro e contro la crisi (resistendo alla violenza del suo impatto sociale), negli scorsi mesi sono stati la Turchia e il Brasile a proporci formidabili lotte che, dall’interno dello “sviluppo”, sono state capaci di contestarne radicalmente la direzione, ponendo il problema della sua “qualità”. Quali tra queste lotte – e quali tra le condizioni in cui si sono determinate – sono le “più avanzate”? E’ una domanda che, se da una parte mostra la radicalità delle trasformazioni che si sono determinate in questi anni, costringe dall’altra a ripensare un insieme di paradigmi e di concetti attraverso cui tanto l’analisi critica del capitalismo quanto la politica rivoluzionaria si sono storicamente articolate.
Più in generale, porre al centro della riflessione il vero e proprio terremoto spaziale che all’interno della crisi sta rimodellando il capitalismo consente di guadagnare un nuovo punto di vista su un insieme di temi che hanno orientato il dibattito sulle trasformazioni del capitalismo negli ultimi decenni – dal capitalismo cognitivo alla finanziarizzazione. Un regime differenziale di accumulazione sembra affermarsi tanto a livello globale quanto all’interno di singoli spazi formalmente unitari, ri-combinando figure del lavoro, modalità della produzione e gerarchie territoriali. Valorizzando anche il contributo di alcuni geografi economici, vorrei qui, conseguentemente, concentrarmi sul rapporto che il capitalismo contemporaneo, in quanto capitalismo globale, intrattiene con la “differenza” e con l’“eterogeneità”. E’ necessario infatti andare oltre l’immagine – a lungo prevalente nel dibattito sulla globalizzazione – dello spazio globale come spazio “liscio”, come spazio di “flussi”, lavorando all’identificazione delle specifiche linee di antagonismo che segnano i processi di produzione dello spazio globale stesso – di uno spazio che proprio in quanto globale si presenta come profondamente eterogeneo.
2. Frontiere del capitale
La cornice analitica al cui interno si collocano queste riflessioni è stata definita nel lavoro che ho fatto in questi anni con Brett Neilson, confluito in un libro appena pubblicato (Border as Method, or, the Multiplication of Labor, Durham, NC, Duke University Press, 2013). Assumendo come punto di partenza il concetto marxiano di “mercato mondiale”, abbiamo cercato di mostrare come fin dalle origini del modo di produzione capitalistico l’espansione delle “frontiere del capitale” si sia necessariamente iscritta in uno spazio globale. Al tempo stesso, questo spazio globale è stato organizzato storicamente in molti modi, tutti caratterizzabili a partire da una specifica modalità di articolazione tra le frontiere espansive del capitale e una molteplicità di linee di demarcazione territoriale, attorno a cui si è venuta svolgendo la storia degli Stati e degli Imperi.
All’interno di questo schema interpretativo, qui riassunto in modo brutale, assumono il proprio significato i cicli egemonici analizzati dai teorici della “world system theory” (e in particolare da Giovanni Arrighi), le problematiche analizzate nei grandi dibattiti di inizio Novecento sull’imperialismo, ma anche – per venire ad anni a noi più vicini – i diversi modelli interpretativi della (nuova) divisione internazionale del lavoro e dei rapporti tra centro e periferia, le teorie dei “tre mondi” e categorie come “Nord” e “Sud globale”. E’ questa intera nomenclatura spaziale che deve oggi essere messa alla prova a fronte del terremoto geografico che si è stenograficamente indicato.
Dal lavoro di Arrighi, ad esempio, possiamo certamente riprendere la tesi di una crisi dell’egemonia americana (non senza sottolineare la preveggenza con cui lo stesso Arrighi formulò questa tesi fin dall’inizio degli anni Novanta). La dipendenza crescente della posizione di centro finanziario degli Stati Uniti da finanziamenti provenienti dall’esterno dell’Occidente è stata del resto resa ancora una volta evidente in questi giorni, dal monito rivolto a Obama del governo cinese a “garantire gli investimenti” di fronte alla prospettiva di un default. E lo sviluppo della crisi siriana ha mostrato le grandi difficoltà che gli Stati Uniti incontrano nella proiezione della propria potenza su un’area strategica come quella medio-orientale.
Al tempo stesso, risulta difficile pensare che quella che stiamo vivendo sia una “transizione egemonica” analoga a quelle descritte da Arrighi nella sua ricostruzione dei “cicli” che hanno scandito la storia del sistema-mondo capitalistico (da Genova all’Olanda, dall’Olanda all’Inghilterra, dall’Inghilterra agli Stati Uniti). L’ipotesi che conviene avanzare è piuttosto che oggi stiamo vivendo una trasformazione fondamentale nel rapporto tra capitalismo e “territorialismo” (termine chiave nel lavoro di Arrighi). E questo non perché la rilevanza del “territorio” tenda a diminuire per il capitalismo contemporaneo, ma piuttosto perché il significato stesso della nozione di territorio sta cambiando profondamente, in termini politici e giuridici non meno che economici. Il problema fondamentale consiste nel rendere conto di questa nuova rilevanza del “territorio” evitando quella che il geografo John A. Agnew definiva già nel 1994 la “trappola territoriale” – ovvero senza assumere come scontata la definizione di territorio che emerge dalla lunga storia dello Stato territoriale moderno e senza assumere come già costituite le diverse “scale” territoriali e come stabili i confini della “territorialità”.2
Ciò che contribuisce a complicare il rapporto tra capitalismo contemporaneo e “territorialismo” – nonché a rendere improbabile una transizione lineare dal “secolo americano” al “secolo asiatico”, o comunque l’emergere di un nuovo sistema egemonico organizzato attorno a un singolo centro – è un doppio processo: da una parte aspetti cruciali della sovranità tendono ad assumere sempre più una natura non territoriale3, mentre dall’altra singoli territori nazionali sono per così dire moltiplicati dal loro interno, nel senso che vengono “spacchettati” tanto dal punto di vista economico quanto dal punto di vista giuridico, attraverso l’azione di una pluralità di ordinamenti e sono fatti oggetto di modalità di sfruttamento e valorizzazione profondamente eterogenee4. Mi sembrano processi di grande rilievo per la comprensione delle geografie della crisi e dello sviluppo del capitalismo contemporaneo.
3. Varieties of capitalism
Facevo in precedenza riferimento al problema del rapporto tra il capitalismo globale contemporaneo e la “differenza”. Si tratta di un problema attorno a cui si è sviluppato negli ultimi anni un dibattito molto intenso che ha coinvolto studiosi postcoloniali (si veda da ultimo il polemico lavoro di V. Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, London, Verso, 2013) ed economiste femministe (si pensi in particolare ai lavori di J.K. Gibson-Graham), fino a mettere in discussione la stessa possibilità di una definizione unitaria del concetto di capitale5.
Più interno al dibattito mainstream è lo sviluppo di un insieme di analisi comparative, di impostazione neo-istituzionalista, delle cosiddette “varietà di capitalismo”. Vale la pena soffermarsi brevemente su questi sviluppi teorici, considerata la grande influenza che esercitano sui tentativi di descrivere le geografie del capitalismo contemporaneo. Partendo dalla distinzione formulata nel 1993 da Michael Albert tra un capitalismo “anglosassone” e un capitalismo “renano”, le analisi che si richiamano alla formula delle “varietà di capitalismo” hanno infatti proposto modelli molto influenti per censire “complementarietà istituzionali capaci di promuovere prestazioni economiche efficienti dal punto di vista di imprese rappresentative e/o economie nazionali”6.
Negli anni Novanta, in un clima caratterizzato dalla tesi di una “convergenza globale”, lo sviluppo di questi studi ha comunque svolto un ruolo importante nel promuovere una sensibilità per l’esistenza di modelli alternativi e per il ruolo svolto dai diversi contesti storici e geografici. Al tempo stesso, concentrandosi in particolare sulla dimensione dell’impresa nell’analisi dei processi economici, la letteratura sulle “varietà di capitalismo” (ad esempio nell’influente versione proposta da Peter A. Hall and David Soskice7 tende ad assumere come unità analitica e come riferimento per la comparazione l’economia nazionale.
All’interno della stessa letteratura neo-istituzionalista, è stato notato a questo proposito che “la posizione dello Stato nazione come criterio di definizione dei confini dei diversi casi analitici non è affatto così fissa e non dovrebbe essere assunta come scontata per definitionem”8. A ciò si dovrebbe aggiungere che una concentrazione sulle varietà nazionali conduce a sottovalutare i “caratteri comuni” del capitalismo contemporaneo, che devono essere al contrario posti in rilievo per comprendere il significato stesso della “differenza” per il capitalismo9. E si può avanzare l’ipotesi che la crisi intensifichi la rilevanza di questi caratteri comuni anche se le sue geografie sono profondamente eterogenee: che proprio il rapporto tra caratteri comuni del capitalismo contemporaneo ed eterogeneità delle geografie della sua crisi e del suo sviluppo debba essere assunto come oggetto privilegiato di indagine.
4. Oltre il “nazionalismo metodologico”
Da questo punto di vista, ovviamente, i processi di finanziarizzazione giocano un ruolo fondamentale. Recenti ricerche sulla “geografia della finanza” hanno ulteriormente messo in discussione il “nazionalismo metodologico” che implicitamente domina il dibattito sulle “varietà di capitalismo”. Lavorando in particolare sul caso tedesco, G.L. Clark and D. Wójcic10 hanno messo ad esempio in evidenza come la “governance” delle grandi imprese si sia progressivamente adeguata agli standard globali (ovvero si sia avvicinata al modello “azionario” solitamente collegato al capitalismo anglosassone) nella misura in cui quelle imprese si sono sempre più orientate alla ricerca di capitali sui mercati globali. Ma Clark e Wójcic hanno anche mostrato l’esistenza di una molteplicità di modelli di “corporate governance” in Germania, differenziati essenzialmente lungo linee “regionali” (per via del fatto che alcuni Länder incentivano lo sviluppo di regimi di “governance” maggiormente in linea con gli imperativi dei mercati finanziari globali).
L’unità del modello tedesco di capitalismo (il paradigma di quella che viene spesso definita “economia coordinata di mercato”) è così messa in discussione tanto dal basso quanto dall’alto. Al tempo stesso un altro “caso” di capitalismo di cui sono state enfatizzate negli ultimi anni le “caratteristiche peculiari” – quello cinese – si presenta in tutt’altra luce nel momento in cui lo si consideri dal punto di vista delle dinamiche di finanziarizzazione, e in particolare del “rapporto economico simbiotico” tra Cina e Stati Uniti: le politiche macroeconomiche, fiscali e monetarie statunitensi appaiono come variabili interne allo sviluppo cinese – e ovviamente viceversa11. Emerge così chiaramente il rischio, nelle parole del geografo A.D. Dixon, di “enfatizzare l’esistenza di diversi modelli di capitalismo quando in realtà c’è un unico capitalismo, anche se evidentemente si tratta di un capitalismo variegato”12.
5. “Capitalismo variegato”
 Dal punto di vista dell’esigenza di comprendere i “caratteri comuni” del capitalismo contemporaneo, per poter meglio definire la natura del rapporto che intrattiene con il territorio e con la “differenza” (e dunque per guadagnare un punto di vista più efficace sulla tumultuosa ridefinizione delle sue geografie), il concetto di “capitalismo variegato” risulta in effetti molto utile.
Dal punto di vista dell’esigenza di comprendere i “caratteri comuni” del capitalismo contemporaneo, per poter meglio definire la natura del rapporto che intrattiene con il territorio e con la “differenza” (e dunque per guadagnare un punto di vista più efficace sulla tumultuosa ridefinizione delle sue geografie), il concetto di “capitalismo variegato” risulta in effetti molto utile.
La sua formulazione originaria si deve a due geografi, Jamie Peck e Nick Theodore13. Quel che mi sembra particolarmente interessante nel loro lavoro è il fatto che gli spazi e le “scale” dei processi contemporanei di accumulazione non vengono assunti come “dati”, e tanto meno come coincidenti con i confini politici o con le delimitazioni amministrative ufficiali. Anziché limitarsi a un tradizionale approccio comparativo, Peck e Theodore sottolineano l’importanza di “principi, fonti e dimensioni di differenziazione capitalistica (capitalist variegation)” che operano in modo dinamico e relazionale, trasversalmente – per così dire – rispetto ai diversi casi solitamente oggetto di comparazione. Il “polimorfismo dinamico” che ne risulta deve essere a loro giudizio analizzato combinando un’attenzione di fondo all’eterogeneità del capitalismo con un tentativo di cogliere la “produzione sistemica di differenziazione geo-istituzionale”.
In Border as Method, io e Brett Neilson abbiamo lavorato in una direzione simile, partendo da una ripresa e da una rielaborazione del concetto di “assiomatica del capitale” sviluppato da Gilles Deleuze e Felix Guattari in particolare in Mille piani. Quello che ci è parso importante in quel concetto è esattamente il fatto che consente di mantenere un concetto unitario di capitale senza per questo collegarvi un qualche argomento sulla “convergenza globale” – per dirla altrimenti, senza equiparare unità del concetto di capitale e tendenza all’omogeneizzazione di tutti i contesti sottoposti alla sua azione e al suo dominio. Deleuze e Guattari, infatti, sottolineano che all’assiomatica del capitale (a un insieme di “caratteri comuni” che si fissano in una tavola di principi) corrisponde sì un “isomorfismo”, ma non una “omogeneità”. L’assiomatica, al contrario, non solo tollera ma promuove costantemente la generazione di “eterogeneità” sociale, temporale e spaziale14.
A me pare che questo gap tra assiomatica ed eterogeneità – per continuare a usare i termini di Deleuze e Guattari (ma l’intera problematica potrebbe essere riformulata attraverso una rilettura della categoria marxiana di “sussunzione”) – sia particolarmente evidente oggi e che proprio la divaricazione tra i due piani debba essere tenuta presente per cogliere alcune trasformazioni essenziali che caratterizzano il capitalismo contemporaneo, le geografie della sua crisi e le instabili coordinate spaziali del suo sviluppo. Lo spazio globale si presenta in questa prospettiva come effetto del processo continuo e sistematico di produzione e differenziazione descritto da Peck e Theodore. E si tratta di un processo che può certamente dar luogo a nuove configurazioni regionali (attraversate da molteplici vettori di interconnessione), ma molto difficilmente alla riorganizzazione del sistema mondo capitalistico attorno a un unico centro egemonico.
6. Estrazione
Evidentemente, ancora una volta, i processi di finanziarizzazione sono qui essenziali. Da tempo abbiamo insistito sulla qualità nuova di questi processi rispetto a precedenti epoche nella storia del modo di produzione capitalistico. E abbiamo in particolare sostenuto che la stessa distinzione tra economia “reale” ed economia “finanziaria” è oggi messa radicalmente in discussione15.
Questo appare ancora più evidente laddove si considerino innovazioni finanziarie come i derivati, che disarticolano le merci e ne disperdono i disjecta membra “per impacchettarli con elementi di altre merci di interesse per un mercato orientato globalmente, su cui gli scambi avvengono secondo la logica del rischio”16. L’high frquency trading, operando con algoritmi sempre più sofisticati, stravolge d’altro canto la temporalità della valorizzazione e dell’accumulazione del capitale, producendo fenomeni come il cosiddetto “flash crash” del 6 maggio del 2010, quando il Dow Jones è crollato di circa mille punti nel giro di pochi minuti per risalire altrettanto rapidamente. È un evento di rilievo sintomatico laddove si tenga presente che oggi l’assiomatica del capitale, il suo isomorfismo e il suo codice astratto di rapporto sociale sono sempre più rappresentati sui mercati finanziari globali (e dunque sono sempre più soggetti alla “volatilità” che li caratterizza).
Al tempo stesso, è essenziale analizzare le modalità con cui il capitale finanziario “tocca terra”, sia dal punto di vista spaziale sia dal punto di vista dei cambiamenti che si producono nei rapporti tra capitale e lavoro. A me pare, ed è un altro punto su cui sto lavorando con Brett Neilson17, che si possa utilizzare a questo proposito un concetto estensivo di estrazione per definire il modo in cui il capitale finanziario si rapporta alle diverse forme assunte dalla cooperazione (e dalla concorrenza) sociale. La differenza rispetto al capitale industriale è qui particolarmente importante: mentre l’operaio, una volta varcati i cancelli della fabbrica, si trova all’interno di un sistema di cooperazione organizzato dal padrone, la donna nera sola (per usare una figura stereotipica) che contrae un mutuo subprime deve pagare mensilmente il debito entrando in una serie di rapporti di cooperazione, dipendenza e sfruttamento che risultano essenzialmente indifferenti al capitale finanziario, che si limita appunto a “estrarre” una quota di valore prodotto dall’interno di quei rapporti.
Questo esempio stilizzato mostra del resto in modo efficace il rilievo del debito nelle forme contemporanee di subordinazione e sfruttamento18. Guardando al funzionamento di giganti della distribuzione come Amazon o Walmart, Tsing sottolinea che le modalità di produzione delle merci commercializzate sono sempre più lasciate interamente ai fornitori (che se ne fanno carico all’insegna dell’imperativo categorico di abbattere i costi), mentre quel che conta di più dal punto di vista della valorizzazione è la capacità “logistica” di sincronizzare queste modalità eterogenee di produzione appunto all’interno della catena di fornitura. “Piracy” è il termine che Tsing utilizza per definire il rapporto tra catena e ambiente economico e sociale circostante: ed evidentemente siamo prossimi al campo semantico dell’estrazione.
7. Fine del neo-liberalismo?
Adottare una prospettiva come quella suggerita dal concetto estensivo di estrazione consente, come si è detto, di classificare una serie di operazioni del capitale che producono i loro effetti a livello globale, sia pure in modo differenziato e generando anzi geografie profondamente eterogenee dello sviluppo e della crisi del capitalismo contemporaneo. A me pare, inoltre, che offra una prospettiva originale su un altro tema al centro dei dibattiti sulla crisi contemporanea: ovvero il neo-liberalismo, un concetto che ha orientato molte analisi critiche della globalizzazione negli ultimi vent’anni, fino a ridursi spesso a termine vuoto e assolutamente generico (per quanto non siano mancati usi del concetto consapevoli della diversità dei contesti a cui si applica e dunque della sua complessità e “duttilità”: penso ad esempio ai lavori di Wang Hui sulla Cina o a quelli di Aihwa Ong sull’Asia sud-orientale).
La crisi economica globale rappresenta la fine del neo-liberalismo, come affermano ad esempio Gérard Dumenil e Dominique Lévy19? O è piuttosto più realistico sostenere che “il dominio ecologico del neo-liberalismo” all’interno del “capitalismo variegato” è sopravvissuto alla crisi del 2007-200820? A me pare che la prima ipotesi sia decisamente affrettata, e che molti elementi militino piuttosto a sostegno della seconda. Ma mi sembra soprattutto che lo stesso concetto di neo-liberalismo debba essere riesaminato criticamente. E se rimangono essenziali le indicazioni di Michel Foucault, che ci invitano a studiare il neo-liberalismo non come un semplice insieme di ricette macro-economiche ma piuttosto per gli effetti che ha sotto il profilo della soggettività, anche da questo punto di vista il lavoro di molti geografi critici può essere prezioso.
Mi limito qui a menzionare un saggio recente di Jamie Peck, “Explaining (With) Neoliberalism”21, che sottolinea in modo convincente la necessità di studiare il neo-liberalismo come un processo, ovvero di enfatizzarne la natura “embedded”, contraddittoria e aperta, l’impossibile “purezza”. Da questo punto di vista diventa possibile da una parte collegare i processi di “neo-liberalizzazione” all’assiomatica estrattiva del capitalismo contemporaneo, con la peculiare produzione di soggettività e con i regimi specifici di governamentalità che la contraddistinguono, mentre dall’altra se ne può cogliere analiticamente la riproduzione anche in quei contesti, come i Paesi latinoamericani con governi “progressisti”, dove il dibattito pubblico è dominato dal tema del “ritorno dello Stato”22.
8. Lo Stato, reloaded
Proprio il tema dello Stato, del resto, richiede una nuova considerazione critica, in particolare (ma non soltanto) per quel che riguarda l’analisi delle geografie della crisi e dello sviluppo capitalistico. Nel corso degli ultimi anni una serie di studi fondamentali (quelli di Michael Hardt e Toni Negri a partire da Impero, ad esempio, ma anche quelli di Saskia Sassen) hanno messo in evidenza la profonda trasformazione dello Stato nel contesto dei processi di globalizzazione, sottolineando come la sua stessa “unità” sia stata messa radicalmente in discussione dal punto di vista giuridico e politico. Border as Method, il libro più volte menzionato che ho scritto con Brett Neilson, si colloca nel solco di questi studi, contribuisce cioè a mostrare che cosa lo Stato non è più. Non si tratta, evidentemente, di tornare indietro rispetto ai risultati acquisiti, ma piuttosto di andare avanti, cominciando a lavorare su che cosa lo Stato è oggi, a diverse latitudini e a fronte di diversi regimi di accumulazione.
Per quanto profondamente trasformato, per molti versi irriconoscibile se misurato sui parametri della classica dottrina dello Stato europea dell’inizio del Novecento, lo Stato continua a essere un attore strategico nei processi di riallineamento dell’economia capitalistica globale (nella gestione dell’interdipendenza, dell’inserimento nel mercato mondiale e nelle configurazioni regionali emergenti), gioca ruoli cruciali nell’articolazione e nel “radicamento” della logica estrattiva del capitalismo contemporaneo su eterogenee scale geografiche. Inoltre, come in particolare il caso latinoamericano mostra in modo particolarmente efficace, continua a essere oggetto di investimento di desideri e aspettative di emancipazione e di trasformazione (e opporre a questo investimento una critica astratta della forma Stato rischia di essere politicamente del tutto inefficace).
Una triplice prospettiva di analisi dello Stato nel presente globale può essere indicata come conclusione provvisoria di queste note.
In primo luogo, è necessario approfondire la nostra comprensione dei cambiamenti a cui è oggi sottoposta la nozione stessa di territorio (che, non è inutile ricordarlo, è uno dei elementi costitutivi della sovranità nel pensiero giuridico e politico moderno). In Border as Method, lavorando in particolare sulla Cina e sull’India, abbiamo posto l’accento sui processi di moltiplicazione delle “zone” e sulla corrispondente “eterogeneizzazione” di territori nazionali formalmente omogenei. Sotto il profilo genealogico, questi processi hanno le loro radici in dispositivi coloniali di governo dello spazio, tra cui la “concessione” è particolarmente importante. Questo approccio genealogico apre prospettive analitiche da cui studiare una serie di processi cruciali nel nostro tempo – dal ruolo giocato da “frammenti territoriali” posseduti da ex potenze coloniali nel determinare l’estensione delle loro “zone economiche esclusive” marittime23 al “land grabbing” attuato in Africa e altrove da molte potenze emergenti24 ai processi di “regionalizzazione” in atto nell’Unione Europea25. Ma il punto su cui appare particolarmente importante approfondire l’analisi è la capacità che gli Stati (alcuni più di altri, evidentemente) mostrano di sovra-determinare questi processi di scomposizione territoriale, rappresentandone l’unità tanto sul piano delle retoriche quanto sul piano delle politiche. Nel momento in cui molte delle più rilevanti lotte sociali si presentano come lotte per lo spazio, indagare questa sconnessione di piani è urgente anche sotto il profilo immediatamente politico.
 In secondo luogo, è necessario studiare accuratamente le trasformazioni dei rapporti tra Stato e capitale, riprendendo e aggiornando la tradizione di analisi marxista che ha lavorato criticamente sullo Stato a partire dal concetto di “capitale complessivo”. Sarà evidentemente necessario tenere nel debito conto il fatto che la rappresentazione del “capitale complessivo” è oggi attraversata e complicata dalla logica estrattiva della finanza, dal protagonismo di attori transnazionali, e dalla presenza di regimi giuridici globali: che in nessun modo, in altri termini, il capitale complessivo si rappresenta come “nazionale”. In molti casi, il rapporto tra quelle che in termini marxiani si possono definire “frazioni di capitale” e singole strutture statali si presenta in forme ibride, con le logiche della “corporation” e quelle del “governo” che, lungi dall’essere ordinatamente distribuite sui due poli dell’attore economico e di quello politico si intrecciano nell’azione dell’uno come dell’altro. Molti modelli di partnership pubblico/privato sembrano anch’essi conformarsi a questo modello. Volendo anche in questo caso rintracciare geneologicamente degli antecedenti, sarebbe interessante studiare il modello della cosiddetta chartered company, a partire da quella più nota, la Compagnia delle Indie Orientali inglese26. In termini generali, in ogni caso, decisivo è comprendere se all’interno di questa figura emergente dello Stato – anch’essa profondamente differenziata a seconda dei contesti – vi sono spazi per una rappresentazione del “lavoro”, o comunque di “interessi” diversamente qualificati rispetto a quelli capitalistici. Allargando l’indagine in una prospettiva globale andranno censite le forme di mediazione che, secondo una logica segmentata (dalla cooptazione al corporativismo), molto diversa da quella che abbiamo conosciuto in Occidente nel tempo storico delle costituzioni del lavoro, continuano comunque a manifestarsi. Ne andranno evidenziati e criticati i limiti radicali a fronte dell’assiomatica estrattiva del capitalismo contemporaneo, ma ne andranno anche colti – laddove emergono – gli elementi di novità (come abbiamo fatto almeno in determinati passaggi del recente ciclo dei governi “progressisti” latinoamericani).
In secondo luogo, è necessario studiare accuratamente le trasformazioni dei rapporti tra Stato e capitale, riprendendo e aggiornando la tradizione di analisi marxista che ha lavorato criticamente sullo Stato a partire dal concetto di “capitale complessivo”. Sarà evidentemente necessario tenere nel debito conto il fatto che la rappresentazione del “capitale complessivo” è oggi attraversata e complicata dalla logica estrattiva della finanza, dal protagonismo di attori transnazionali, e dalla presenza di regimi giuridici globali: che in nessun modo, in altri termini, il capitale complessivo si rappresenta come “nazionale”. In molti casi, il rapporto tra quelle che in termini marxiani si possono definire “frazioni di capitale” e singole strutture statali si presenta in forme ibride, con le logiche della “corporation” e quelle del “governo” che, lungi dall’essere ordinatamente distribuite sui due poli dell’attore economico e di quello politico si intrecciano nell’azione dell’uno come dell’altro. Molti modelli di partnership pubblico/privato sembrano anch’essi conformarsi a questo modello. Volendo anche in questo caso rintracciare geneologicamente degli antecedenti, sarebbe interessante studiare il modello della cosiddetta chartered company, a partire da quella più nota, la Compagnia delle Indie Orientali inglese26. In termini generali, in ogni caso, decisivo è comprendere se all’interno di questa figura emergente dello Stato – anch’essa profondamente differenziata a seconda dei contesti – vi sono spazi per una rappresentazione del “lavoro”, o comunque di “interessi” diversamente qualificati rispetto a quelli capitalistici. Allargando l’indagine in una prospettiva globale andranno censite le forme di mediazione che, secondo una logica segmentata (dalla cooptazione al corporativismo), molto diversa da quella che abbiamo conosciuto in Occidente nel tempo storico delle costituzioni del lavoro, continuano comunque a manifestarsi. Ne andranno evidenziati e criticati i limiti radicali a fronte dell’assiomatica estrattiva del capitalismo contemporaneo, ma ne andranno anche colti – laddove emergono – gli elementi di novità (come abbiamo fatto almeno in determinati passaggi del recente ciclo dei governi “progressisti” latinoamericani).
In terzo luogo, c’è l’esigenza di approfondire l’analisi dei processi di disarticolazione dell’unità dello Stato, ricostruendo i processi di “neo-liberalizzazione” che continuano a ri-plasmare nel senso appena indicato l’azione e la “razionalità” di specifiche strutture statuali. In via ipotetica si può supporre la possibilità che all’interno di questo processo emergano contraddizioni all’interno dell’assetto istituzionale complessivo della forma Stato, e che altre strutture si presentino come elementi di potenziale resistenza ai processi di neo-liberalizzazione (è un’ipotesi su cui stanno lavorando molti compagni ancora una volta in America Latina). L’attraversamento di queste strutture, la loro appropriazione e la loro “ri-significazione” all’interno dell’articolazione istituzionale di un progetto politico di costruzione del comune è un’ipotesi il cui realismo va valutato caso per caso. Decisiva, da questo punto di vista, è comunque la forza, la potenza costituente dei movimenti e delle lotte che si generano a partire dalle trasformazioni, dalle dinamiche e dalle dimensioni soggettive del lavoro sociale, della cooperazione e della vita sfruttati dal capitale. E non si dovrà dimenticare che, analogamente a quanto si è detto a proposito del territorio, anche il processo di disarticolazione del sistema istituzionale dello Stato viene continuamente sovradeterminato, tanto sul piano delle retoriche quanto sul piano delle politiche, dalla riaffermazione, più o meno violenta, più o meno benevola, della sua unità. Ne abbiamo continue conferme anche in Europa: e proprio l’esempio europeo suggerisce di prestare la massima attenzione, tanto dal punto di vista analitico quanto dal punto di vista politico, al ruolo giocato dallo Stato all’interno dei processi di regionalizzazione che caratterizzano l’attuale ridefinizione degli assetti globali del capitalismo. Non solo in Europa, è proprio su questo tema che si gioca la necessaria reinvenzione dell’internazionalismo, intesa come soglia minima per attribuire realisticamente efficacia alle lotte e all’azione politica anche su scala locale e “nazionale”. Questo ordine di considerazioni, in ogni caso, conduce a una radicale ripoliticizzazione dei dibattiti sul capitalismo contemporaneo, sulle sue geografie e sulla sua differenziazione dinamica27.
Riprendo qui la traccia di una lezione tenuta alla Humboldt Universität di Berlino, all’interno della Summer School “Teaching the Crisis” (settembre 2013). ↩
Cfr. J. Agnew, “The Territorial Trap: Geographical Assumptions of International Relations Theory”, Review of International Political Economy, 1 (1994), 1. ↩
J.A. Agnew, “Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics”, in Annals of the Association of American Sociologists, 95 [2005], 2, p. 441; Id., Globalizing Sovereignty, Rowan & Littlefield, 2009. ↩
Cfr. S. Sassen “When Territory Deborders Territoriality”, Territory, Politics, Governance, 1 [2013], 1. ↩
Cfr. ad es. J.T Chalcraft, “Pluralizing Capital, Challenging Eurocentrism: Toward post-Marxist Historiography”, Radical History Review 91 [2005]. ↩
B. Jessop, “The Diversity and Variability of Capitalism”, in Ch. Lane and G.T. Wood, Capitalist Diversity and Diversity Within Capitalism, London – New York, Routledge, 2012, p. 233. ↩
Cfr. il libro da loro curato, Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford, 2001 ↩
C. Crouch, Capitalist Diversity and Change. Recombinant Governance and Institutional Entrepreneurs, Oxford University Press, 2005, p. 42. ↩
Cfr. W. Streeck, Re-Forming Capitalism: Institutional Change in the German Political Economy, Oxford University Press, 2009 ↩
The Geography of Finance. Corporate Governance in the Global Marketplace, Oxford University Press, 2007. ↩
K. Fan Lim, “On China’s Growing Geo-economic Influence and the Evolution of Variegated Capitalism”, in Geoforum, 41 [2010], in specie p. 680. ↩
A.D. Dixon, “Variagated Capitalism and the Geography of Finance: Towards a Common Agenda”, in Progress in Human Geography, 35 [2010], 2, p. 203. ↩
“Variegated Capitalism”, in Progress in Human Geography, 31 [2007], 6. ↩
Cfr. G. Deleuze – F. Guattari, Mille piani. Capitalismo e schizofrenia [1980], trad. it. Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1987, in specie p. 638. ↩
Cfr. A. Fumagalli – S. Mezzadra, a cura di, Crisi dell’economia globale. Mercati finanziari, lotte sociali e nuovi scenari politici, Verona, ombre corte, 2009, e più in generale i lavori di Christian Marazzi. ↩
R. Martin, “After Economy? Social Logics of the Derivatives”, in Social Text, 31 [2013], 1, p. 89. ↩
Cfr. il nostro “Extraction, Logistics, Finance. Global Crisis and the Politics of Operations”, in Radical Philosophy, 178 [March-April 2013]. ↩
Cfr. M. Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato, Roma, DeriveApprodi, 2012); al tempo stesso, tuttavia, consiglia di non assolutizzarlo, e di analizzarlo congiuntamente ad altre forme e ad altri rapporti (quelli, spesso presidiati da figure d’impresa assolutamente tradizionali, in cui la donna nera del nostro esempio deve entrare per poter ripagare il suo debito). L’ipotesi da verificare, in ogni caso, è che un concetto estensivo di estrazione si presti a definire un insieme di operazioni essenziali del capitale, che rientrano a pieno titolo nell’assiomatica del capitalismo contemporaneo – ovvero in quei caratteri comuni che comandano il processo della sua differenziazione su eterogenee scale geografiche.
È evidente che il rilievo globale del settore estrattivo in senso stretto (su cui insiste criticamente in America Latina il dibattito sul neo-extractivismo) deve essere tenuto ben presente nello sviluppo e nella verifica di questa ipotesi. Si possono poi indicare alcuni ambiti di ricerca particolarmente importanti: il cosiddetto data mining in rete, il “bio-capitale” (ovvero lo sviluppo e la commercializzazione di farmaci “post-genomici”), l’alleanza tra capitale finanziario e capitale immobiliare nei processi di “rinnovamento urbano” e gentrification.
Altri se ne dovranno individuare. Mi limito qui a un unico ulteriore esempio, relativo alle trasformazioni delle cosiddette “catene di fornitura” (supply chains) e della logistica, il cui rilievo per il capitalismo globale contemporaneo è difficilmente contestabile. Anna Tsing, un’antropologa statunitense che lavora da anni su questi temi, ha insistito recentemente sul fatto che oggi, contrariamente a quel che accadeva nel capitalismo industriale, molto spesso è la catena di fornitura a comandare la produzione ((A. Tsing, “On Nonscalability”, in Common Knowledge, 18 [2012], 3. ↩
The Crisis of Neoliberalism, Harvard University Press, 2011. ↩
Jessop, “The Diversity and Variability of Capitalism”, cit., p. 233. ↩
Territory, Politics, Governance, published online 21 June 2013. ↩
Si veda ad esempio l’analisi del governo di Evo Morales offerta da Daniel M. Goldstein, “Decolonizing ‘Actually Existing Neoliberalism’”, in Social Anthropology/Anthropologie Sociale, 2012, 20 [2012], 3. ↩
Cfr. P. Nolan, “Imperial Archipelagos. China, Western Colonialism and the Law of the Sea”, in New Left Review, 80 [March-April 2013]. ↩
Cfr. S. Sassen, “A Savage Sorting of Winners and Losers: Contemporary Versions of Primitive Accumulation”, Globalizations, vol. 7 [2010], 1-2. ↩
Si vedano i materiali raccolti nel numero monografico di European Urban and Regional Studies, 20 [2013]. ↩
Cfr. Ph.J. Stern, The Company State. Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India, Oxford – New York, Oxford University Press, 2011. ↩
Cfr. anche U. Rossi, “On the Varying Ontologies of Capitalism: Embeddedness, Dispossession, Subsumption”, Progress in Human Geography, published online 28 November 2012, p. 15. ↩