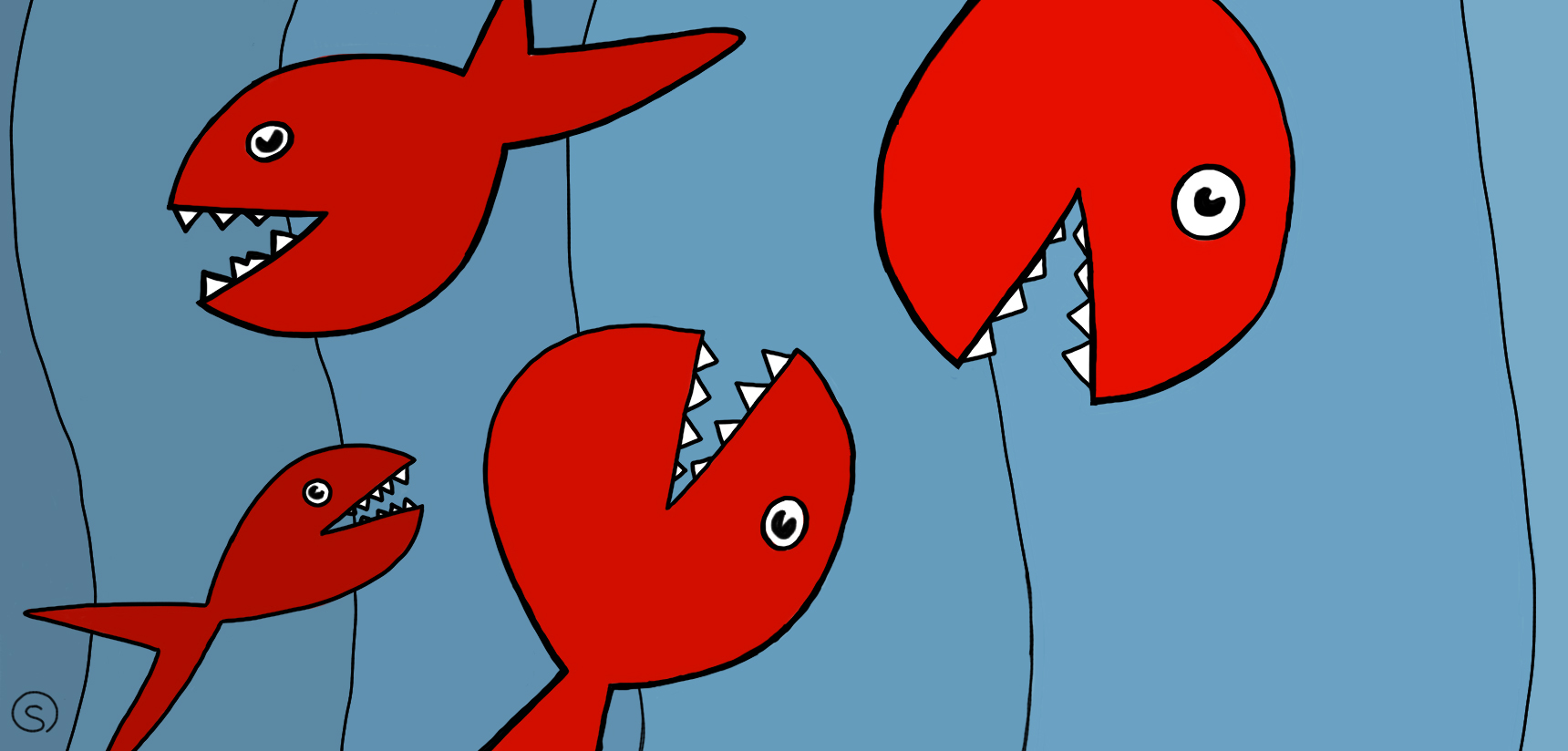di GIROLAMO DE MICHELE.
Il Rapporto sui diritti globali è una pubblicazione annuale edita dall’Associazione Società INformazione Onlus nata nel 2003 sull’onda lunga del G8 di Genova, e curata da Sergio Segio, che con questo 21° volume festeggia, per così dire, i suoi vent’anni. Si tratta, per chi ha a cuore i diritti globali, di uno strumento prezioso, di quelli che necessitano per tenere non ancorati, ma ben piantati al suolo i piedi del discorso: una rassegna dei luoghi, delle modalità, delle pratiche attraverso le quali anno dopo anni i diritti sono messi in questione, o si affermano come conseguenza di lotte e movimenti. L’apertura globale consente al tempo stesso di tenere insieme lotte e diritti che altrimenti rischiano – come il più delle volte succede – di essere almanaccati uno per uno, in una narrazione che disconnette ciò che andrebbe sempre letto sullo sfondo di un orizzonte comune.
Vent’anni sono abbastanza per tracciare un bilancio di un’impresa che fino ad oggi ha pubblicato qualcosa come quasi 20.000 pagine: e così è stato. Il Rapporto diritti globali 2023, edito da Milieu Edizioni, infatti, è costituito da una silloge delle interviste tratte dai precedenti volumi, raccolte sotto l’esplicito titolo “Le guerre in corso contro popoli, diritti umani, lavoro, diritti sociali, migranti”. Si tratta di un volume di quasi 700 pagine, cui si aggiunge una seconda silloge di quasi equivalenti dimensioni, Globalizzare i diritti. Una memoria critica per comprendere e cambiare il mondo, che raccoglie le venti introduzioni dei volumi scritte dal curatore. Ambedue i volumi sono introdotti, come sempre, da Sergio Segio [qui i sommari del primo e secondo volume], che nel presentare i due lavori non ha esitato a parlare di quadro a tinte fosche. L’oscurità del quadro è, oltre che una constatazione, anche un effetto percepito a partire dal punto di vista dal quale guardare lo stato delle cose: quella fase espansiva delle lotte in nome di diritti – di migrazione e di cittadinanza in primo luogo – e di rifiuto della guerra (Afghanistan e Irak, ai tempi) che si svolse fra Genova, Porto Alegre e le grandi manifestazioni per la pace del 2003, quando a nessunə capitò di trovarsi sotto il “fuoco amico” dell’accusa di essere fiancheggiatorə dei talebani o di Saddam Hussain. “Volevamo solo cambiare il mondo” è l’incipit di Segio, che a partire da quel momento prospettico prende in esame il populismo penale in Italia, che sospinge “fuori orizzonte” alcuni capisaldi di civiltà giuridica in campo penale, e ignora sistematicamente le cause sociali, economiche e culturali dei diversi fenomeni oggetto di inasprimento penale, accomunati dalla convinzione che la povertà è una colpa e una responsabilità individuale. Un punto fermo della critica di Mark Fisher al neoliberismo, cui si aggiunge la dogmatica asserzione che allo stato di cose presente, cioè alla sottomissione dei processi sociali alle regole del mercato, non c’è alternativa. Con buona memoria, Segio ci ricorda che il neoliberismo fu sperimentato in quel sanguinoso laboratorio che è stato il Cile di Pinochet: ci ricorda, cioè, che l’economia uccide. Non c’è bisogno di glorificare il lavoro, né di farne un valore in sé, per ricordare che di lavoro si muore, e non dovrebbe accadere: così come si muore di migrazione, anche per effetto di quella Fortezza Europa che ha dichiarato guerra ai migranti. Vale a dire: che ogni discorso che sorvoli sui diritti dei lavoratori, o sul diritto di cittadinanza, come residui del passato, deve poi fare i conti con le concrete esistenze che sui luoghi di lavoro piuttosto che nel Mediterraneo, e prima ancora nelle carceri libiche, e ancor prima nei deserti attraversati a piedi, vivere non solo non è scontato, ma non è neanche probabile.
Dalla guerra metaforica, l’introduzione si sposta sul piano delle guerre vere e proprie, in particolare quelle in corso a Gaza e in Ucraina, riuscendo a mantenere quella lucidità di analisi che consente di non farsi abbagliare da una valutazione forzatamente positiva della guerra cosiddetta “giusta” (che la morte di Gino Strada sembra aver sdoganato), mantenendo la convinzione che un discorso sugli orrori presenti – quello del 7 ottobre, e quello che si dispiega a Gaza – non può prescindere dalla “analisi delle radici storiche, degli antefatti e delle responsabilità politiche”. Il che non significa esimersi dal dovere di denunciare “gli orrori del presente e le responsabilità di Hamas”; nondimeno, questa capacità di storicizzazione “è doverosa e necessaria se si vogliono affrontare i problemi anziché esorcizzarli e rimuoverli o strumentalizzarli, e quindi moltiplicarli”.
Con altrettanta lucidità viene analizzata la guerra in ucraina, per trarne alcune caratteristiche strutturali, prescindendo dal clima da derby calcistico con cui questo conflitto viene spesso assunto dalle rispettive tifoserie; fra le quali, “i gravi vulnus alla democrazia e drastiche limitazioni alle libertà civili da entrambi i governi belligeranti”. Questa considerazione mi sembra possa essere assunta a metodo generale, a fronte dei due corposi volumi: che la guerra, spogliata di ogni fascinazione faziosa, possa essere compresa come lo strumento generale dell’attacco ai diritti, alle libertà, alla vita stessa. Il che, sul rovescio del tappeto, dovrebbe favorire la connessione dei diversi soggetti sotto attacco come interni a un unico processo, a dispetto delle apparenti diversità delle pratiche. D’altronde, temi come le condizioni presenti del lavoro, le migrazioni, i diritti umani, politici e sociali, l’ambiente sono resi attuali dal loro essere imposti da lotte che, in modo diverso e con diversa intensità, si dànno: sono parole che esistono perché esistono cose, non l’inverso. A dispetto di chi oggi, con gesto blasé, liquida i diritti fra le piccole cose di pessimo gusto, parole delle quali sarebbe opportuno liberarsi, o snobbava ieri con sussiegosi filosofemi le diverse forme attraverso cui può darsi diritto di cittadinanza per i migranti – ad esempio lo ius soli – come forma di assoggettamento all’ordine giuridico statuale. Per i diritti, per le lotte per i diritti in generale, può e deve essere detto quanto ha detto poco tempo fa Alisa Del Re quando ha definito l’ansia di affermare la fine del patriarcato come “un’esigenza di catarsi da parte di chi è escluso da quei processi messi in atto dai movimenti femministi”. Raccogliendo questa indicazione di metodo, e coniugandola con la precedente – leggere la guerra come paradigma dell’attacco ai diritti – significa quantomeno porsi il problema non solo dell’attuale attacco alle vite nel loro differente manifestarsi, ma soprattutto della possibilità che nell’arco di un anno le guerre senza fine, gli esiti delle elezioni negli Stati Uniti e nell’UE, le conseguenze di elezioni recenti (ma anche future) in America Latina possano estendere la militarizzazione come processo di governance, lo scambio fra diritti e sicurezza sociale, la guerra contro la povertà, la privatizzazione – cioè la sottomissione alle regole del mercato – di porzioni ancora più vaste del settore pubblico. Realizzando una fascistizzazione sotto altro nome che, al netto delle esibizioni simbolico-nostalgiche, come in un romanzo di Ballard o di Dick riattualizzi il desiderio fascista.
Il problema, alla fine è sempre quello di chi del modo presente, e del suo studio metafisico, ne ha abbastanza, e vorrebbe rimettere all’ordine del giorno la questione della sua distruzione.