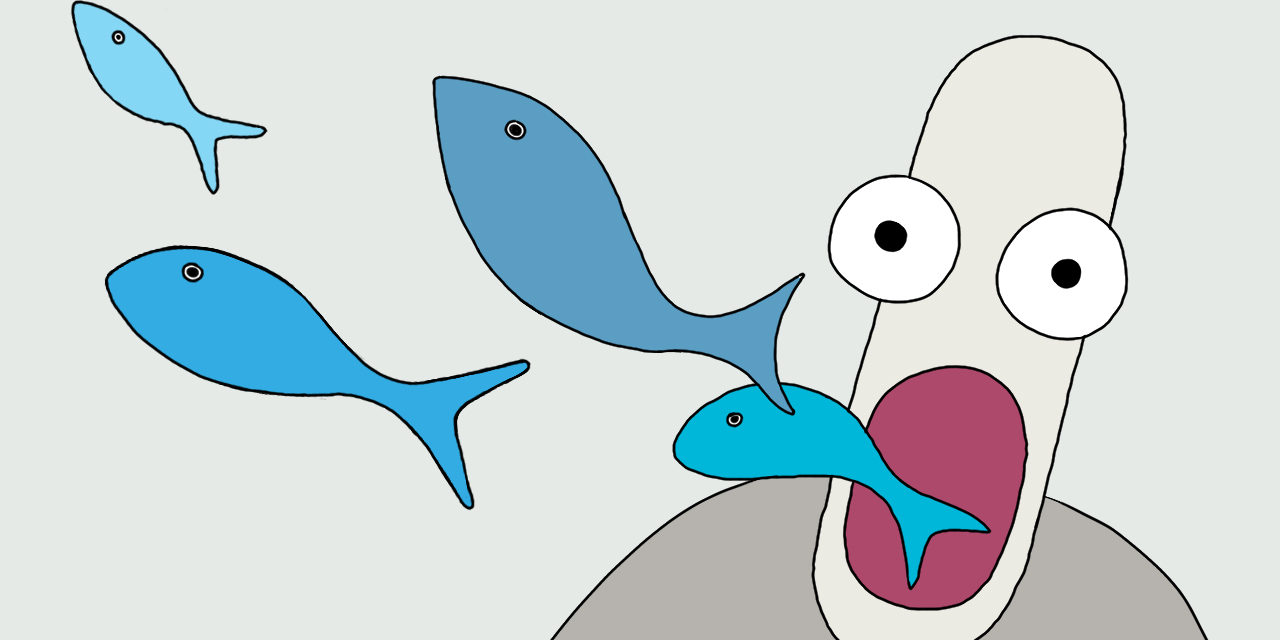di NICOLAS MARTINO.
«Ora che lo spettacolo non occupa più solo le nostre vite ma anche i nostri sogni, le nostre aspirazioni, il ruolo simbolico che un tempo è stato della rivoluzione, possiamo dire che un ciclo si è concluso. Con una sorta di silenziosa Invasione degli ultracorpi lo spettacolo si è impadronito delle nostre vite, dei nostri corpi, riducendoli a gusci vuoti».
Così scrive Carlo Freccero in chiusura del fulminante pamphlet «L’idolo del capitalismo» (Castelvecchi, 2016). Scritto seguendo il sentiero di due giganti del Novecento, Adorno e Debord, nella prima parte si analizza la nascita dell’ideologia neoliberista, quando una «nuova ragione del mondo» sostituisce il compromesso tra capitale e lavoro che aveva garantito benessere senza peraltro espungere il conflitto, ma piegandolo a proprio favore. Una nuova ragione, ovvero un «idolo», che se da un lato si presenta come legibus solutus rispetto al compromesso keynesiano, dall’altro produce una «forma di vita» che punta a colonizzare l’anima dei soggetti e che, fondata sul paradigma della gestione imprenditoriale e proprietaria del sé, è «invariabilmente» di destra, e quindi viene politicamente e retoricamente gestita in questo senso, essendo ormai «naturalmente» fuori gioco qualsiasi sinistra.
Nella seconda parte Freccero tratteggia le conseguenze sociali e antropologiche di quello che chiama il «consumo culturale», ovvero quel divenire culturale del general intellect che Jameson definisce postmodernismo. Il divenire immateriale della produzione ha fatto della cultura il consumo più importante, nel divenire «culturale» della produzione di merci però, questa era la tesi di Adorno, la cultura perde la sua «anima critica» diventando puro intrattenimento e l’unica resistenza possibile diventa il fortino dell’avanguardia, oppure il silenzio. Una tesi che struttura anche l’impianto de «La società dello spettacolo» di Debord, una condanna senza appello, esito di un marxismo dialettico che apre a esiti «tragici», come nel caso di Adorno e dell’IS, o «ironici» come nel caso di Baudrillard. E da qui ci sembra discendere anche la conclusione di Freccero, nel discorso del quale, però, rimane in agguato una contraddizione «produttiva» della quale diremo tra poco.
Il fatto è che ciò che questa tradizione di pensiero, pur nelle diverse declinazioni, condivide, è una condanna dell’industria culturale in quanto fabbrica del falso, e una idea della filosofia come «disvelamento». Una posizione che potremmo riassumere così: 1. C’è una verità che, occultata, occorre ristabilire; 2. Questa verità la si può ristabilire nella dialettica tra dentro e fuori, davanti e dietro, vero e falso; 3. Quando però il capitalismo riesce a colonizzare il pianeta e anche l’anima nella loro totalità, non si da più dialettica e quindi non è più possibile disvelare la verità. In poche parole, non c’è più niente da fare. Eppure, e Freccero lo sa bene, esiste un’altra linea «materialista», anche nella teoria critica, che invece di condannare l’industria culturale prova a studiarla dall’interno, e punta tutto su un pensiero della superficie smarcandosi dalla dialettica tra vero e falso, ma individuando sempre il conflitto. Basterebbe citare Kracauer che notava come «le masse si lasciano stordire solo perché sono più vicine alla verità» e che «alla forma dell’attività lavorativa corrisponde necessariamente la forma del divertimento», per capire che nell’industria culturale c’è una battaglia strategica da combattere, come riconosce lo stesso Freccero, questa la contraddizione «produttiva», quando insiste sullo sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che riesce a fare male al padrone.
Perché oggi le grandi fabbriche sono quelle dell’anima e sono le intelligenze al lavoro nella cultura diffusa che possono organizzare il conflitto. Per questo non siamo d’accordo con la conclusione e, se è vero, come dice Freccero, che oggi protagonista di «Matrix» non sarebbe più Neo, l’eroe che combatte per ristabilire la verità, ma Cypher, il traditore che vuole annegare nelle gioie dello spettacolo, la questione essenziale è, per chiudere con Kracauer, che oggi quel film è rivolto «in forme sorpassate a nobili sentimenti ormai obsoleti».
Questo articolo è uscito su il manifesto del 08.09.2016