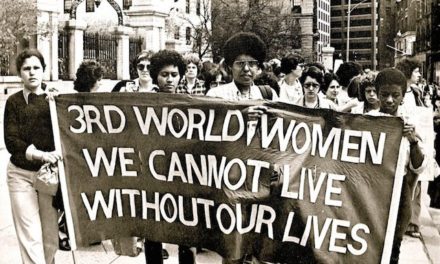di UGO MATTEI, MICHELE SPANÒ
[Questo contributo è parte del volume Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, a cura di Federico Zappino, Lorenzo Coccoli e Marco Tabacchini, Mimesis, Milano 2014]
Difficile, per non dire impossibile, affrontare la legalità come un concetto dotato di autonoma consistenza. E ciò non già per la ragione banale per cui tutti i concetti politico-giuridici sono “essentially contested”, ma per almeno due altri e più rilevanti motivi: il primo è che, almeno nella modernità, è stato impensabile trattare di legalità prescindendo dal suo concetto gemello: quello di legittimità; il secondo è quello che – considerandola in crisi permanente – impedisce di rivolgersi alla legalità altrimenti che nel modo della critica.
Nessun altro come Carl Schmitt ha mostrato fino a che punto il nesso tra legalità e legittimità sia stato la pietra angolare del moderno Stato di diritto1. Punto più alto della parabola del liberalismo, il Rechtsstaat, anche e forse soprattutto nella sua espressione democratico-parlamentare, ha fatto della legge e dunque del principio di legalità (Gesetzmassigkeit) il mezzo e la forma della politica. Se è vero che la legalità impone un governo mediante e secondo la legge e la separazione tra produzione e applicazione di questa, essa traduce la volontà nella norma, rendendo legittimità e legalità integralmente indiscernibili2. La legittimità dello Stato di diritto è stata la legalità. L’equilibrio dei poteri e la sottoposizione di questi alla legge, insieme con la riduzione alla forma-di-legge di ogni valido atto dello Stato, ha contribuito a indeterminare veritas e auctoritas, fino a rendere oziosi i dibattiti che, per secoli, si erano cimentati col dilemma circa quale, delle due, “facesse”, in ultimo, la legge.
Il telescopage, quando non la semplice confusione, tra legalità e legittimità è tuttavia solo apparente: esso custodisce infatti le premesse della loro potenziale divaricazione. Come aveva intuito Schönberg in Mosè e Aronne: «Che vi sia una legge, questo devi salutare come un miracolo; che vi sia chi si ribella, questa è una trita banalità». Il rapporto tra legalità e legittimità ha natura asimmettrica: la legalità è quella “porta” varcata la quale è possibile decidere di ogni legittimità. Essa, come ha mostrato lucidamente Schmitt, assegnando il “premio politico sull’esercizio legale del potere”, è quella soglia che, una volta superata, consente la sua stessa disfatta3. Quanto a questa dinamica: non è necessario allegare prove. Gli Stati costituzionali elaboreranno gli esorcismi adatti al caso. Il sindacato di costituzionalità e la riserva di legge duplicano, nei modi della ultralegalità o della superlegalità, il registro della legalità.
Se la legalità ha riguardo della distinzione tra amministrazione e giustizia, essa ha potuto esibire prima le sue più edificanti prestazioni nel dominio del diritto penale e poi fornire il blasone a ogni contestazione dello Stato totale4. Ma allorché è proprio tale summa divisio a scricchiolare è lecito essere scettici verso una soluzione omeopatica5. Certamente lo spazio che tiene separati la legittimità dalla legalità è quello che in una società decide dell’estensione dei domini del politico e del giuridico. Ma questa è già storia di ieri. Sovranità e legalità cadono insieme. La differenziazione sociale, la singolarizzazione delle forme di vita, le metamorfosi del sistema produttivo indicano il tramonto della decisione e la fine del Leviatano. È una buona notizia; ma essa comporta una nuova confusione tra esecutivo e legislativo, che lascia margini prima inauditi al giudiziario. Questa è una notizia che può essere meno buona; ma è nondimeno qualcosa che accade. Occorre perciò immaginare forme e modi capaci di custodire la distinzione tra conflitto politico e sua formalizzazione; capaci cioè di mantenere insatura la formula del sociale. La democrazia è sembrata a lungo l’unica forma di governo in grado di comporre astrazione e trasformazione sociale: «Il potere di assorbimento proprio dell’ideologia democratica ha contribuito, allo stesso modo della prassi costituzionale, a rimuovere il diritto di resistenza»6. La resistenza trascorreva nella legge e la legalità attestava, fissandola e formalizzandola, della coincidenza tra atti amministrativi o di governo e legge stessa: «Alla razionalizzazione del concetto di legge corrisponde la formalizzazione del concetto di legalità»7. Dovremo allora dire che alla odierna irrazionalizzazione della prima segue lo sformarsi della seconda.
Sulla Costituzione sarà opportuno tornare. Soffermiamoci per ora sullo statuto critico che la legalità non smette di assumere. Perchè potesse sostenere, quale sua architrave, lo Stato di diritto, la legge doveva esibire caratteristiche definite: generalità, astrattezza, universalità. Nessuna è sopravvissuta al tempo. In secondo luogo, i due “volti” della legge nello Stato di diritto – forma e formalità, “mediante” e “attraverso” – sono entrambi sfigurati: soft law, decreti legge, stato d’eccezione permanente lo dimostrano aldilà di ogni ragionevole dubbio. La crisi del diritto è la crisi del suo Stato e insieme quella di impersonalità, razionalità e generalità. Incontestabile la crisi, ma non univoche le terapie. Non solo: la legalità tanto meno efficacemente assolve al suo compito di razionalizzazione e uniformazione, tanto più stinge e dilaga come retorica. Alla sua mancanza di effettività fa da contraltare un’egemonia simbolica crescente.
La retorica del Rule of Law è in questo senso esemplare. Se la crisi del nesso che legava legittimità e legalità segnala il tramonto di una forma della politica, essa ha anche contribuito alla trasformazione della politica in polizia. Di questa metamorfosi la legalità è stata un tassello cruciale. Un impasto che ha confuso, con un dilettantismo non privo di efficacia (in una parola: con i tratti tipici dell’arroganza), la democrazia ridotta a liturgia elettorare con i diritti umani spacciati per ricetta universale e allergica ai contesti, il Rule of Law ha finito per costituire null’altro che la poco scintillante veste capace di coprire quelle operazioni di saccheggio – materiale e simbolico – che hanno ridisegnato il mondo globalizzato prima e dopo 9/118. Se gli Stati Uniti d’America si sono distinti in questa impresa, la retorica della legalità ha assunto rapidamente proporzioni globali. Vero e proprio lasciapassare discorsivo e patente di moralità che decide dell’accesso all’arena internazionale, essa è il singnificante-vuoto che accredita i difensori della “democrazia”. Il divenire-polizia della politica internazionale e l’egemonia del modello di Law & Economics sul diritto internazionale sono i binari paralleli su cui la retorica della legalità viaggia distribuendo i dividendi del saccheggio e appuntando le medaglie del paternalismo e della filantropia.
Ma il caso domestico è forse ancora più eloquente. Lo scacchiere politico italiano ha infatti provveduto a una divisione del lavoro: da un lato la legittimità, dall’altro la legalità. Da un lato l’eversione istituzionale operata da alte cariche dello Stato, giustificata in virtù dell’investitura popolare o della “sospensione” eterodiretta della politica, dall’altro la delega a poteri terzi in forza di una conclamata incapacità di mediazione. In un caso come nell’altro, la politica è completamente espunta: se nel primo per saturazione, nel secondo per estinzione. In entrambe le interpretazioni: la dinamica politica italiana è esonerata dal nesso legalità e legittimità; essa è ormai, allo stesso tempo, una macchina capace di performances anti-politiche, impolitiche e ultrapolitiche. Perciò non può che girare fatalmente a vuoto. Dove però i due poli della macchina lavorano ancora di concerto è nella traduzione poliziesca del loro vuoto o troppo pieno di politica: la retorica della legalità funziona infatti come discorso passe-partout e unico residuo della “beanza” del politico che governa la macchina. Che sia per attingere a ogni riserva di legittimità o per mascherare la propria inettitudine a confliggere, la religione della legalità dilaga e lo fa costruendo nemici. In un caso si tratta di inventare l’antagonista del popolo ultrapolitico della destra (e i nemici saranno allora i migranti), nell’altro quello di chi le regole le rispetta (e i nemici in questo caso saranno gli antagonisti sans phrase). Oggi il premio politico di schmittiana memoria si trasforma nella decisione sull’ordine pubblico. Se da un lato la legalità è diventata il discorso della sicurezza e i suoi nemici i criminali, dall’altro è diventata il discorso della repressione, anche e soprattutto dei desideri. Dunque un discorso moralista, da parte a parte. Del resto, molto resterebbe ancora da dire sul ruolo svolto dalla magistratura nel venir meno del nesso tra legalità e legittimità quale forma di regolazione eminente del rapporto tra politica e diritto.
Quello che si tratta di pensare non è tanto una soluzione, quanto una morale provvisoria, una tattica. Per farlo è opportuno abbandonare ogni postura luttuosa: ricomporre l’intero non è possibile e non è neppure auspicabile. Se avrebbe poco spazio un ragionamento sulla “rifondazione” della legalità in assenza di qualsiasi risorsa di senso, ancor più miope sarebbe non voler ascoltare la lezione che le forme di vita contemporanee, sulla legalità, già impartiscono. Più utile seguire due ipotesi di lavoro. La prima discende da una storicizzazione integrale del concetto di legalità e permette conseguentemente di mostrare, qui e ora, pratiche che la trasformano. La seconda prospetta una riflessione di lunga lena che ha a cuore una certa idea di diritto e di forma che ha il nome di Costituzione.
Occupare e fondare sono due verbi che del diritto e della politica costituiscono l’ossatura. Lontani dalle scene primarie del politico e perciò da ogni immaginario regressivo, essi offrono oggi una formidabile descrizione di nuove forme dell’agire sociale dentro e contro la legalità. Sia il caso della fondazione. A Roma, un teatro – il Valle – ha scelto la prima via, quella dell’occupazione, come extrema ratio a fronte della possibilità di scomparire. Il movimento dei beni comuni ha trovato qui la sua massima espressione e anche il suo limite. Perciò esso si è più recentemente costituito in fondazione: col fine di espandere e proteggere quella speciale forma di cooperazione e immaginazione sociale che fuori e dentro le sue mura continua a darsi convegno. Nel caso della fondazione è una forma legale del diritto – e del diritto privato – che inizia a disfarlo estendendo il campo del legittimo. Quello delle occupazioni, che riguarda ormai realtà troppo numerose per poter essere elencate, è un caso ancora più significativo: ciò che è attualmente considerato illegale trasforma – tanto lavorando per “legalizzarsi” quanto esibendosi e iterandosi in quanto tale – il legittimo possibile e il legale che c’è. L’uso lucido dell’art. 42 della Costituzione, dal Macao al Palazzo al Colorificio di Pisa, tra punti segnati e temporanei insuccessi, ha mostrato che l’autonomia dei concetti giuridici è disponibile alla trasformazione sociale e che la dialettica tra legale e legittimo è la sua stessa posta in gioco.
Entrambi gli esempi attestano l’assoluta contingenza, storicità e trasformabilità della legalità. Nei due casi gli operatori della trasformazione sono la cooperazione sociale e la materialità dei corpi: l’una non può essere senza l’altra nella costituenda legalità. La regola che da queste “scene” può essere ricavata ha validità più generale e coincide con null’altro che la marca temporale – quella del presente e della contingenza – che definisce la legalità stessa: illegale sarà sempre ciò che non è legale per l’ordinamento vigente. È una conclusione forse banale e tuttavia inaggirabile. Ogni trasformazione che sia veramente tale sarà allora e per definizione illegale. O anche: la legalità oggi è sempre il prodotto di infiniti atti di illegalità ieri. Una critica della legalità è sempre anche materialmente e storicamente critica della legittimità e viceversa: o questa in nome di quella o quella in nome di questa. Se la legalità è il presente, l’illegalità legalizzanda è il futuro o il futuro presente. D’altro canto, al presente, ma non del presente, decide solo l’ordinamento: «L’ordinamento giuridico statuale non rimprovera al rivoluzionario il fatto di relativizzare i concetti di legalità e di illegalità; solo se il risultato di questo processo ideale lo conduce eventualmente all’illegalità, lo mette in conflitto con questo. Non meno indifferente per il sistema giuridico vigente, è, però se un partito appartenga alla cerchia dei partiti “buoni”, nel caso che gli salti in mente di non osservare, sulla via che lo conduce al potere politico, la legge penale. Chi, d’altronde, vorrebbe essere così presentuoso da anticipare ciò che spetta soltanto allo storico: la differenziazione estremamente relativa tra partiti rivoluzionari e partiti “buoni”?»9. La confusione, e la possibile sovrapposizione, tra illegalità e legalità e il fatto che essa si possa indifferentemente predicare tanto dei mezzi quanto del fine, può condurre speditamente all’attività poliziesca dei tribunali, almeno tenendo per vera «la caratteristica concezione secondo la quale l’illegittimità delle idee sociali conduce sempre alla perdita del diritto di far legalmente uso di diritti legali»10. Ammesso che ci sia bisogno di precauzioni: questo discorso non ha nulla di sovversivo. Si limita alla descrizione rigorosa della dinamica e della trasformazione storica e giuridica11. Cosa si capirebbe infatti della “politica popolare” nella “gran parte del mondo”, di una “società politica” che negozia benessere e servizi, autonomia e libertà, sul e attraverso il crinale che separa legale e illegale, cinismo e resistenza12, tenendo fede a un’idea acontestuale e astorica della legalità? Il problema, insomma, è tanto politico almeno quanto metodologico.
Allo stesso modo – vale a dire: per gli stessi motivi – la storicizzazione integrale del concetto di legalità non equivale a un elogio dell’illegalità. Si tratterebbe di un assoluto abbaglio. Se è pur vero che la retorica della legalità, anche solo per il suo insopportabile tasso di moralismo, sembra a volte giustificare una speculare retorica dell’illegalità, è proprio la logica dello specchio a dover essere scartata. Varrebbe la pena di rispolverare quella doppia critica lukácsiana al romanticisimo dell’illegalità e al cretinismo della legalità, che, capace di isolare il “carattere puramente tattico” dell’una e dell’altra, altro non è che un lucidissimo elogio della spregiudicatezza. E c’è da credere che poche altre tonalità emotive possano ambire a forgiare l’ethos delle forme di vita contemporanee: «Nella misura in cui i mezzi ed i metodi illegali di lotta ricevono una particolare aureola, l’accento di una particolare “autenticità” rivoluzionaria, alla legalità dello Stato esistente viene attribuita ancora una certa validità e non un essere meramente empirico. Infatti, se ci si ribella alla legge in quanto legge, se si dà la preferenza a certe azioni per via del loro carattere illegale, ciò significa che per colui che agisce in questo modo il diritto ha mantenuto il suo carattere di validità vincolante. Mentre se vi è una piena spregiudicatezza comunista nei confronti del diritto e dello Stato, la legge e le sue prevedibili conseguenze non hanno né più né meno importanza di qualsiasi altro fatto della vita esteriore, di cui si deve tener conto nella valutazione della eseguibilità di una determinata azione; ed il fatto di trovarsi in condizione di trasgredire la legge non può quindi ricevere un accento diverso, ad esempio, da quello di perdere, in un viaggio di particolare importanza, una coincidenza ferroviaria»13. Un discorso sensato – e dunque critico – attorno alla legalità non può prescindere dalle forme di vita per come esse sono: la loro indifferenza verso le forme è anche ciò che indica che di esse non è possibile fare a meno. Le forme sono utili. L’uso, alla lettera, indifferente di una tattica legale e di una illegale è ciò che smaschera – cioè denaturalizza – l’ordinamento giuridico. E se non bastasse – o non piacesse – Lukács, sarà sufficiente pensare al discorso queer, uguale e contrario, sul riconoscimento legale del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la trasformabilità dei concetti giuridici. Per dissacrare la “maestà astratta” dello Stato non si può non assumere, insieme alla contingenza radicale e alla storicità assoluta dei concetti di legalità e illegalità, il loro inestinguibile tenore etico e cognitivo. Come non si ricompone la macchina della politica giocando legalità e legittimità l’una contro l’altra, tanto meno si disfa la retorica della legalità investendo sul suo antonimo. Ciò che occorre, piuttosto, sono un pensiero e una pratica che riconoscano l’intrascendibilità di queste tensioni e ne facciano il piano di consistenza di ogni trasformazione possibile.
Questo stile di negoziazione, di cui la legalità è insieme strumento e posta in gioco, ha nella metropoli il suo teatro. Si è recentemente fatto ricorso all’idea di «legalità porose»14 nel tentativo di isolare il ruolo cruciale che forme diffuse di illegalità hanno nel configurare l’accesso e la partecipazione di molti soggetti alla vita delle città globali. Le legalità porose incarnano una figura teorica capace di indicare – a prezzo, senz’altro, di un parziale cedimento al romanticismo – l’instabilità del confine tra legale e illegale, la cui sempre nuova determinazione, e può trattarsi indifferentemente di contrazione o espansione, costituisce l’enjeu delle negoziazioni tra governati e governanti, tra società politica e governamentalità. Uno strumento che, prosaicamente, ma in molti contesti urbani, consente a soggetti altrimenti esclusi di guadagnare un titolo di accesso e un certo grado di esistenza politica. Oltre a un indubbio valore etnografico, l’ipotesi di legalità apocrife e plurali costituisce un ulteriore guanto di sfida alla mitologia liberale del Rule of law: fratturando la distinzione binaria che separa la legalità dall’illegalità, essa addita la miriade di quotidiane e ordinarie negoziazioni con il potere che in una strategia che intreccia iterabilità e performatività ne disloca costantemente i confini: «They destabilise the structure, without making any claims. So the encroacher redefines the city, even as she needs the city to survive. The trespasser alters the border by crossing it, rendering it meaningless and yet making it present everywhere – even in the heart of the capital city – so that every citizen becomes a suspect alien and the compact of citizenship that sustains the state is quietly eroded. The pirate renders impossible the difference between the authorised and the unauthorised copy, spreading information and culture, and devaluing intellectual property at the same time. Seepage complicates the norm by inducing invisible structural changes that accumulate over time»15. Le lotte sociali, che altro non esibiscono se non la virtuosistica capacità di «sfruttare i pori», possono essere più sensatamente descritte quali veri e propri esercizi di appropriazione e ridistribuzione dei mezzi di produzione della legalità e dell’illegalità. Per quanto disagio morale essa possa produrre, la società politica costituisce una figura smagliante della catastrofe dei protocolli morali che decidono dell’accesso alla politica e potrà forse costituire la leva di quell’inderogabile “rettifica dei nomi” che permetta di immaginare una nuova politica dei governati. L’illegalità non solo può essere ma è a tutti gli effetti una strategia giuridica: essa modifica “da sotto” il diritto, innovandolo e obbligandolo a metabolizzare novità e sfide. Non vale soltanto la considerazione triviale per cui una deroga ripetuta si trasformerebbe fatalmente in norma, ma l’idea che il meccanismo che ha il diritto di “rappresentare” assume necessariamente la forma della crisi e che la legalità è di questa l’anamorfosi storica. Sono gli appelli plurivoci alla legalità che fanno di quest’ultima un concetto esposto e consegnato a una costante autosovversione.
A fronte di tanta “confusione” non stupisce, ma neppure aiuta, la difficile elaborazione del lutto del nesso tra legalità e legittimità che impegna molti filosofi politici contemporanei16. Il richiamo alla Chiesa cattolica quale unica forma politica in grado di integrare legalità e legittimità, auctoritas e potestas, maschera appena le difficoltà di confrontarsi con un presente in cui il nesso è saltato e vano sarebbe immaginare una sua ricomposizione. Oltre una malcelata nostalgia per la “tirannia dei valori” e un epimeteismo passatista sta la possibilità di una critica e di una prassi che sfuggendo alla fatalità della dicotomia siano insieme capaci di “sopportarla”: né custodi della legalità né partigiani della legittimità. Nessuna restaurazione della diade infranta, ma un tentativo costante – in funzione di scala, contesto e obiettivo – di usare l’una e l’altra, l’una contro l’altra. Se si assume la priorità della trasformazione sociale, occorrerà anche riconoscere che come essa è qualificata solo da quel che c’è così la trasformazione di quel che c’è dovrà sostenersi di nuove qualificazioni. Se allora è da respingere ogni retorica, che sia della legalità o della legittimità, c’è solo da accettare quel campo conflittuale che, come un’ascissa e un’ordinata, esse segnano alla cooperazione sociale: a essa sta di cambiare le unità di misura.
Il progetto costituzionale è stato questo: il tentativo di comporre legalità e legittimità su un piano alto. A questo circuito sono stati dati molti nomi: Costituzione materiale e formale17, Konstitution e Verfassung, potere costituente e potere costituito. Tutti altro non fanno che esibire questo andirivieni tra storia e forma, tra vita e regola, tra forma di vita e istituzione. Non si tratta perciò di difendere questa o quella Costituzione – benché, almeno per l’Italia, esista un numero non esiguo di argomenti a favore18 – né di redigere atti di morte o di allestire concorsi di bellezza tra carte; si tratta di riconoscere nella forma della Costituzione l’unico dispositivo ancora oggi disponibile per pensare la trasformazione, non in virtù di una petizione di principio o di un élan moralistico, ma perché è proprio della sua forma essere trasformabile e trasformativa. Oltre l’idea di una Costituzione da liquidare o da difendere, resta la questione della “forma” in quanto tale. Una “forma”, quella costituzionale, che oggi ha la chance di emanciparsi, sganciandosene, dalla forma-Stato19. Per le Costituzioni civili o sociali il problema della legalità, ammesso che ancora si ponga, si affaccia infatti in modo nuovo. Se la difesa della Costituzione è sempre difesa partigiana della Costituzione materiale è soltanto in questa dialettica che ne va della legalità. La forma costituzionale è la sintesi più alta di questa sistole e diastole dell’ordinamento che è il rapporto, storicamente determinato, tra legalità e legittimità. Con una formula: occorre pensare una Costituzione per le forme di vita contemporanee; e sarà l’ecologia di queste ultime che dovrà dettarne il ductus e la morfologia: essa sarà europea e sarà postcoloniale20. Perchè non si parla di forma senza soggetti né si parla di Costituzione senza processi costituenti. Ma il costituente non è mai, e per definizione, legale. Solo il costituito lo è. Come nella Calcutta di Chatterjee così nelle metropoli europee, le forme di vita contemporanee «non esprimono la spontaneità di una società costitutivamente impolitica; al contrario, incarnano il costituirsi continuo di soggettività e problemi collettivi (o “comuni”) che rompono per ogni lato i confini di una natura del politico tenacemente identificata, in ultima analisi, col perimetro della statualità; ed instaurano al contempo relazioni tanto duramente negative, quanto all’occorrenza positive (in tal senso “opportunistiche”) con le articolazioni istituzionali di quest’ultimo»21. Dalla crisi della legalità, che è la crisi della legittimità, che è la crisi della Costituzione, che è la “crisi”, non si esce dunque che attraverso un nuovo processo costituente. Un processo che non abita nell’essere né nel dover essere ma nel potrebbe essere del comune.
C. Schmitt, Legalità e legittimità, in Id., Le categorie del ‘politico’, il Mulino, Bologna 1998, pp. 211-244. ↩
P. Costa, D. Zolo, (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Feltrinelli, Milano 2002. ↩
C. Schmitt, La rivoluzione legale mondiale, in Id., Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste, Neri Pozza, Vicenza 2012, pp. 187-215. ↩
P. Calamandrei, Non c’è libertà senza legalità, Laterza, Roma-Bari 2013. ↩
L. Ferrajoli, Dei diritti e delle garanzie, il Mulino, Bologna 2013. ↩
O. Kirchheimer, Legalità e legittimità, in Id., Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale, De Donato, Bari 1982, p. 117. ↩
Ibidem ↩
U. Mattei, L. Nader, Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali, Bruno Mondadori, Milano 2010. ↩
O. Kirchheimer, Legalità e legittimità, in Id., Costituzione senza sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale, De Donato, Bari 1982, p. 127. ↩
Ivi, p. 130 ↩
E. Peñalver, S. Katyal, Property Outlaws: How Squatters, Pirates, and Protesters Improve the Law of Ownership, Yale University Press, New Haven 2010. ↩
P. Chatterjee, Oltre la cittadinanza. La politica dei governati, Meltemi, Roma 2006. ↩
G. Lukács, Legalità ed illegalità, in Id., Storia e coscienza di classe, Sugar Editore, Milano 1970, p. 326. ↩
L. Liang, «Porous Legalities and Avenues of Participation», in Sarai Reader 05, Sarai Media Lab, Delhi 2005, pp. 6-17. ↩
Ivi, p. 15. ↩
G. Agamben, Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi, Laterza, Roma-Bari 2013; M. Cacciari, Il potere che frena, Adelphi, Milano 2013. ↩
C. Mortati, La Costituzione in senso materiale, Giuffré, Milano 1998. ↩
U. Mattei, Contro riforme, Einaudi, Torino 2013. ↩
A. Negri, La forma Stato. Per la critica dell’economia politica della Costituzione, Dalai, Milano 2012. ↩
S. Mezzadra, La condizione postcoloniale. Storia e politica nel presente globale, ombre corte, Verona 2008. ↩
L. Ferrari Bravo, Costituzione e movimenti sociali, in Id., Dal fordismo alla globalizzazione. Cristalli di tempo politico, manifestolibri, Roma 2001, pp. 254-255. ↩