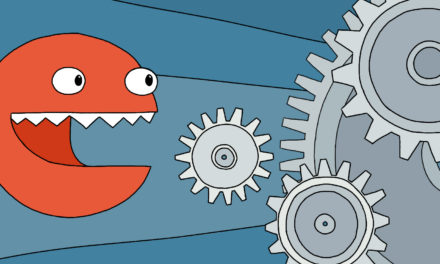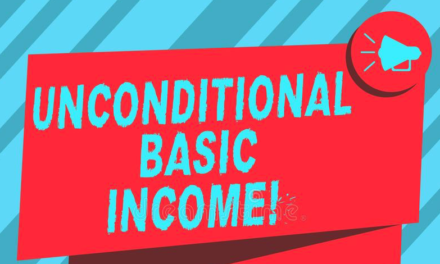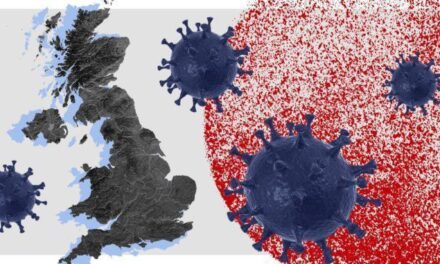Di MADDALENA FRAGNITO
Quando l’essenziale è invisibile agli occhi è il risultato di precise scelte politiche che organizzano e determinano le nostre vite mettendo la riproduzione e la cura di corpi e ambiente tra le ultime delle priorità. La cura è da sempre una relazione conflittuale tra esseri viventi, spazi e tecnologie. I corpi non sono nuda vita ma vestiti di sessualità, genere, razza, classe sociale, abilismo ed età. Vestiti che garantiscono o meno l’accesso e il diritto alla stessa cura. C’è chi cura e chi si fa curare, e c’è chi cura e non può essere curat@.
In questi giorni, il concetto di “lavori essenziali” è entrato con forza nel dibattito pubblico. Questa nuova centralità può aiutare a ribadire come tutti i lavori legati al mantenimento della vita siano condizione di esistenza e continuità della società tutta, a ripetere come da sempre siano stati attraversati da forme più o meno visibili di sfruttamento, infine, a ricordare come la loro privatizzazione (e platformizzazione) non abbia fatto altro che continuare a garantire, a pochi soggetti, un’immane ricchezza estorta. Eppure, la possibilità di decidere cosa sia un lavoro essenziale è un fatto profondamente politico che anche oggi resta nelle mani di pochi governatori.
Così, il dibattito intorno ai lavori essenziali continua a mostrarci uno spazio attraversato da ingiustizie e da possibili conflitti politici. Ma la centralità e l’importanza di questo argomento è più che mai attuale, non soltanto in relazione alla gestione di nuovi focolai, piuttosto come nesso radicale attorno cui ripensare un presente possibile. Il nesso attraverso cui disegnare una “fase 2, 3, 4” dove il culto della crescita infinita procede indiscusso, o lascia spazio a una riflessione intorno alla giustizia, alla finitezza dei corpi e del pianeta, e alle nostre inter-responsabilità. Cosa sia essenziale, cosa no e per chi, appare quindi come la possibilità di agire un dopo diverso dal prima, proprioperché apre una riflessione intorno alla salute e al benessere di tutte e di tutti, e un conflitto intorno alla priorità della vita umana rispetto all’economia. Curare e curarsi, ovvero la capacità di tenere in vita la vita, diventa un lavoro sempre più conflittuale: la cura è la lotta contro le necropolitiche in corso, e la lotta è la cura per la redistribuzione della vita. Non è un caso che anche questo termine sia entrato con forza – e nel peggiore dei modi – nel dibattito pubblico di questi giorni. Quotidianamente, infatti, nuovi esperti della cura ci indicano i modelli da attuare per riportare tutto a com’era prima. Sono modelli di cura del profitto di una specifica classe sociale, schemi per riattivare il passato senza alcuna riflessione sulle ragioni di ciò che è accaduto, né su cosa sia essenziale, appunto, in prospettiva. Così, da una parte, ci sono veloci soluzioni imposte con lo spettro della crisi economica, dall’altra, c’è una pandemia: l’azione di un’entità biologica che ci sta dando la possibilità di aprire una riflessione articolata e duratura intorno alle ragioni della cura.
Questo contesto generale, ovvero quello che potrebbe essere analizzato come un vero e proprio conflitto tra modelli di cura, si è riproposto allo stesso modo nello specifico dell’assistenza sanitaria, basti pensare alle numerose voci che si sono alzate dalle corsie degli ospedali lombardi in questi ultimi due mesi.
6 marzo 2020, Documento della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI):
“In una situazione così complessa, il medico può trovarsi a dover prendere in breve tempo decisioni laceranti da un punto di vista etico oltre che clinico: quali pazienti sottoporre a trattamenti intensivi quando le risorse non sono sufficienti per tutti”.
12 Marzo 2020, Lettera anonima delle addette alle pulizie degli ospedali di Bergamo:
“Siamo le lavoratrici invisibili. Siamo quelle che si alzano alle 5 del mattino, ma nessuno ci vede. Lasciamo solo il nostro passaggio di pulizia, spesso scontato. Come se non fosse così importante. Anche noi ci siamo.”
24 Marzo 2020, Lettera dei medici di Bergamo:
“Stiamo imparando che gli ospedali possono essere i principali veicoli di trasmissione del Covid-19, poiché si riempiono rapidamente di malati infetti che contagiano i pazienti non infetti. Lo stesso sistema sanitario regionale contribuisce alla diffusione del contagio, poiché le ambulanze e il personale sanitario diventano rapidamente dei vettori. I sanitari sono portatori asintomatici della malattia o ammalati senza alcuna sorveglianza.”
18 Aprile 2020, 100.000 medici scrivo al Ministro Speranza:
“Lo chiediamo, indipendentemente dagli schieramenti politici e/o da posizioni sindacali, lo chiediamo come Medici che desiderano ed esigono svolgere il proprio ruolo attivamente ed al meglio, dando un contributo alla collettività nell’interesse di tutti.”
Anzitutto, queste parole smascherano la propaganda agita dalla maggioranza di centrodestra che guida la Giunta regionale lombarda, raccontando l’evidente fragilità, sul fronte gestionale e organizzativo, del modello di cura adottato dalla Lombardia durante l’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Un modello che, inserito in un contesto istituzionale in base al quale le Regioni programmano e gestiscono in autonomia la sanità, ha portato a un risultato difficile da nascondere: il “motore industriale” dell’Italia è l’area più colpita dal Covid-19 a livello europeo, con più di diecimila vittime e decine di migliaia di infettat@. La gravità dei casi trattati in Lombardia non ha fatto che acuirsi, portando il numero dei decessi a circa cinque volte quelli della media nazionale, mentre il personale sanitario si è trovato a combattere l’infezione con rischi e sacrifici personali enormi. Dei circa 21.000 operatori sanitari risultati positivi al SARS-COV-2 (di cui il 66% sono donne) il tasso di infezione lombardo è di 19,1 volte superiore alla media nazionale. Degli oltre 185 decessi tra il personale medico italiano, oltre 90 sono morti in Lombardia. Più che un “modello”, la Lombardia è diventata un caso di studio e un esempio da evitare per qualunque altro sistema sanitario.
Inoltre, queste parole rappresentano una forte denuncia nei confronti della gestione della crisi sanitaria e degli attuali limiti infrastrutturali e organizzativi della sanità regionale. Le difficoltà raccontate dimostrano come la sanità in Lombardia sia un buon esempio di ciò che viene definita come la “crisi della cura”, ovvero quel modello neoliberale di privatizzazione dei servizi alla persona che, in particolare negli ultimi 30 anni, si è basato sull’erosione dei finanziamenti pubblici e dell’idea stessa di salute accessibile e democratica. Sono parole che ci spingono a riflettere sul fatto che la privatizzazione della sanità ha voluto dire trasformare il diritto alla salute in una merce – in uno stile di vita che possiamo permetterci o meno – e ha ridotto gli investimenti e l’impegno per la prevenzione, ovvero la pratica intorno a cui si istituisce il Servizio Sanitario Nazionale nel 1978[1]. Non possiamo dimenticare che la storia della nascita della Riforma Sanitaria sia cominciata con la Resistenza (proposta del CLN Alta Italia, 1944) e abbia attraversato il movimento operaio e sociale degli anni ’70. Una storia che ha portato all’istituzione di servizi e strutture per la salute di cittadine e cittadini come la prevenzione nei luoghi di lavoro, per la salute delle donne, per l’igiene pubblica e ambientale, per la salute mentale, per le tossicodipendenze e per la medicina in età scolastica. Nel 1997, però, la Lombardia compie una svolta sostanziale, seguendo un modello pensato per rendere sempre più facile l’accesso dei privati al Servizio Sanitario regionale. “La Giunta Formigoni si ispirò alla riforma avviata alcuni anni prima nel Regno Unito: decise di separare anche in Lombardia le funzioni che prima erano integrate, in modo che la funzione di erogazione potesse essere affidata sempre di più al privato. La Regione, a iniziare da quel periodo, ha cominciato a programmare e, soprattutto, a comprare servizi sia dalle strutture pubbliche lombarde (trasformate in ‘aziende’ gestite con un metodo sempre più manageriale e definite ‘autonome’ in modo improprio) sia da imprese private, che ovviamente entrarono nel mercato sanitario con un orientamento basato sul profitto”, sostiene Maria Elisa Sartor, professoressa a contratto nel Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano. È proprio questo processo che ha determinato lo smantellamento graduale della medicina sociale, ovvero del servizio territoriale di indagine tra sintomatologie diffuse e cause comuni.
Infine, sempre queste parole suggeriscono altre possibili strategie di cura per affrontare la crisi. Sono soluzioni che dimostrano come il modello di cura neoliberale crolli quando la salute-merce diventa più cara del margine di profitto, quello che è accaduto durante questi mesi. I grandi ospedali privati, infatti, costruiti come cattedrali nel deserto, non sono in grado di gestire un’emergenza sanitaria, perché la medicina stra/ordinaria, quella con meno margine di profitto, rimane per la maggior parte nelle competenze del servizio pubblico. Si evidenziano quindi i limiti del sistema sanitario attuale: quello pubblico, degradato negli anni dai tagli in finanziamenti e operatori; quello privato, attento esclusivamente all’utilizzo della malattia e dei servizi sanitari e farmaceutici a scopo di profitto. Si esplicita così l’inefficienza di un servizio sanitario misto come quello lombardo, basato sull’ospedalocentrismo e sull’ideologia del “competere è meglio che cooperare”. In questo senso, un’ulteriore indicazione che arriva da queste denunce è la necessità di un approccio alla cura basato non più sulla centralità della persona ma della comunità. Un cambio di prospettiva che richiede grossi investimenti nella salute pubblica e nello studio delle epidemie.
Nonostante tutto quello che è successo, è quello che non sta succedendo a preoccupare di più. Le condizioni create dalla pandemia ci mostrano come le lavoratrici e i lavoratori del settore sanitario abbiano gestito in prima linea l’emergenza nella totale mancanza di ascolto, trattat@ come fossero sacrificabili più che essenziali. Una mancanza che ci ha portato ad aprire la “fase 2” senza alcun ripensamento sugli errori fatti e senza nessuna inversione di rotta, come, per esempio, una veloce e strutturale riattivazione della medicina territoriale: l’unico strumento possibile per attraversare la pandemia grazie a test, tracciamenti e un sistema di cura a domicilio – se non si vuole andare avanti per sole restrizioni e responsabilità individuali.
Proprio a partire dalla necessità di prendere sul serio i tanti comunicati scritti dalle diverse categorie del servizio sanitario lombardo, è nata la campagna #OraACasaRestateciVoi. Una raccolta di dati e testimonianze che prova a mettere in fila gli errori fatti dai governatori di Regione Lombardia e che ne chiede le immediate dimissioni. La campagna, inoltre, auspica un profondo cambio di rotta. Come suggerito da Medicina Democratica nel lancio di un nuovo coordinamento nazionale, bisogna infatti “riprendere il filo del discorso di una prevenzione che parta dal territorio quale sistema unitario e olistico di ambiente salubre, luoghi di lavoro sicuri e idonee condizioni di vita ovunque”. Per il Movimento di Lotta per la Salute nato nel 1978, la riapertura delle aziende deve coincidere con l’adozione di una organizzazione del lavoro, a partire dalla riduzione degli orari, per perseguire il benessere di lavoratrici e lavoratori.
Anche qui, per uscire da un’emergenza strutturale,
l’urgenza è determinata dalla nostra capacità, oggi, di decidere cosa sia
essenziale, cosa no e per chi.
[1] “La legge 833 nonostante i limiti e le contraddizioni, può permettere la creazione di un sistema basato sull’approccio preventivo, anche per quanto riguarda la cura e la riabilitazione, capace di autoregolarsi rispetto alla ricerca, alla conoscenza, al controllo, alla eliminazione dei rischi e dei danni più gravi e più diffusi che interessano i lavoratori e la popolazione. Per avviare questo processo di progressiva sostituzione del vecchio assetto sanitario basato sull’approccio individuale e privatizzato della malattia, fatto di domande di intervento sparpagliate ed incontrollabili, sia per quanto riguarda l’efficacia degli interventi stessi, sia per quanto riguarda la spesa, con un sistema basato sulla programmazione, la prevenzione e la partecipazione, occorre una grande mobilitazione ed una grande iniziativa di popolare e di massa… La Federazione CGIL-CISL-UIL assuma e colmi il vuoto legislativo di strutture partecipative, avviando a soluzione il problema scientifico della individuazione, del controllo e dell’eliminazione partecipata dei rischi e dei danni, tramite la costituzione di comitati di partecipazione come prima aggregazione nel territorio della USL di tutti coloro che hanno esperienza dei luoghi di vita e di lavoro nella lotta contro la nocività…” (Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL – Convegno di Ariccia 27/28 febbraio 1979).
Questo articolo è stato pubblicato su milano in movimento l’8 maggio 2020.