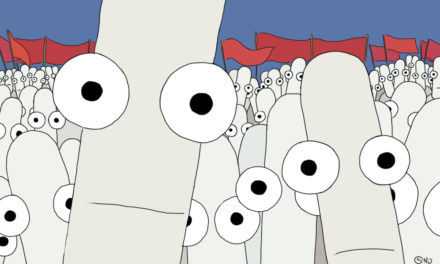di MARCO BASCETTA*. Sarebbe difficile, al giorno d’oggi, scovare nelle opinioni pubbliche di gran parte dei paesi europei un numero rilevante di convinti sostenitori del trattato di Maastricht e della sua discendenza normativa. Perfino tra i proverbiali pensionati tedeschi, incrollabili paladini della stabiltà, non vi sarebbe entusiasmo unanime. Ma poco importa poiché il trattato, e le tecnologie di governo che ne discendono, si presentano come un «sistema impersonale di regole» in nessun modo bisognoso di consenso. Per quelli che ci credono è sufficiente l’atto di fede, per gli altri, i molti che dai più diversi versanti contestano la governance europea, i rapporti di forza (che costituiscono indubbiamente un dato oggettivo) non consentono che un assoggettamento accompagnato da qualche modesta contrattazione ai margini.
Il trattato, ci spiegano gli autori di questo utile volume collettivo (A. Barba, M.D’Angelillo, S.Lehndorff, L.Paggi,A.Somma, Rottamare Maastricht, Deriveapprodi, pp.186, Euro 13) contiene infatti tutti i principi e i parametri inviolabili delle politiche neoliberiste (dove il neo sta a indicare il rinnovato vigore con cui sono tornate a dominare la scena negli anni Ottanta). Ma soprattutto, ciò che contraddistingue i Trattati è l’essere posti al riparo da ogni interferenza di natura democratica.
Tutti ricordano la risposta perentoria del ministro Wolfgang Schaeuble a chi, sulla base dei risultati elettorali in Grecia, chiedeva un passo indietro della Troika rispetto alle pretese avanzate nei confronti di Atene: «nessun responso elettorale può cambiare le regole!» Ma a quale mondo e a quale cultura appartengono questi sacerdoti del rigore, questi chierici della rendita finanziaria?
Leonardo Paggi li considera liberi da ogni riferimento specifico a gruppi, bisogni sociali o territori. Indifferenti e separati dal concreto e dalla storia. Portatori di un pensiero matematizzato, astratto e innervato da una caparbia pretesa universalistica. Di certo sono usciti, insieme alle oligarchie alle quali rispondono, da quello che siamo soliti chiamare «patto sociale». Ne sono usciti «dall’alto», ma non fuori dalla storia. 
I critici del neoliberalismo e delle enormi diseguaglianze che esso determina, sono soliti denunciare le contraddizioni interne del sistema e le insuperabili tendenze perverse dell’accumulazione. Ma non volendosi compromettere troppo con il marxismo si tengono alla larga dalla teoria e dall’esperienza storica della lotta di classe. Questo impedisce di vedere come il «sistema impersonale di regole» si sia affermato sul campo in un duro e lungo scontro tra l’egemonia montante delle oligarchie finanziarie e i movimenti operai e democratici. L’Europa è stata edificata per intero all’interno di questa storia, secondo il paradigma imposto da chi ne era uscito vincitore.
Una storia che, però, si era già dipanata all’interno dei singoli stati nazionali europei (e non solo) la cui conversione, senza residui, al neoliberismo e alla competitività non è stata imposta dall’esterno, da un disincarnato «capitalismo planetario» o dalle dinamiche astratte della globalizzazione, ma imposta dagli interessi delle élites nazionali ,inserite, beninteso, in una rete di alleanze e complicità sovranazionali. Alla firma del Trattato di Maastricht la sovranità popolare inscritta nelle Costituzioni europee era stata già ampiamente svuotata del suo contenuto e delle soggettività politiche che ne erano state il motore. Se l’Europa poteva essere «concepita come un unione di Stati che competono l’uno con l’altro come se fossero aziende» (S. Lehndorff) è perché la fusione tra politica ed economia nelle diverse realtà nazionali aveva già assunto la forma dell’organizzazione aziendale e adottato il calcolo costi\benefici che le è proprio.
L’idea che possano darsi singole sovranità nazionali che isolatamente sappiano contrapporre valori democratici e progresso sociale a questi principi di competitività è oggi fuori dalla storia reale e dai rapporti di forze che attualmente ne determinano il corso. Incombe invece, sempre più minacciosa, quella esaltazione dell’ interesse o «priorità nazionale» che si presenta come conflitto «tra nazioni» con forti richiami identitari. O come rifiuto dell’Unione europea, ritenuta un mero strumento nelle mani dei poteri e delle economie più forti, se non in quelle di una malvagia cospirazione cosmopolita.
Ora, se è pur vero che l’Unione presenta un centro e una periferia, paesi egemonici e paesi subalterni, squilibri che le «regole» del mercato unico si incaricano di perpetuare, è anche vero che questi squilibri, che attraversano più o meno intensamente tutte le realtà nazionali, possono essere interpretati e affrontati politicamente in termini diversi da un funesto scontro tra nazioni. Non giocando cioè la sovranità nazionale contro l’integrazione europea, ma cercando di indirizzare quest’ultima contro le classi dirigenti nazionali che la tengono in ostaggio.
È una doppia, ardua partita, quella che un movimento democratico europeo si trova a dover giocare: contro l’ordine sovranazionale della rendita finanziaria e contro il ritorno di un nazionalismo aggressivo che pretende di costituirne l’unica possibile alternativa.
*questo articolo è stato pubblicato da il manifesto il 13 dicembre 2016.