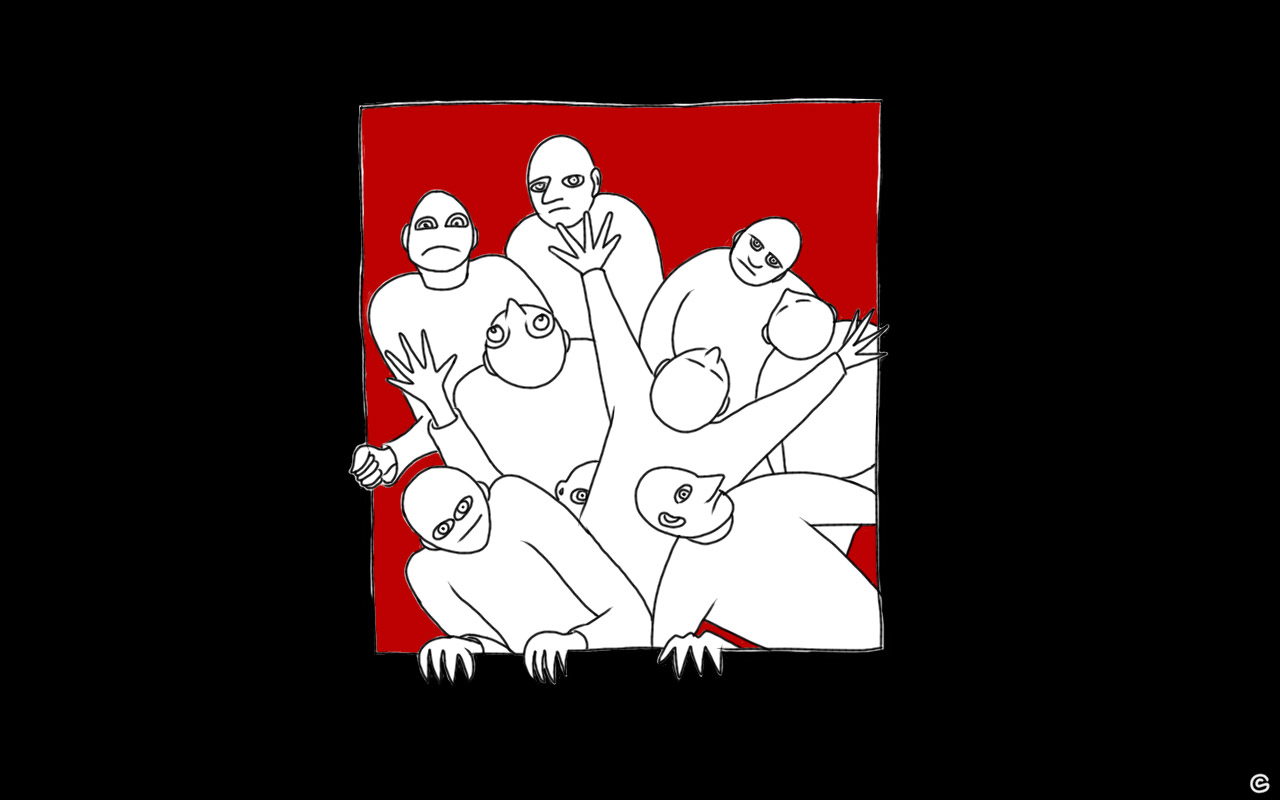di GISO AMENDOLA.
Quando si dice che ogni discorso è un discorso collocato, molto spesso è fondamentale proprio la sua collocazione nel senso più letterale, lo spazio geografico da cui si parla. Questo Genealogie della modernità. Teoria radicale e critica postcoloniale, a cura di Carmine Conelli ed Eleonora Meo (Meltemi, pp. 408, € 24) si apre dichiarando il suo luogo di enunciazione: nasce dai seminari organizzati dal collettivo Deconow, presso l’Università Orientale di Napoli, ed è concepito a partire «dall’angolazione geo-politica in cui siamo posizionati, ovvero dal sud dell’Europa».
Dalla frontiera mediterranea, sempre più drammaticamente decisiva nella crisi europea, il collettivo propone con molta nettezza la sua chiave critica: eurocentrica è l’idea stessa di modernità, il cui nesso con il colonialismo non è accidentale, ma costitutivo.
L’introduzione di Conelli e Meo mette in campo, in un diretto confronto con il pensiero critico europeo, tutto il laboratorio della critica decoloniale latinoamericana. La «linea di demarcazione» della modernità è così fissata al 1492: l’intera impalcatura del razionalismo occidentale ha la sua origine nella violenza coloniale. Come scrive Enrique Dussel, è l’ego conquiro (l’io conquisto) che anticipa l’ego cogito cartesiano. La colonialità del potere (definizione di Anibal Quijano) accompagna continuamente i processi capitalistici di estrazione del valore: per quanto il capitale si autodescriva come rapporto di scambio tra soggetti formalmente liberi, lo sfruttamento globale si costituisce insieme all’uso del dispositivo della razza per gerarchizzare le differenze. La violenza razzista e coloniale struttura lo stesso soggetto del pensiero e della politica: un soggetto maschio eteronormato, bianco, autoctono, proprietario.
Non si tratta però solo di decostruire questa ragione coloniale, ma anche di operare un delinking, per dirla con Walter Mignolo, cioè uno sganciamento dalla struttura coloniale del pensiero. Uno sganciamento che investe ovviamente anche il marxismo, per il suo rapporto ambivalente con la modernità occidentale, e gli stessi studi postcoloniali, posizionati comunque all’interno dell’ambiente culturale poststrutturalista anglofono e francofono, mentre la svolta decoloniale mira a far emergere luoghi di enunciazione completamente altri. Il libro struttura questo serrato confronto con la teoria euro-occidentale, affidando nove figure centrali ad altrettante voci di diversi orientamento. Mezzadra «attraversa» Marx, Visentin Fanon, Chignola Foucault, Baritono Davis, Frosini Gramsci, Curti de Beauvoir, Iuliano Spivak e Aramini Lacan.
Gli interventi di Deconow (Rizzo, Mercone, Gatta, Miele, oltre ai curatori) replicano alle presentazioni, tracciando diverse traiettorie di decolonizzazione del sapere. L’effetto è molto interessante proprio perché il campo resta animato da tensioni mai occultate.
Per esempio: «distendendo» Marx, come voleva Fanon, lungo il mercato globale, appare come la violenza razzista e coloniale, costitutiva del comando del capitale, riconduca tutta una varietà di forme e di tempi al codice egemonico della modernità occidentale (Rizzo); allo stesso tempo, però, le operazioni del capitale non sono mai linearmente uniformanti, poiché entrano sempre in relazioni specifiche con l’eterogeneità delle figure soggettive che compongono la forza lavoro (Mezzadra). Ancora: l’umanesimo di Sartre è certamente un limite che separa il Sartre dell’impegno politico anticolonialista dal Sartre filosofo che lavora ancora dentro il sapere dei colonizzatori (Rizzo), ma allo stesso tempo il suo esistenzialismo si spinge sino a segnare una «nausea» che investe il cuore dello storicismo europeo (Mellino).
E soprattutto: se il black feminism fa esplodere non solo il soggetto della modernità, ma anche la sua persistenza all’interno dello stesso femminismo bianco (Miele), una lettura come quella che Curti offre di Simone de Beauvoir, enfatizzandone il momento del divenire-donna e mostrandone le derivazioni inattese, per esempio, nelle teorie queer, spiazza qualsiasi linearità nelle genealogie. Che è un effetto importante, e forse esso stesso inaspettato, del libro: se infatti l’esercizio di decolonizzazione del pensiero ha una grande forza di impatto nel rompere il canone occidentale, corre però il rischio di costruire un’immagine altrettanto unitaria e solida della modernità, semplicemente ribaltata rispetto alla sua autonarrazione. Il confronto teso e non pacificato tra prospettiva decoloniale, approcci postcoloniali e teoria critica occidentale, restituisce invece alle genalogie una costitutiva pluralità, gli «altri accenti e ritmi» su cui insiste Chambers nella postfazione: una pluralità che ha molto a che fare con la necessità politica di radicare la critica della costitutiva violenza del capitale nell’eterogeneità dei dispositivi di assoggettamento come nella molteplicità delle pratiche di liberazione.
questa recensione è stata pubblicata sul manifesto del 21 marzo 2018