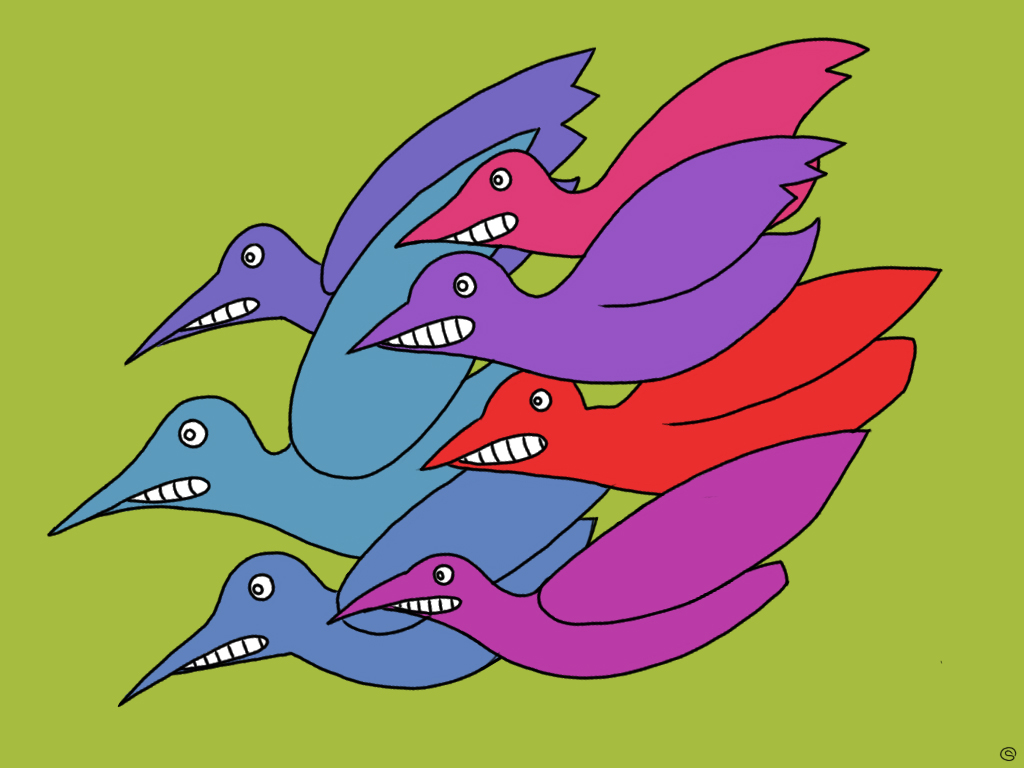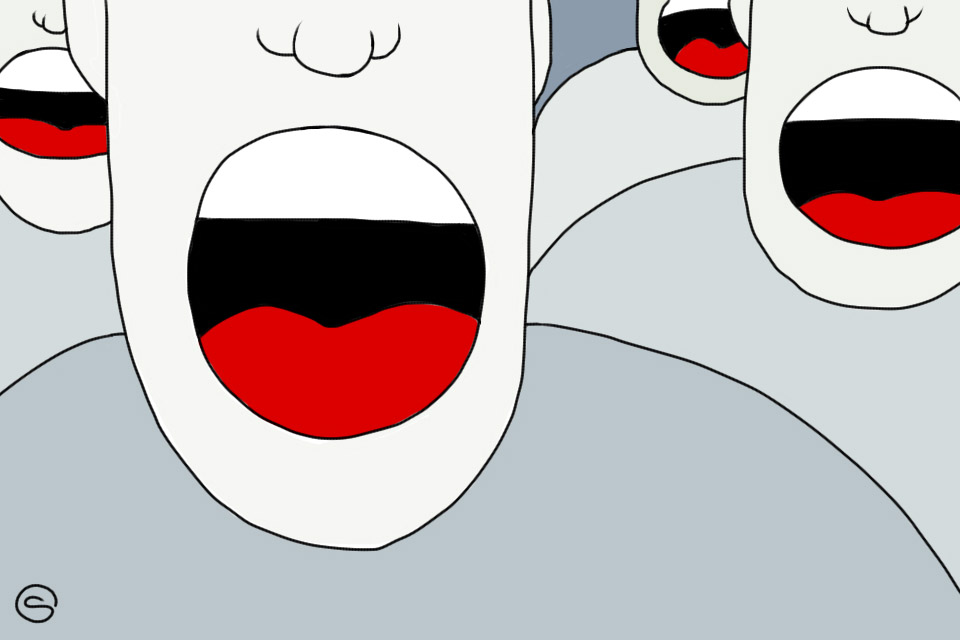Di SANDRO MEZZADRA
Molte lettrici ricorderanno The Spirit of ’45, il documentario di Ken Loach (2013) dedicato all’edificazione dello Stato sociale britannico letteralmente sulle macerie della Seconda guerra mondiale. Edilizia popolare, sanità pubblica, istruzione furono gli assi fondamentali dell’azione del governo laburista di Clement Attlee, che inventò un modello di Welfare state democratico attorno alle cui linee di fondo si determinò nei decenni successivi un consenso di massima tra le forze politiche e sociali in Gran Bretagna. Il documentario di Loach si conclude con la vittoria elettorale di Margaret Thatcher nel 1979, ovvero con la fine di quel consenso e con l’avvio dell’egemonia neoliberale.
Si tratta di una vicenda che ha naturalmente le sue peculiarità in Gran Bretagna, ma che è tuttavia parte di un più generale ciclo politico che vide nuove politiche sociali caratterizzare l’azione dello Stato in Europa occidentale nel secondo dopoguerra (con alle spalle l’esperienza del New Deal rooseveltiano negli USA). La stessa reazione neoliberale non può certo essere limitata a singoli Paesi. E oggi, quantomeno in Europa, la pandemia ha rimesso al centro del dibattito politico proprio la questione del Welfare, a partire dalla salute e dall’istruzione. Si può anzi pensare che anche in Italia il Welfare sia destinato a costituire un terreno cruciale di scontro e di mobilitazione nei prossimi mesi e anni, già attorno alle decisioni che verranno prese sull’uso delle risorse europee. Occorre dunque aggiornare la riflessione attorno a questo tema, ripensando le politiche sociali e lo stesso concetto di Welfare (“benessere”) alla luce delle profonde trasformazioni intervenute negli scorsi decenni e delle stesse sfide poste dalla pandemia.
Un contributo importante in questo senso è offerto da un libro di Ursula Huws, Reinventing the Welfare State. Digital Platforms and Public Policies (Pluto Press, pp. 209, 20,79 euro). Il punto di partenza della sua analisi è precisamente il modello di Stato sociale a cui è dedicato il documentario di Ken Loach. “Lo Stato sociale di metà Novecento”, scrive Huws “gioca un ruolo potente nell’immaginario socialista”: ed è certo un’affermazione che non vale soltanto per la sinistra britannica, considerata la frequenza con cui anche in altri Paesi europei la critica del neoliberalismo assume implicitamente o esplicitamente come alternativa proprio il “ritorno” allo Stato sociale “fordista”.
È tuttavia, secondo Huws, precisamente ciò che oggi occorre evitare. Il Welfare state novecentesco costituisce un modello improponibile sia perché sono venuti i suoi presupposti materiali (per quel che riguarda i rapporti di lavoro e la composizione di quest’ultimo) sia perché quel modello non può essere “romanticizzato” (se non al prezzo di dimenticare i suoi aspetti disciplinari e familisti, nonché le molteplici esclusioni su cui si fondava). Da questo secondo punto di vista, Huws si sofferma efficacemente sulla critica rivolta al Welfare state in Gran Bretagna dai movimenti sociali degli anni Sessanta e Settanta – e in particolare sui temi posti dal femminismo della “seconda ondata”, dalla divisione sessuale del lavoro all’interno della famiglia al lavoro domestico, dalla riproduzione sociale alla cura.
Una “reinvenzione del Welfare state” non può che prendere le mosse da una realistica analisi delle dinamiche del mercato del lavoro e delle figure soggettive che al suo interno si muovono. La prospettiva di Huws mette in evidenza come in Gran Bretagna, ma certo non solo lì, si sia assistito negli ultimi decenni alla progressiva erosione di quel “rapporto di lavoro standard” (fondato su contratti regolari e permanenti) che rappresentava il riferimento normativo tanto per il diritto del lavoro quanto per le politiche di welfare. Impegnata da molti anni nello studio del “lavoro digitale”, Huws si sofferma qui in particolare sul “lavoro di piattaforma”, che indipendentemente dal suo rilievo statistico le pare indicare un insieme di tendenze che stanno ridefinendo l’organizzazione del lavoro nel suo complesso. Collocati sul crinale tra autonomia e dipendenza, su cui le grandi piattaforme realizzano i propri profitti, i lavoratori di piattaforma riflettono una nuova economia della povertà e sono caratterizzati da fluttuazione ed eterogeneità nella loro composizione. Le loro rivendicazioni e i loro bisogni mostrano i limiti dei sistemi tradizionali di contrattazione collettiva, che dovrebbero essere integrati a giudizio di Huws da “diritti generalizzati per tutti i lavoratori a tutele sul lavoro e da un minimo salariale stabilito a livello nazionale”.
È così indicato il primo, fondamentale, asse di una “reinvenzione” del Welfare state (valido per Huws ben al di là dei lavoratori di piattaforma e anzi da porre come base di una “nuova carta universale dei diritti”). Particolarmente interessante mi pare, anche considerando il dibattito italiano, la proposta di combinare contrattazione collettiva e minimo salariale (un minimo salariale “universale” e “alto”), assumendo il secondo strumento per intervenire sui limiti del primo. In questione è la conquista di potere da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che vivono condizioni di subordinazione – un potere di parte che costituisce la base necessaria per allargare gli spazi di democrazia all’interno di un Welfare state che le politiche neoliberali (di Thatcher così come di Blair) hanno ridotto a funzioni meramente assistenziali, secondo una logica punitiva e disciplinare. Nella medesima direzione va anche la proposta di un “reddito universale di base”, che Huws articola in modo dettagliato (tra l’altro ponendone in evidenza una genealogia femminista) e che costituisce in qualche modo il secondo asse della “reinvenzione” del Welfare state.
Ci sono molti altri aspetti interessanti in questo libro, ad esempio un’ampia analisi dell’“uguaglianza di genere” nelle politiche di welfare (svolta sottolineando in particolare il rilievo e le implicazioni della “mercificazione del lavoro domestico”) e una riformulazione dei principi generali delle politiche redistributive che devono costituire la necessaria base di un Welfare state espansivo. Quest’ultimo punto è tanto più importante laddove si consideri che, come Huws dimostra, quattro decenni di politiche neoliberali hanno stravolto il funzionamento dello Stato sociale britannico, trasformandolo in “uno Stato che redistribuisce ricchezza dal lavoro al capitale”. Un aspetto particolarmente originale è poi l’ipotesi, saggiata in un intero capitolo, che sia possibile un uso delle piattaforme digitali, evidentemente riorganizzate rispetto al modello proprietario dominante, per “ottimizzare la redistribuzione delle risorse digitali, per migliorare i servizi di welfare esistenti e per svilupparne di nuovi a livello locale”. È certo un punto da articolare ulteriormente: mi sembra tuttavia molto interessante perché, oltre a contrastare le derive burocratiche dello S tato sociale, interviene sul tema della “digitalizzazione” della pubblica amministrazione sottolineando il ruolo costitutivo della partecipazione e dell’autorganizzazione dal basso.
Scritto nei mesi che hanno preceduto le elezioni britanniche del 2019, il libro di Ursula Huws è stato rivisto dopo l’inizio della pandemia. Molti sono i riferimenti agli effetti di quest’ultima, per quel che riguarda sia le condizioni dei lavoratori di piattaforma sia la moltiplicazione di iniziative mutualiste e di solidarietà, spesso organizzate online. Alla fine del lavoro, prevale una nota di ottimismo: “idee che sembravano utopistiche nella prima bozza”, scrive Huws, “sembrano oggi più realistiche e realizzabili”. Non so se condividere questo ottimismo: certamente, però, questo libro offre prospettive originali su un tema oggi cruciale. Sull’esito delle idee e delle proposte in esso contenute saranno le lotte dei prossimi mesi a decidere.
Questo articolo è stato pubblicato il 26 novembre 2020 su il manifesto.