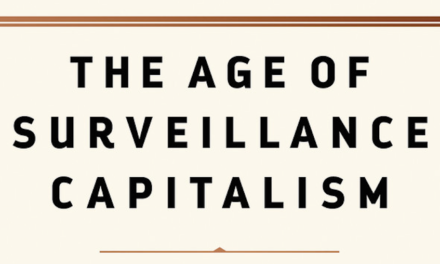Di BIAGIO QUATTROCCHI e FRANCESCO RAPARELLI
1. In un testo di transizione, ma ancora mosso dal desiderio di ricostruire «la storia interna della classe operaia», Mario Tronti propone una lettura originale delle lotte americane degli anni Trenta e Quaranta dello scorso secolo. Per un verso, e già a partire dal 1916, censisce l’uso operaio della catastrofe bellica: scioperi in abbondanza che chiedono aumenti salariali, e li ottengono, costellano negli USA tanto la Prima che la Seconda guerra mondiale. Ma la fine della Grande Guerra, dopo un ciclo vincente di lotte, porta con sé sconfitte tragiche e, dopo il 1919, la violenza padronale contro “rossi” e sindacalisti rivoluzionari. E gli anni Venti – «l’età del jazz» raccontata magistralmente da Francis Scott Fitzgerald – sono segnati da una ripresa in forza dei profitti, che «traboccano» nella società pacificandola ulteriormente e alimentando la speculazione più selvaggia.
D’improvviso il 1929, il crollo finanziario e con esso la Grande Depressione. È nel tentativo di comprendere quest’ultima che Tronti suggerisce una posizione per alcuni versi contraddittoria con quanto in precedenza teorizzato: «È ovvio dire che gli operai non hanno voluto la crisi. Molto meno ovvio, e anzi un po’ scandaloso, è sostenere che la crisi non fu il prodotto delle lotte operaie, ma della passività operaia». Indubbio un certo afflato dialettico. Poche righe prima infatti leggiamo: «Le lotte operaie sono un insostituibile strumento di autocoscienza del capitale». Eppure la mossa pare feconda, e utile per afferrare alcuni tratti distintivi della crisi esplosa nel 2008, e da allora mai sopita. Sarebbe sbagliato affermare che il movimento alterglobale e le tante lotte giovanili del primo decennio del nuovo millennio non abbiano in alcun modo condizionato l’iniziativa capitalistica. Non possiamo di certo affermare, però, che siano stati gli scioperi del lavoro precario a far esplodere la bolla dei mutui subprime. Precarie e precari, semmai, hanno preferito la fuga – pensiamo all’esodo della forza-lavoro qualificata dal Sud al Nord Europa. Senza esagerare con la comparazione storica, possiamo asserire che la crisi (oramai) permanente che ci perseguita dal 2008 è stata sollecitata da un eccesso di comando capitalistico sulla società. O anche, ma non si tratta di affermazione contrastante: la crisi è un’offensiva capitalistica contro il prezzo della forza-lavoro, nella consapevolezza che questa ha conquistato un’autonomia irriducibile, governabile solo a mezzo di ricatto e terrore.
Riprendiamo la ricognizione nel ventesimo secolo americano. Col 1933 gli USA cambiano, prende piede il New Deal di Franklin Delano Roosevelt, Das Kapital si fa socialista. È davvero così? Non proprio. È piuttosto la nascita del CIO, sindacato combattivo che rilancia (in parte) la “tradizione maledetta” dell’IWW, a cambiare le carte in tavola nel 1935. Stesso anno del famoso Wagner Act, la legge che trasforma in modo radicale le politiche del lavoro: big government e big labor si connettono. E sarà poi la valanga di scioperi del 1937 ad avviare una stagione di riforme a favore della classe operaia, dalla contrattazione collettiva al Welfare State, che di lì a breve raggiungeranno anche l’Europa devastata dalla guerra.
Veniamo ai giorni nostri. L’agenda della nuova Presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, introduce temi che da almeno un ventennio, se non di più, sono programma dei movimenti sociali: salario minimo e sussidio di disoccupazione continentali; ovviamente in un quadro di socializzazione dei debiti sovrani, di uniformazione dei regimi fiscali. Sappiamo, e lo abbiamo già scritto nella calura d’agosto, che il governo giallo-rosé appena nato è un effetto di questo “nuovo corso”. Senza revisione del Patto di Stabilità, per il Sud Europa e non solo il destino ha il nome di Matteo Salvini. Pochi giorni fa, a Cernobbio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che non è mai stato comunista, ha detto che occorre quanto prima tassare le multinazionali. L’Europa al bivio, scossa dai dazi di Trump e dai populismi autoritari foraggiati da Putin, promuove almeno a parole un mite riformismo. Non si tratta di buone azioni, intendiamoci: la locomotiva tedesca si è fermata, lo squilibrio della bilancia commerciale – che ha visto nell’export germanico il solo protagonista europeo in Europa e nel mondo – non è più sostenibile.
Arriviamo al sodo: riteniamo plausibile una vera stagione di riformismo del capitale europeo? Sì e no. Sì, perché in assenza di esso l’Europa non può che frammentarsi sotto la spinta della barbarie, anche bellica. No, perché senza una massiccia dose di scioperi del lavoro precario, sottopagato, migrante, informale, ecc. niente ci assicura che alle parole roboanti non seguano topolini ancora ordoliberali. Di più: se l’Europa non cambia, e può cambiare solo con la pressione delle lotte, Salvini e i suoi sodali continentali conquisteranno la maggioranza assoluta. L’Europa al bivio impone a chi non si è arreso all’impotenza e al rancore un salto di qualità: ora più che mai servono movimenti sociali radicali, europei, offensivi. Un sindacato continentale, capace di scioperare lo stesso giorno in dieci città dell’Unione, potrebbe inaugurare un nuovo ciclo di lotte vincenti, mentre le tecnocrazie promettono politiche espansive e investimenti, continuando a tagliare i tassi di interesse.
2. Abbiamo appena scritto: il governo giallo-rosé è l’esito di nuove istanze riformatrici nate nel “laboratorio” ordoliberale del continente. Quello che va messo attentamente a fuoco, è come sia stato preparato questo rocambolesco passaggio istituzionale: oltre che a Berlino e Bruxelles, anche da un nuovo consensus interno alle élite e alle classi dirigenti del Bel paese. Conte bis è l’effetto, cioè, di una resa dei conti per nulla lieve tra «frazioni» della borghesia, in permanente e convulso conflitto tra loro.
La battuta di arresto del progetto sovranista di Salvini, infatti, indica la sconfitta politica – senz’altro provvisoria – di alcuni segmenti del padronato italico: quel «capitalismo molecolare» del Nord, poco incline all’innovazione tecnologica e impoverito dalla crisi, che, facendo leva sulla oramai strutturale tendenza alla «orientalizzazione» delle catene del valore, ha reso momentaneamente credibile il macchiettistico e reazionario sogno di uno spostamento geopolitico dell’Italia verso la Russia di Vladimir Putin. Inoltre, allargando lo sguardo, non si può non constatare che la crisi di governo è stata favorita da un’altra sconfitta, sul piano sociale, che ha investito le forze del governo giallo-verde: l’impossibilità di realizzare quell’iniziale disegno neo-corporativo costituito da un nuovo «assemblaggio di ceti», che avrebbe dovuto subordinare gli interessi dei poveri del Meridione (vedi il Reddito di cittadinanza), alle ambizioni dei piccoli e medi proprietari del Nord alla ricerca di nuovi profitti (vedi la Flat tax).
Quando – riprendendo Tronti e altri; pensiamo al seminario dell’Istituto di Scienze politiche e sociali di Padova, del dicembre del 1967, poi raccolto nel volume dal titolo Operai e stato – affermiamo che il New Deal rooseveltiano è stato realizzato e approfondito dalle lotte operaie, sosteniamo anche, inevitabilmente, che quelle stesse lotte qualificarono from below l’organizzazione del lavoro fordista. Così come furono sempre le lotte, nella fase alta del conflitto italiano dei Sessanta e dei Settanta, a preparare il panorama economico e produttivo postfordista, con la conseguente formazione di nuovi strati della borghesia italica – che tutt’oggi ereditiamo. Il capitalismo familiare italiano reagì alle straordinarie e potenti lotte sul salario e di rifiuto del lavoro in due modi diversi: decentrando e “distrettualizzando” la produzione, allo scopo di fermare o limitare il conflitto; le imprese più grandi, intanto, recuperavano i margini di profitto erosi dalle lotte mediante la finanziarizzazione. Una tendenza notoriamente non isolata, che anzi si inscriveva nel contesto della globalizzazione e dell’accumulazione capitalistica dominata dalla finanza.
Sarebbe persino superfluo rammentare che questa doppia tendenza inscritta nello sviluppo italiano si è poi consolidata grazie ai cambiamenti istituzionali europei, fino all’introduzione dell’Euro. Un contesto in cui – parallelamente – si costituiva il neomercantilismo della Germania che, oltre a prevedere una bilancia commerciale sempre in attivo, è consistito nella definizione di «un’area manifatturiera allargata», con imprese di vari paesi tra loro in rete e alla “locomotiva tedesca” subalterne: Austria, Romania, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Lituania, compresa l’Italia del Nord. Mentre le imprese del “centro” hanno seguito un sentiero segnato dalla specializzazione produttiva e dall’innovazione tecnologica, quelle della “periferia”, comprese le italiche, hanno visto la propria capacità produttiva perdere colpi e volumi.
La crisi europea esplosa a partire dal 2008 – che, come tutte le crisi, è sempre momento di «distruzione creatrice», per dirla con le parole dell’economista austriaco Joseph Schumpeter – ha favorito concretamente un ulteriore, duplice processo: da un lato, le catene del valore a dominanza tedesca hanno accentuato maggiormente l’esposizione verso Est, inseguendo la domanda cinese; dall’altro, le imprese più strutturate hanno battuto la strada aperta dall’innovazione di Industria 4.0 e dal Platform Capitalism. Entrambi i processi non hanno riguardato egualmente tutte le aziende: mentre quelle del “centro” si sono ristrutturate, anche grazie alla ripresa degli aumenti salariali in Germania, quelle della “periferia” sono rimaste al palo.
Il recente rallentamento dell’economia cinese, la guerra americana dei dazi (che a questo rallentamento sta contribuendo), la frenata dell’economia tedesca, insieme all’hard Brexit, hanno finito per favorire il nuovo consensus – succitato – interno alle élite del Bel paese. Per intenderci: i capitalisti del club Ambrosetti e di Cernobbio hanno cambiato idea rispetto al «capitano»; ciò, contro ampi strati della lumpen borghesia che invece il Dj del Papeete hanno fin qui sostenuto e continueranno a sostenere. Le imprese italiane “finanziarizzate”, e quelle maggiormente implicate nella catena del valore a trazione tedesca, nonostante qualche incertezza e discreta diffidenza nei confronti del nuovo governo, hanno giurato fedeltà alla moneta unica, e si sono allineate all’agenda di Ursula.
3. Prima di passare il testimone a Christine Lagarde, Mario Draghi ha rilanciato il Quantitive Easing. A soli dieci mesi dalla fine del primo. La BCE acquisterà titoli di Stato sul mercato secondario per 20 miliardi al mese. Ciò, fin quando sarà «necessario». Terminerà dunque solo quando la BCE alzerà i tassi, ovvero una volta che l’inflazione sarà «robusta e sufficientemente vicina al 2%». Uno scossone: l’euro sarà debole a fronte del dollaro forte; l’export europeo sarà enormemente avvantaggiato. Le banche, poi, avranno liquidità a sufficienza per fare credito alle imprese, che pagheranno tassi di interesse bassissimi. Così dovrebbe essere per i mutui e i prestiti a favore delle famiglie che investono nel mattone. Scende lo spread, con ciò che ne consegue per i paesi come l’Italia molto indebitati. A questo punto, chiarisce Draghi, la palla passa nelle mani delle politiche fiscali europee e degli Stati.
Il rischio ci è già fin troppo noto: l’accesso al denaro è facile, ma il denaro continua a non circolare; meglio, a circolare sempre nelle stesse mani. Con imprese che dovrebbero investire in innovazione e ricerca e che, soprattutto in Italia, continuano a non farlo. Ancora: ma quali sono le famiglie che si indebitano per il mattone quando la precarietà del lavoro e la disoccupazione hanno frammentato biografie e affetti? È dal 2008 che gli stimoli monetari non si traducono in politiche effettivamente espansive, capaci di favorire crescita dei salari diretti e indiretti (welfare: previdenza, salute, istruzione). Saprà, il nuovo QE appena battezzato da Draghi, andare in direzione diversa del precedente? In piccola parte sì, in buona parte no. Perché la moneta da sola, se non ci sono politiche pubbliche coraggiose, non “sgocciola” verso il basso. Ma non è forse questo il momento migliore per rilanciare la parola d’ordine: ‘Quantitative Easing for the People’? Rispondiamo senza incertezze: sì.
Proprio oggi, come spesso è accaduto nella storia della lotta di classe, dovremmo prendere sul serio e praticare from below i timidi enunciati riformistici del capitalismo europeo. Compreso quello, assai più globalizzato, dell’economia circolare e del Green New Deal. Proprio oggi, con la forza dell’esperienza femminista di Ni una menos, e i potenti scioperi transnazionali dell’8 marzo, con l’esempio dei gilets jaunes francesi, ci vorrebbero blocchi continentali della produzione, della circolazione, del consumo. Pretendendo un vero – e non un miserabile – salario minimo europeo, un reddito di base garantito da una fiscalità unica comunitaria, un modello di sviluppo sostenibile. Proprio oggi, in combinazione con i salvataggi in mare e la riapertura di corridoi umanitari anche aerei, servirebbero scioperi della forza-lavoro migrante per il salario e per il welfare, antidoti al razzismo dilagante.
Ma la domanda da farsi è ovviamente la seguente: il sindacalismo sociale può conquistare un’estensione quanto meno europea? I movimenti che ora ci sono – quello femminista, quello ecologista, quello dei migranti in fuga – possono essere traino per una ampia convergenza sociale, e per conflitti che superino confini e steccati identitari? Tra ciò che servirebbe per la trasformazione radicale, e la realtà, difficilmente c’è coincidenza. Soprattutto nel pieno di un ciclo reazionario che a livello globale, dagli Stati Uniti alla Russia, dal Brasile all’India, si è tutt’altro che sopito. E dopo anni in cui i “pozzi” sono stati avvelenati, con la mutazione antropologica che fa da sfondo e da base sociale della reazione neoliberale e al tempo stesso sovranista. Eppure non possiamo, e non dobbiamo, nasconderci la portata epocale della sfida fin qui delineata. Senza organizzazione e lotte, nessun riformismo è davvero possibile. E se il riformismo fin qui per la maggior parte enunciato dovesse fallire malamente, la guerra tornerà in Europa. Ma le riforme in questione, seppur solo verbali, possono diventare terreno offensivo per i movimenti.
Forse, come nel 1929, è stata la relativa passività della «classe operaia», del lavoro vivo, a favorire la crisi europea e, soprattutto, la «stagnazione secolare» che ne è conseguita. Ed è proprio adesso allora, che nelle lotte e nei movimenti occorre preparare la svolta.
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 14 settembre 2019.