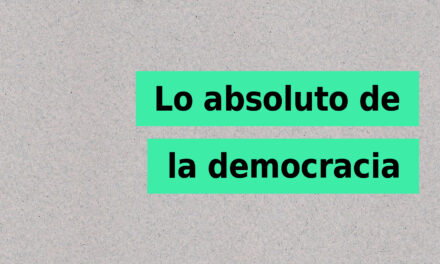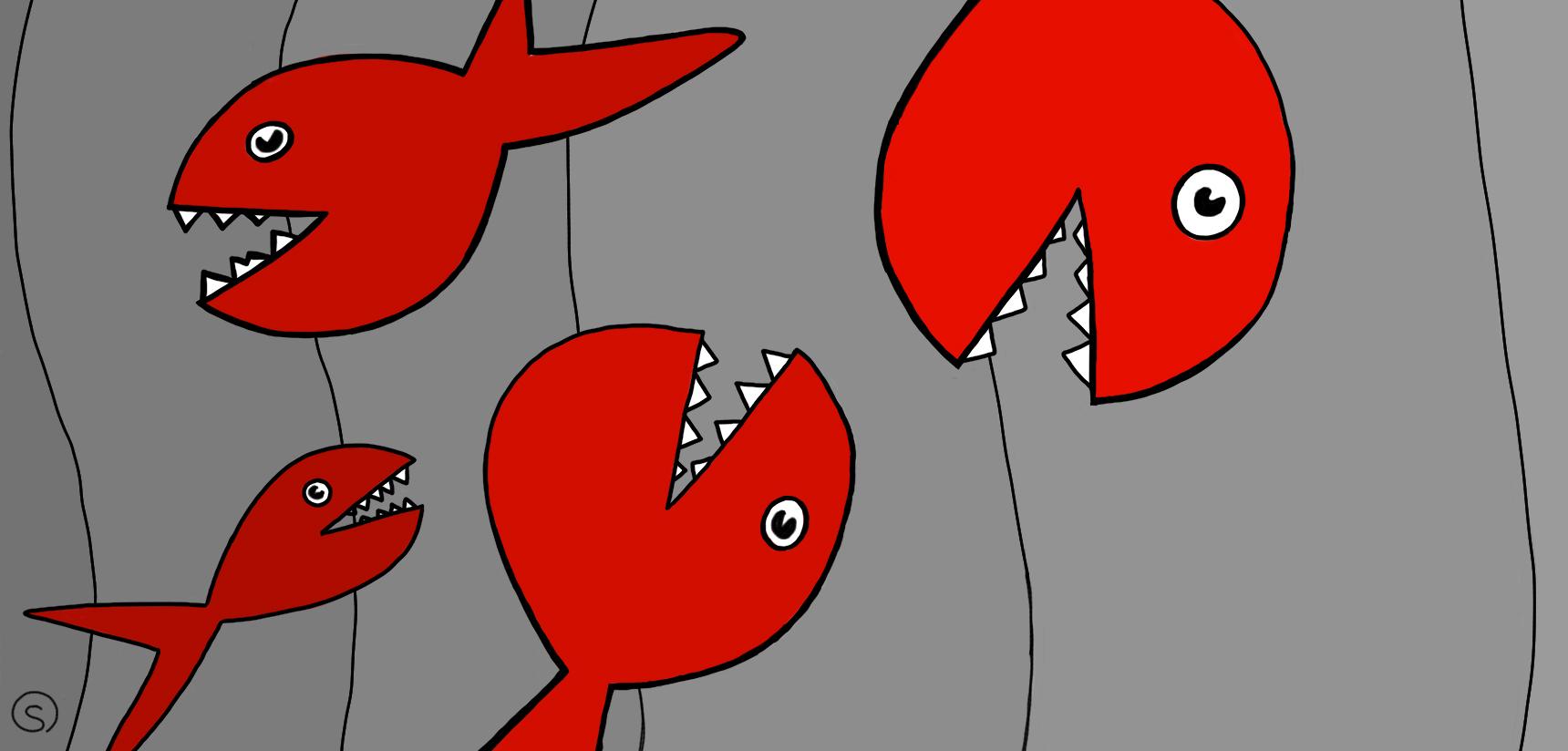di PAOLO FABBRI.*
La scomparsa di Paolo Fabbri ci priva di un compagno acuto, intelligente, curioso, che ci ha insegnato un uso sovversivo dei segni del mondo. Per ricordarlo abbiamo recuperato un suo testo poco noto, pubblicato nel 1998, nel quale faceva il punto – non per arrestarsi, ma per fare ancora un passo in avanti – su Deleuze e Guattari, Hjelmslev e Bacon, argomenti sui quali teneva quell’anno il corso all’Università di Bologna. Il testo è ricavato da una conversazione a registratore acceso, come si evince dal tono discorsivo che è stato intenzionalmente mantenuto [G.D.M.]
Tutto quel che ho scritto era vitalismo, o almeno spero che lo sia, e costituiva una teoria dei segni e dell’evento (Gilles Deleuze)
Nei miei studi su Deleuze, a partire dal mio intervento a un convegno a Palermo, avevo cercato di verificare l’impatto di una certa semiotica – anzi, di due certe semiotiche. La ragione era che, un po’ per la conoscenza personale di Guattari, che era un vero amico (mentre non ho mai conosciuto personalmente Deleuze), un po’ per altre mie ragioni di lavoro, sapevo in maniera molto precisa della grande influenza che aveva avuto sulla terminologia di Deleuze e sul suo ripensamento concettuale il lavoro semiotico e linguistico. Quindi avevo fatto uno sforzo per mettere a punto una definizione generale di questi problemi, che restano a mio avviso fondamentali nell’impalcatura del lavoro di Deleuze. Soprattutto a partire da Mille plateaux (anche se nell’Anti-Edipo c’era già qualcosa), questo tipo di semiotica costituisce un distacco molto forte rispetto a Differenza e ripetizione e Logica del senso: diciamo che questo tipo di riflessione viene dopo Logica del senso, ed per per me fondamentale. Successivamente Deleuze, che si era molto ispirato a questa semiotica, che poi quella hjelmsleviana, quando comincia a lavorare sul cinema si ispira a Peirce. Anche in quel caso, come nel primo, riprende in qualche misura alcuni postulati, alcune definizioni, che poi storce, modifica, traspone, come fa sempre lui: li fa derivare e li fa diventare un’altra cosa. Quindi la mia idea era in primo luogo un lavoro sulle fonti di Deleuze e di Guattari – insisto a dire Deleuze e Guattari, perché secondo me l’influenza hjelmsleviana è avvertibile soprattutto nel lavoro di Guattari: l’influenza di Guattari su di lui non è un’influenza di riflessione sulla psichiatria, come ingenuamente si crede, ma soprattutto su di un certo tipo di approccio alla semiotica, ai problemi del senso, che mi sembra valga la pena di rilanciare.
Un secondo tipo di lavoro, che ho fatto quest’anno nel mio corso universitario, il lavoro su Bacon: volevo guardare lo sguardo del filosofo per vedere che cosa un filosofo vede, in quanto filosofo e in quanto Deleuze, quando guarda la pittura di Bacon. E in questo facevo seguito ad altri corsi che avevo tenuti alcuni anni or sono al Collège International de Philosophie e a Strasburgo, che affrontavano la stessa lettura che avevo fatto, non sulla pittura ma sulla letteratura: e avevo preso il lavoro su Bartleby, quell’introduzione al Bartleby che un po’ come l’introduzione al libro di Sacher-Masoch – quelle introduzioni che sono grandi saggi di filosofia, più che introduzioni al testo. Così facendo mi rendevo conto, progressivamente, non della filosofia di Deleuze – che non era il mio problema – ma di alcune modalità della costruzione della sua filosofia.
Ora, perché fare questa operazione? Nessuno ha mai pensato di ridurre Deleuze alla sua dimensione semiotica, né di decidere che il livello fondamentale del suo lavoro quello semiotico. Ma siccome siamo davanti a uno che ha sempre sostenuto di essere un “intercessore” tra diverse linee discorsive e culturali (Mille plateaux costruito proprio come un sistema di intercessioni), allora mi sembrava che fosse interessante puntare anche su questo aspetto. Tuttavia, oltre a questo, mi sembrava importante sottolineare che, oltre ad aver lavorato esplicitamente sul campo semiotico, Deleuze ha anche lavorato con teorie semiotiche realmente incompatibili l’una con l’altra: questo pone la questione di quanto la semiotica possa aver contribuito ad attivare un certo tipo di pensiero. Io ho un esempio, che ho preso da Pourparlers: «Tutto quel che ho scritto era vitalismo, o almeno spero che lo sia, e costituiva una teoria dei segni e dell’evento». Ora, cosa vuol dire segni? Teoria del segno per Deleuze non vuol dire affatto una semiologia generale, ma quella che lui chiama una “trans-semiotica”: una specie di “trasduzione”, in cui il passaggio tra sistemi semici provoca un incremento di senso, una morfogenesi. Ho l’impressione che l’intelligenza di Deleuze consista nell’aver capito alcune cose che sta ora cominciando a capire l’intelligenza artificiale: diversamente dalla logica, la questione non è di costruire dei sistemi logici preliminari e poi cercare di vedere come funzionano nel linguaggio, ma di assemblare alcune unità molto semplici e poi interessarsi delle proprietà emergenti. La teoria della “muta” di Deleuze consiste proprio nel vedere come, a un certo punto, delle proprietà emergenti si organizzano e prendono significato, che esattamente il contrario della vecchia semiotica e della vecchia logica.
Un altro punto molto curioso dell’approccio deleuziano alla semiotica è là dove Deleuze, citando Pasolini, afferma che la semiotica una “scienza descrittiva della realtà”: «tale è la natura misconosciuta della semiotica, al di là dei “linguaggi esistenti”, verbali o no». Contro tutti quelli che hanno cercato di ridurre i problemi semiotici a problemi puramente linguistici, oppure di applicazione linguistica, l’intelligenza di Deleuze è di aver capito che la semioticità consiste in pezzi di lingua e di non-lingua: «che la linguistica sia una parte della semiotica non vuol dire, come per la semiologia, che ci sono dei linguaggi senza lingua, ma che la lingua esiste solo come reazione a una materia non-linguistica». In altri termini, a differenza di altre filosofie (penso qui a Derrida), la filosofia di Deleuze semioticamente del tutto anti-testualista, se per testo si intende il testo puramente scritto e letterario: per Deleuze il testo è fatto di pezzi di lingua e pezzi di realtà. Lingua nel senso: teoria dell’espressione da una parte, e organizzazione del mondo in quanto dotato di significato dall’altra. Per Deleuze gesti, immagini, pezzi di fotografie, pezzi di quadro stanno tutti insieme: in questo è veramente vicino alla semiotica non linguistica, cioè a una semiotica che si interessa dei problemi di significato non a livello del testo inteso in senso restrittivo. Prendiamo, come esempio, quella sua idea dell’astice: guardando come fatto, si trova nell’astice, con la sua doppia articolazione di tenaglie, proprio la rappresentazione classica del modello hjelmsleviano: l’idea del taglio simultaneo della forma dell’espressione e della forma del contenuto. Ciò vuol dire che forma dell’espressione e forma del contenuto sono atti simultanei, la correlazione tra forma dell’espressione e forma del contenuto essendo, secondo me, la grande scoperta che fa Hjelmslev per far saltare l’opposizione forma-contenuto. E infatti Deleuze parla di forma dell’espressione e forma del contenuto, sostanza dell’espressione e sostanza del contenuto, e contro ogni idealismo linguistico raccoglie l’idea che Hjelmslev è uno spinozista, chiedendosi: cosa c’è qui? C’è la materia, c’è la forma – che uno dei livelli della materia –, la forma articola la materia, e chiamiamo sostanza quel tanto di materia, in quanto articolata dalla forma. In altri termini: la lingua è quella che è, ritaglia indubbiamente il reale, e da questo punto di vista la lingua si dota di una sostanza. Soltanto che questo reale è un reale presupposto da questa sostanza, non opposto a questa sostanza, ed è quel luogo caotico di forze, di determinazioni, di impulsi, di pulsioni che sono quelli su cui si tracciano le linee di consistenza: e questo modello è sostanzialmente hjelmsleviano. Ho trovato in Mille plateaux una divertentissima immagine, molto spiritosa: «Il geologo danese Hjelmslev, oscuro principe discendente da Amleto, che si occupa del linguaggio appunto per estrarne la stratificazione»; qui geologo vuol dire una cosa molto chiara: il geologo è arpenteur, un tagliatore di territori.

Ora, questo problema in Deleuze e Guattari si articola in tre punti. Hjelmslev ha, prima di tutto, fatto saltare l’opposizione tra forma e contenuto, riarticolandola; in secondo luogo, ha incluso il pensiero spinozista della materia; infine, la conclusione è che mentre persino il Derrida della Grammatologia continua a pensare che il significante percettivo e il significato concettuale, secondo un modello che nessuno gli toglierà più dalla testa (anche perché si è ormai storicamente affermato), la risposta di Guattari e Deleuze è che in Hjelmslev c’è scritta un’altra cosa: che ogni forma espressiva può diventare la forma di contenuto di una nuova espressione, e ogni forma di contenuto può diventare la forma espressiva di un nuovo contenuto – pensate che liberazione! Io sono veramente convinto dell’efficacia di questa lettura, perché a questo punto non più vero che il significante è percettivo e il significato è concettuale: ogni percettivo può diventare concettuale per una nuova espressione percepibile, e ogni contenuto concettuale può diventare espressione per un nuovo contenuto. Cioè, la liberazione del segno, che prima era inchiavardato sul significante-significato, è intesa da Deleuze e Guattari come un formidabile modo di liberazione del significato, di mutamento e di trasformazione: è questa la trans-semiotica. Ed è importante notare che proprio in quel periodo, in Francia, la semiotica si blocca da un lato su un’ipotesi di tipo trans-linguistico – la semiotica è solo principio di linguaggio applicato ad altre sostanze, e dall’altra parte si blocca sulle definizioni di significato e significante: una strada che non poteva portare a niente, e che infatti non ha portato a niente. Da qui la necessità di correzioni infinite: introdurre un po’ di pragmatica, introdurre continuamente delle determinazioni, data l’incapacità del modello. Invece Deleuze e Guattari vedono luminosamente il problema, e lo sviluppano in una maniera che permette a Deleuze di articolare alcuni problemi precedenti. Dov’è che Deleuze parla del segno? Nel lavoro su Proust, dove affronta soprattutto la questione di Spinoza e del segno, parlando della teoria delle affezioni, cioè delle passioni. Quello che mi aveva colpito della distinzione tra percetto, concetto e affetto in Deleuze era che per lui il segno era affezione: ora, curiosamente, questo lo ritroviamo anche nella semiotica di Greimas, contro la semiotica alla Barthes o alla Peirce – cioè contro una semiotica di tipo logico, in cui la teoria del dubbio è puro fallibilismo, e non una teoria dell’affezione come sarebbe invece per Deleuze. Io ho l’impressione che in questo tipo di semiotica, in cui noi lavoriamo sull’affezione del segno, in queste ricerche sul segno in Proust, l’avvicinamento all’affezione, la teoria degli affetti spinoziana trova un’articolazione all’interno di una semiotica che abbia una capacità spinozista. Ad esempio, nell’articolo sulle Tre Etiche di Spinoza c’è un lungo passaggio sull’idea di segno in Spinoza. Lo stesso nel lavoro su Proust: per Deleuze l’opera di Proust non si basa sull’esposizione della memoria, ma sull’apprendimento dei segni. Ma quello che mi interessa mettere in luce è che il passaggio alla teoria hjelmsleviana dà a Deleuze un’articolazione al problema del segno, che è uno dei suoi grandi problemi, e alla teoria spinoziana. Se si accetta questo, ne risulta una cosa molto divertente: a questo livello la capacità di manipolare segni dà a Deleuze un fondamento alla nozione di “traduzione” hjelmsleviana. Infatti l’intercessione di Hjelmslev tra sistemi di segni è traduzione perché si può passare da un segno all’altro – ma sono segni di tipo diverso, non necessariamente di tipo linguistico o mentale, sono segni molto fisici, sono segni-effetti, e così via: «Tutti i movimenti umani, anche i più violenti, implicano delle traduzioni».
Cosa succede nel secondo momento, quando Deleuze passa allo studio del cinema? Qui Deleuze si trova davanti a un caso un po’ particolare, e adotta quasi interamente l’analisi di Peirce: prende tutte le tipologie di Peirce (primarietà, secondarietà, terziarietà, ecc.) e le applica al cinema. Si mette a rifare una ridefinizione dei concetti peirceani: cosa sono i sintomi, cosa sono i feticci, cosa sono i binomi, cos’è un indice, cos’è un’ellisse, che cos’è una marca, un simbolo, ecc. Ora, bisogna essere abbastanza chiari: che compatibilità c’è fra una teoria spinozista hjelmsleviana che Deleuze usa in Mille plateaux e quella che usa nei libri sul cinema? La mia risposta è che a un certo punto Deleuze si trovato davanti a una materia diversa da quella del linguaggio, dove la riflessione ha isolato sia le parole lessicalmente, sia le regole della grammatica e le regole stilistiche e della retorica: nel caso del linguaggio, siamo davanti a una tradizione che ha tipologizzato enormemente i segni. Ma qui Deleuze si ritrova in un campo dove tutto questo non c’è: non c’è per l’immagine l’equivalente di una tipologia rigorosa dei segni linguistici. E allora cosa fa? Va a prenderla dove può, e la prende da Peirce. La cosa più spiritosa è di vedere che la cambia continuamente: ad esempio, il concetto di simbolo è diverso da quello di Peirce, mentre in altri casi i concetti corrispondono, e in altri ancora ridefinisce le nozioni, come col concetto di reuma. Deleuze prende una tipologia e, come fa sempre, la fa derivare: il suo grande problema è sempre quello di far derivare le relazioni e sottoporle a fenomeni di trasformazione. Del resto è vero che Peirce, essendo un logico, ha costruito una teoria della semiotica non modellata sul linguaggio, a differenza di Saussure. È interessante mettere a fuoco che entrambe le volte che Deleuze usa la semiotica, la usa perché tanto Hjelmslev quanto Peirce sono contro la determinazione a senso unico di tipo linguistico: «La forza di Peirce, quando ha inventato la semiotica, è stata di concepire i segni a partire dalle immagini e dalle loro combinazioni, e non in funzione di determinazioni linguistiche pre-esistenti». Ciò nonostante Deleuze mantiene in modo molto forte i modelli precedenti, cioè i modelli di tipo linguistico, che considera fondamentali. Ne è un esempio il modello di processo aperto: il concetto di processo aperto in Hjelmslev è certamente l’idea dell’infinitivo. Deleuze parla molto del concetto di “infinitivizzare”: non i concetti, ma i processi nel loro darsi – quindi non l’immagine ma l’immaginare, non la parola ma il parlare. Tutto viene pensato a partire da processi di infinitizzazione: il diventare, di qui l’idea della metamorfosi, concetto centrale perché il divenire-altro, il divenire-animale, il divenire-donna, e così via. Questo è un modello molto forte che lui trae dalla linguistica, ad esempio quella di Guillaume, che è una linguistica di tipo prettamente mentalista, e che però si interessa degli aspetti della temporalità e dell’aspettualità: la processualità. Se si pensa che per lungo tempo la filosofia ha pensato non l’essere nella sua processualità, ma l’ente (come sostantivo), è evidente che quest’idea cambia completamente il problema: il problema ad esempio non più la presenza, ma l’essere-presente. Deleuze continua ad usare questo modello linguistico, soggiacente nel caso del funzionamento linguistico, e qualche volta quest’uso gli viene molto bene a proposito dell’immagine. Ad esempio, lui cita con grande soddisfazione Pasolini, e cita di Pasolini non la vecchia idea che c’è una semiotica del reale, ma l’idea del discorso libero indiretto, che è un modello di tipo linguistico: quello per cui non si sa chi sta enunciando in un certo momento, e che nello stesso tempo è un modello che si trova anche nell’immagine. Di qui l’intelligenza di Deleuze, di non fare difficoltà fra il linguaggio e i segni non linguistici, ma di capire che ci sono delle categorie all’opera in entrambi i casi, diverse ovviamente a seconda dell’organizzazione segnica locale. Di qui l’idea, molto buona, di sottolineare nell’analisi del cinema non tanto l’immagine in sé, ma i processi di enunciazione per cui non si capisce chi sta affermando la propria parola, cosa per lui importantissima perché collegata all’idea che lui ha del soggetto – soggetto in trasformazione, soggetto in modificazione, soggetto in fieri, soggetto in metamorfosi. Nel discorso indiretto libero di Pasolini Deleuze coglie il fatto che ci sono dei momenti, nel discorso, in cui non si capisce chi sta parlando, cioè che il soggetto è in derivazione. Un esempio banalissimo: “Sbucarono nella pianura. Ah, com’era bella!”. Chi dice: “com’era bella”? Sono i protagonisti che raccontano la loro storia, o il narratore onnisciente che racconta che cos’hanno visto, o addirittura il narratore onnisciente che interviene per commentare? Un esempio semplice, anzi banale, che però ci fa vedere come nell’atto stesso del testo la soggettività deriva e si metamorfosa, e come ci sono dei punti in cui diventa “impercettibile”. Una delle grandi categorie del divenire impercettibile non è necessariamente una categoria dell’immagine-percetto: è, al contrario, una delle categorie dell’impercettibilità del soggetto nel gioco dell’immagine, là dove il soggetto diventa impercettibile.
Cosa ho fatto quest’anno su Bacon? Ho cominciato a riflettere sulla questione della “logica della sensazione” di Bacon. Qui, come nel caso di Sacher-Masoch, dove prende tutte le categorie di Sacher-Masoch, gliele rivolta in bocca e gli fa dire un’altra cosa, Deleuze prende i testi di Bacon e le conversazioni con Sylvester, li monta insieme – quindi pezzi di quadri e pezzi di dichiarazioni attaccati gli uni agli altri, proprio una “trans-semiotica” – e li fa funzionare con un regime autonomo, che vede alcune cosa ma che, deliberatamente, non ne vede altre. Il nostro problema non è cosa Deleuze ha visto e cosa non ha visto: filosoficamente, quello che mi pare più interessante non è tanto cosa lui dice di Bacon, ma il fatto che Bacon gli serve come dispositivo per pensare filosoficamente. Ci sono già altri che hanno lavorato molto bene su questo modello: ad esempio, Scholem e Benjamin. L’Angelus novus di Klee è costitutivo di un’epistemologia benjaminiana: l’idea del faccia-a-faccia con l’angelo che però non viene verso di te, ti cattura e poi all’indietro, continuando a guardarti, ti trascina verso il Paradiso spinto dal vento del Tikkun, e l’angelo che ti ha catturato vede dietro di te le rovine che ha lasciato, mentre tu continui a vedere il Paradiso. Ecco, questo modello, in cui c’è mezzo Benjamin, è un modello di cui ci si può chiedere: Benjamin aveva questa filosofia, e poi ha deciso di illustrarla con questa immagine, o è questa immagine ad essere costitutiva del suo discorso filosofico? La risposta di un deleuziano che è hjelmsleviano è che, come nella doppia articolazione dell’astice, c’è una reciproca determinazione: il ritaglio che viene fatto sull’immagine è un ritaglio che viene fatto sul discorso, e quindi l’operazione è simultanea.

A me sembra interessante che nell’impostazione che si trova nell’ultimo capitolo di Che cos’é la filosofia? – che non a caso è stato fatto non dal solo Deleuze, ma da Deleuze con Guattari – si trova implicato questo concetto, che Deleuze da solo aveva letto in Bacon: che nel quadro di Bacon c’è un fondo di campitura che è appunto questo mondo delle forze, questo mondo della materia, delle forze caotiche, e su questo mondo di forze caotiche si creano delle figure che lui chiama “la casa”, che sono dei luoghi di “trasduzione”, o “linee di consistenza” che “territorializzano” il caos, e che però funzionano reciprocamente – ci sono simultaneamente la “deterritorializzazione” e la “riterritorializzazione”, filtrate dall’apparato che è la casa. Qui, nella parte centrale, tra le linee di consistenza, si trova la figura umana, che in preda a tutti i sistemi di deformazione – come è evidente nel divenire-animale in Bacon. La figura umana non è lì per rappresentare qualcosa, ma per rappresentare delle forze di deformazione – un’altra grande affermazione di Deleuze è che la pittura rappresenta forze in fieri, processi di forze, non rappresenta figure, immagini, stati: descrive, come direbbe un greimassiano o uno hjelmsleviano – come dico io – dei processi di trasformazione. In questo caso particolare, quindi, forze che generano processi di deformazione.
Quest’idea della figura umana centrale, della casa che la include con le linee e i “piani di consistenza” che permettono le azioni di deterritorializzazione e riterritorializzazione, tutti i fenomeni di forze su questa figura che la trasformano in animale, in carne da macello, tutto questo diventa qualcosa che non so come chiamare. Volevo chiamarlo il “Blasone di Bacon”, se non fosse che il concetto di blasone darebbe l’idea di una ricostruzione statica, fissa – cosa che mi dispiacerebbe profondamente: chiamarlo “blasone” significherebbe chiuderlo e fissarlo come uno scudo, cosa che impossibile. Per cui forse la nozione migliore è quella di “diagramma”, che Deleuze riprende ovviamente da Peirce. Peirce ha detto (e su questo sono d’accordo con lui) che in un’inferenza logica, quando si passa dalla protasi all’apodosi (o dalla premessa maggiore alla minore, se si preferisce) ci si trova sempre ad utilizzare in qualche modo – come d’altra parte con la metafora – uno “schema diagrammatico”. L’inferenza, cioè, sorretta da un diagramma soggiacente: diagramma d’inclusione, di conseguenza, di esclusione, d’inglobamento. Un po’ come la metafora, per passare da un termine all’altro, deve avere sotto un diagramma che permette la circolazione. Ad esempio, “la donna è una rosa”, la più banale delle metafore: si deve pensare che tra i due termini ci siano in comune dei tratti, come la freschezza, la scarsa durabilità e il problema del tempo, il carattere effimero, il profumo; e se ne devono escludere altri, come le spine, il fatto che le rose vadano concimate, eccetera. C’è nel lavoro della metafora, in qualche misura, uno schema di proprietà che consente il passaggio, a volte reciproco, dei tratti. Lo stesso accade nell’argomentazione: “Tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale”: qui si ha un diagramma soggiacente di tipo inclusivo; o, al contrario, nell’induzione si ha un diagramma per allargamento. Insomma, io penso che la parola “diagramma” vada bene.
Io ho l’impressione di aver toccato con mano in modo chiaro che questa specie di diagramma figurativo deleuziano, che Deleuze trova nell’opera di Bacon, non sia soltanto un’illustrazione teorica: su questo anche Derrida (che l’uomo più lontano da Deleuze che si potesse immaginare: li si potrebbero rovesciare ed ottenere l’uno dall’altro) insiste molto. Probabilmente Derrida, quando si è posto il problema dell’immagine filosofica, se lo è posto in maniera simile: anche lui sa che l’immagine non è una mera decorazione dell’argomentazione filosofica. E qui posso citare un caso personale, una discussione sulla traduzione che ho avuto con Gianni Vattimo alla Columbia University. Io dicevo che una vera traduzione è inter-semiotica, trans-semiotica; che ci sono traduzioni dell’immagine nel linguaggio e del linguaggio nell’immagine, e non solo sovradeterminazione del linguaggio rispetto agli altri sistemi semiotici; e Vattimo mi ha obiettato: “ce lo vedi un gruppo di pittori che si mettono a discutere di noi dipingendo?”. Ecco, resta dietro Vattimo, e lo si vede bene anche dietro Gadamer, il privilegio del linguaggio, l’assoluto privilegio della scrittura (come anche in Derrida). La forza di Deleuze di avere aperto innanzitutto all’immagine, ma soprattutto a una trans-semiotica in cui pezzi di immagine e pezzi di parola si alternano clamorosamente.
Due esempi ulteriori della capacità diagrammatica a cui fa pensare sempre Deleuze: il concetto di “rizoma”, e il concetto di “muta”. È evidente che Deleuze parla non per metafore, ma per diagrammi: le sue sono proprio argomentazioni figurative. Se si vede come uno scienziato come Stephen Jay Gould interpreta l’evoluzione, si scopre come Gould sia deleuziano sino in fondo. Deleuze non è interessato alle strutture ad albero, perché preferisce le strutture rizomatiche in cui tutto si riconnette con tutto: la stessa osservazione la fa Gould per l’evoluzione, quando afferma che l’evoluzione non è né una scala né un insieme ordinato di aperture di possibilità di cui alcune restano bloccate mentre altre avanzano, ma un “cespuglio” – Deleuze direbbe un “rizoma”. «Potato dalla sinistra falciatrice che è la morte», aggiunge Gould: certo, senza dubbio – ma senza che questo arresti il continuo atteggiamento rizomatico. Secondo esempio, il concetto di “muta”. Ciò che interessa a Deleuze non sono gli stati, ma in qualche misura le collettività nomadi. Ora, per tale idea di collettività nomade Deleuze usa il concetto di “muta” come “proprietà emergente di interazioni miopi”, e parla molto del concetto di “acentrismo”, o di comunità non-centrata, che però si muove – tutt’altra cosa dal decentramento amministrativo, che pur decentrandosi resta sempre sul posto. Anche per i concetti è così: Deleuze non pensa che i concetti “stiano là”, non pensa a una storia della filosofia che “sta lì” con i suoi concetti e che ammette qualche decentramento. Lui pensa alla storia della filosofia come a una muta, come uno stormo di storni o un banco di pesci che evolve con delle informazioni locali – che però fanno sì che ci sia un orientamento: non un orientamento finalistico, saputo a priori, ma una forma di derivazione, di deriva.
In questa prospettiva, Deleuze ci consente di pensare meglio ad alcune questioni che oggi ci vengono poste dal problema dell’intelligenza artificiale, delle macchine parallele, dai problemi della morfogenesi nel disegno artificiale, diciamo così, della vita – dove comincia la vita, dove finisce: io credo che questi problemi richiedano un’epistemologia di tipo deleuziano. Con questo tipo di impostazione sembra però che io tenda a sottovalutare gli aspetti fondamentali del pensiero di Deleuze, come ad esempio il suo bergsonismo: Deleuze non ha mai avuto alcuna vergogna a dire che la sua filosofia è una filosofia bergsoniana, che in questo senso la sua filosofia è “espressionismo”. Ma a me interessa quest’altro tipo di lavoro deleuziano: si pensi al pensiero diagrammatico, a quali spettacolari risultati arriva quando pensa al concetto di “piega”. La “piega” è quel diagramma che si ritrova nella filosofia, nelle matematiche, nella topologia, è nella scultura e nella pittura del Seicento, e nella musica. Più che con il concetto di evoluzione, che un concetto più propriamente filosofico, mi interessa questo spostamento, quest’idea di far derivare il discorso della filosofia in Deleuze.
Aggiungo qui una delle cose che resterebbero da fare, da ripensare sul serio: una ricerca sulle “immagini-affetto”. Come ci sono delle “immagini-concetto” e delle “immagini-percetto”, ci sono anche delle “immagini-affetto”. Dato che il concetto di segno è spinozisticamente centrale per la nozione di affetto, credo che varrebbe la pena di metterlo a fuoco. Io ho un’idea sull’argomento: parlando in uno degli ultimi saggi su Beckett, che Deleuze amava molto (Film di Beckett gli sembrava un vero capolavoro), Deleuze si occupa del concetto di “spossatezza”, si chiede che cos’è uno spossato. Ebbene, lui diceva che è spossato, o anche esaurito, colui che ha attraversato tutte le possibilità, tutti i possibili: è quando sono finiti tutti i possibili, quando sono esaurite le possibilità che uno davvero spossato, esaurito. Ecco, io ho l’impressione che lo studio delle configurazioni che lui dà – la gioia, ad esempio: il modo in cui lui ripensa il più attivamente possibile la grande tipologia dell’Etica, che è secondo me il libro che lui ha approfondito di più, che lo ha marcato di più – potrebbe essere una via interessante. Bisognerebbe fare una collezione di tutto l’insieme delle riflessioni che Deleuze ha fatto sugli affetti: io ho l’impressione che lui abbia davvero ripensato agli affetti. In ogni caso ne cito uno, quello che mi ha sempre più commosso: quando mi hanno raccontato che si era buttato dalla finestra, ho detto: “non posso pensare altrimenti”. Avendo deciso di morire – non di uccidersi, ma di morire: di diventare impercettibile – ha eseguito quasi alla lettera un’analisi straordinaria che aveva fatto della nozione di vertigine, là dove spiegava che la vertigine non è la paura del basso, ma è la valorizzazione dell’alto: cadendo, tu valorizzi l’alto. Si dirà che bisogna essere nietzscheani per pensarlo: io credo di sì, quest’idea di affermatività non davanti alla morte, ma dentro la morte mi sembra assolutamente nietzscheana. L’idea che si possa morire affermando l’altezza, sprofondare affermando l’altezza, mi sembra una cosa straordinaria. Confesso che una delle ragioni – forse quella fondamentale – per cui continuo a studiare Deleuze dopo la sua morte è questa: questa valorizzazione, questa gioia nietzscheana di affermare nella morte la vita, che mi sembra in qualche modo esemplare.
* Questo testo, ripreso qui con leggerisisme modifiche nella forma e l’omissione delle note, è stato in origine pubblicato col medesimo titolo in Gilles Deleuze: una piccola officina di concetti (a cura di Girolamo De Michele), “Discipline filosofiche” n. 1/98, pp. 209-220.