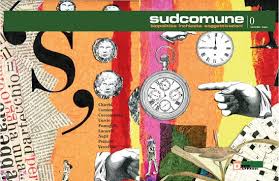Di SANDRO MEZZADRA e TONI NEGRI
Mentre nell’agosto più caldo della nostra storia prende avvio la campagna elettorale, non è solo il cambiamento climatico a essere sostanzialmente ignorato nel dibattito politico italiano. Anche sulla guerra, in realtà, sembra essere calato il silenzio. O meglio, si dà per scontato che esista un consenso di fondo rispetto a una linea definita “europea e atlantica” (parte della mitologica “agenda Draghi”), e si va alla ricerca – per stigmatizzarli – di reali o potenziali scostamenti rispetto a quella linea, a destra, a sinistra, tra i Cinque Stelle. L’operazione di Giorgia Meloni sfrutta l’ambiguità della formula appena richiamata, enfatizzando la fedeltà atlantica del suo partito e subordinando a essa un posizionamento europeo che trova nel nazionalismo polacco il suo modello. È quanto basta, oggi, per rivendicare affidabilità sul piano “internazionale”.
La guerra, d’altro canto, continua a porre in difficoltà anche i movimenti e la sinistra, nelle sue molteplici e spesso conflittuali denominazioni. L’evidente scarto rispetto alle guerre che abbiamo conosciuto negli ultimi anni (per via del fatto che è la Russia a presentarsi come Paese aggressore) ha rapidamente fatto emergere il limite delle mobilitazioni contro la guerra che pure si erano sviluppate tra febbraio e marzo. E mentre si sono qui e là manifestate caricaturali posizioni di appoggio alla Russia, per una presunta caratterizzazione anti-imperialista della sua azione (senza alcuna considerazione per il carattere apertamente reazionario della “civiltà” difesa da Putin all’interno e all’esterno del Paese), un gran numero di iniziative e di carovane a difesa del popolo ucraino e dei suoi profughi ha dato espressione a una tensione morale spesso apprezzabile, ma incapace di superate i limiti di un approccio sostanzialmente umanitario.
A noi pare che sia essenziale superare questo stallo, che per altro non riguarda solo l’Italia. La guerra in corso da oltre cinque mesi si combatte in Ucraina, certo, e assume il carattere di una guerra europea. Ma non è soltanto una guerra europea: ha una dimensione globale che non può sfuggire proprio in questi giorni, di fronte all’operazione militare speciale a Gaza dell’esercito israeliano (che ha in realtà l’Iran come obiettivo) e soprattutto di fronte a quanto accade attorno a Taiwan dopo la provocazione di Nancy Pelosi. Non c’è naturalmente un rapporto diretto tra questi conflitti e la guerra in Ucraina: ma i nessi sono molteplici, e prefigurano un regime di guerra a livello globale che minaccia di diventare la nuova normalità (con la corsa al riarmo che ne costituisce al tempo stesso il presupposto e l’esito). Lottare contro la guerra in Ucraina significa lottare contro questo regime di guerra a livello globale.
Dobbiamo comprendere quali sono le tendenze profonde e di lungo periodo che spiegano la situazione di grande pericolo che stiamo vivendo, e al cui interno si colloca la stessa guerra di aggressione russa in Ucraina. È quantomeno dalla crisi finanziaria del 2007-2008 che viviamo già in un mondo multipolare. Questo significa che, come Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi avvertivano fin dagli anni Novanta, la tendenza di fondo che contraddistingue il nostro presente è la crisi dell’egemonia globale, del soft power, statunitense. Occorre intendersi: non stiamo prefigurando uno scenario di “crollo” degli Stati Uniti, più realisticamente stiamo registrando il ridimensionamento della loro capacità di imporre un consenso attorno a politiche globali di organizzazione dei mercati e degli scambi (quello che si è chiamato Washington consensus). In Asia così come in America Latina e in Africa gli Stati Uniti si trovano di fronte interlocutori esitanti o riottosi, mentre nuove medie e grandi potenze contendono loro le zone di influenza.
Molto prima della guerra di Putin in Ucraina, dunque, si è determinata una situazione che Adam Tooze ha definito con la formula “multipolarità centrifuga”. E questa situazione ha esercitato pressioni crescenti non solo sulle istituzioni mondiali sorte con la Seconda Guerra Mondiale (le Nazioni Unite in primo luogo), ma anche su quelle che – nate dagli accordi di Bretton Woods – si erano trasformate dopo la fine della guerra fredda e avevano costituito un embrione di governo economico della globalizzazione (la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, l’Organizzazione Mondiale del Commercio). In queste condizioni, la multipolarità, da centrifuga, può facilmente diventare conflittuale, e il terreno del conflitto riguarda l’organizzazione degli spazi della globalizzazione, o, se si vuole, l’organizzazione politica del mercato mondiale. Siamo infatti convinti che solo identificando la globalizzazione con le retoriche neoliberali che l’hanno celebrata negli anni Novanta sia possibile affermarne la fine. La materialità dell’interdipendenza (emersa sia rispetto all’efficacia solo relativa delle sanzioni alla Russia sia rispetto alla “crisi del grano”) e il radicamento di processi globali che articolano economie e società anche profondamente diverse tra loro ai quattro angoli del pianeta devono piuttosto trovare nuovi spazi e nuovi dispositivi di governo.
È in questa tumultuosa condizione di transizione a livello globale che la guerra minaccia di porsi al centro dei processi di globalizzazione, imponendo una nuova riflessione su un concetto come quello di imperialismo, su cui ci proponiamo di tornare. Ma intanto vogliamo porre il problema essenziale di fermare la guerra, ovunque nel mondo e in particolare in Ucraina, dove lo scontro appena dissimulato tra la Russia e la NATO evoca ogni giorno lo spettro delle armi nucleari. La guerra va fermata in Ucraina, per mettere fine al massacro dei civili e alla distruzione del Paese. Ma va fermata anche per affermare con forza la necessità di disinnescare quello che abbiamo definito il regime di guerra a livello globale, per imporre una transizione egemonica che non passi attraverso la guerra. Diciamolo chiaramente, la guerra chiude gli spazi per la lotta per l’uguaglianza e per la libertà, è più semplicemente la negazione di ogni forma di crescita civile ed economica.
Ci sono le condizioni per lottare contro il regime di guerra a livello globale: non abbiamo simpatia per alcun governo delle potenze oggi emergenti, e tuttavia non possiamo non sentire nel profilarsi di un mondo multipolare gli echi delle lotte anticoloniali; avversiamo l’autoritarismo e il nazionalismo di Xi Jinping, e tuttavia non possiamo non vedere nella crescita della Cina la spinta di decenni di lotta di classe proletaria; vediamo in particolare in America Latina la continuità di una spinta potente dei movimenti che giungono ad attraversare nuovi governi “progressisti” e a prefigurare processi di integrazione regionale. A noi pare che la ricostruzione di un punto di vista internazionalista, capace di collegare questi echi e queste spinte alle lotte in atto nelle diverse regioni del mondo, sia un compito essenziale, ben più urgente della corsa ad arruolarsi in uno dei fronti del presunto scontro tra “autocrazie” e “democrazie”.
Torniamo alla guerra in Ucraina. È evidente che Putin ha pensato di poter cogliere l’occasione del ridimensionamento globale della potenza statunitense per porre la questione della ridefinizione delle architetture di sicurezza in Europa e al tempo stesso per affermare il rango imperiale della Russia. L’aggressione all’Ucraina, con il suo carico intollerabile di morte e di distruzione, trova qui le proprie “ragioni”. Alle spalle dell’“operazione militare speciale” c’è un “capitalismo politico”, di natura essenzialmente estrattiva e statica: ma c’è anche la costruzione di un regime autoritario, ci sono le guerre in Cecenia e in Siria, c’è la proiezione della potenza russa in Libia e in Mali. Non v’è alcun dubbio che Putin rientri tra i nostri nemici (e in particolare tra i nemici di quanti e quante si battono in Russia per l’uguaglianza e la libertà). Ma con il passare dei mesi appare sempre più chiaro che la reazione dell’Occidente alla guerra e in particolare l’insistenza sulla “vittoria” ucraina rischiano di consolidare il regime di Putin assai più di quanto non contribuiscano a indebolirlo.
Se è vero che Trump aveva tentato di operare una sorta di “secessione” dal mondo multipolare in formazione, per “rendere nuovamente grande l’America” in spazi più precisamente definiti, l’amministrazione Biden ha visto a sua volta nella guerra in Ucraina un’occasione per reagire alla crisi dell’egemonia globale statunitense, riorganizzando attorno a sé un Occidente le cui coordinate geografiche si estendono dall’Atlantico all’Indopacifico. Dovrebbe essere evidente il carattere reattivo di questo progetto, tanto più che l’Occidente che si è tornati in questi mesi a celebrare pare aver perso ogni carattere “universale”, presentandosi ormai come parte che è costretta a riconoscere la presenza strutturale sul terreno globale di attori di diversa costituzione: sta qui una delle mote differenze rispetto alla guerra fredda.
L’esplicito riconoscimento dell’Indopacifico come area di interesse strategico per la NATO nel nuovo Strategic Concept adottato al vertice di Madrid dello scorso giugno indica in ogni caso come la guerra in Ucraina costituisca un passaggio fondamentale per l’organizzazione, divenuta una vera e propria alleanza militare su scala globale (rinforzata in Europa dall’adesione di Svezia e Finlandia, pronte a cedere alle pressioni turche e a estradare decine di militanti curdi). Quel che accade a Taiwan in questi giorni fa intendere la pericolosità di questa trasformazione, in uno scenario in cui gli Stati Uniti possono senz’altro optare per una forzatura militare per convincere Paesi alleati e non allineati che, come si è ben visto con l’iniziativa di Pelosi, possono essere riluttanti a schierarsi in uno scontro con la Cina.
Non sfugge comunque che questa NATO globale non potrà che apparire alle moltitudini non occidentali come una NATO bianca, imperialista. E con buone ragioni. Si pone dunque qui una questione fondamentale per l’Europa, che in questi mesi è stata sostanzialmente schiacciata sul profilo atlantico. L’Unione Europea aveva affrontato la pandemia in un modo sostanzialmente diverso rispetto a come aveva affrontato la crisi dei “debiti sovrani”. C’era molto da criticare nelle politiche della Banca Centrale Europea e nello stesso piano “Next Generation EU”: e tuttavia il principio della mutualizzazione del debito si era in qualche modo affermato, e ingenti risorse erano state mobilitate per ricostruire società ed economie stremati da due anni di pandemia. Una virtualità democratica si offriva alle lotte e ai movimenti sociali. Con l’avvio della guerra abbiamo assistito a un violento scarto, a un passaggio dall’insistenza sulle politiche di welfare alla priorità del riarmo e al crescente ruolo dei Paesi dell’Europa orientale, per cui l’appartenenza alla NATO è sempre stata più importante dell’appartenenza all’Unione Europea.
Dobbiamo porre la questione europea al centro del dibattito e dell’azione politica. Nello scenario della multipolarità centrifuga e conflittuale che abbiamo delineato, aprire una faglia all’interno dell’Occidente è di fondamentale importanza. Affermare un interesse europeo separato e distinto da quello atlantico è la condizione per lottare efficacemente contro la guerra, e al tempo stesso per sostenere le vertenze e le mobilitazioni sociali che sono oggi necessarie. Sappiamo che in autunno le ricadute del regime di guerra saranno immediate in Europa, e in Italia in modo particolare. Siamo certi che i prossimi mesi saranno segnati da tensioni e scontri sociali; non siamo affatto certi che prenderanno la forma da noi auspicata. Fin da oggi, dentro lo stesso dibattito elettorale, occorre costruire le condizioni politiche perché questo avvenga. No alla guerra, no alle spese militari, reddito e salario degni per tutti e tutte, intersezionalità delle lotte: su parole d’ordine semplici ritroviamoci insieme per coniugare – ancora una volta, ma in modo sempre rinnovato – lotta di classe e internazionalismo.