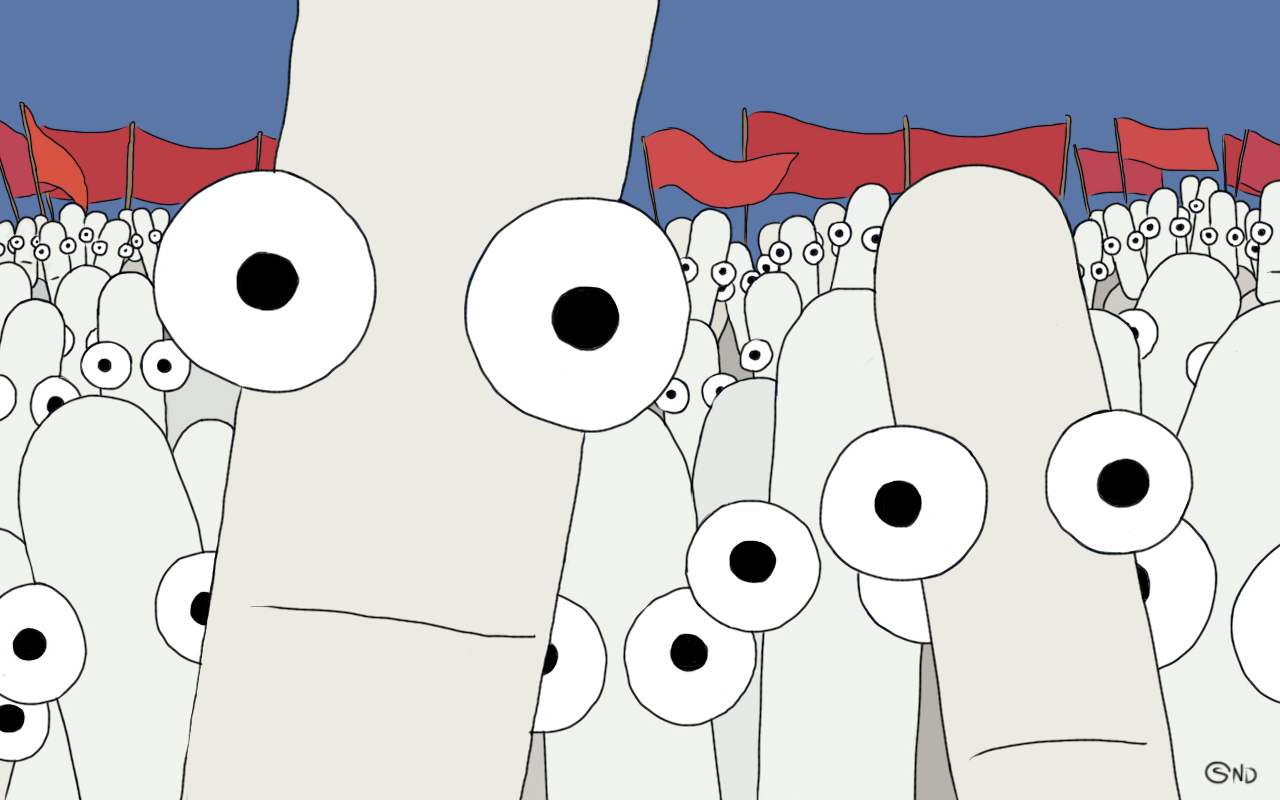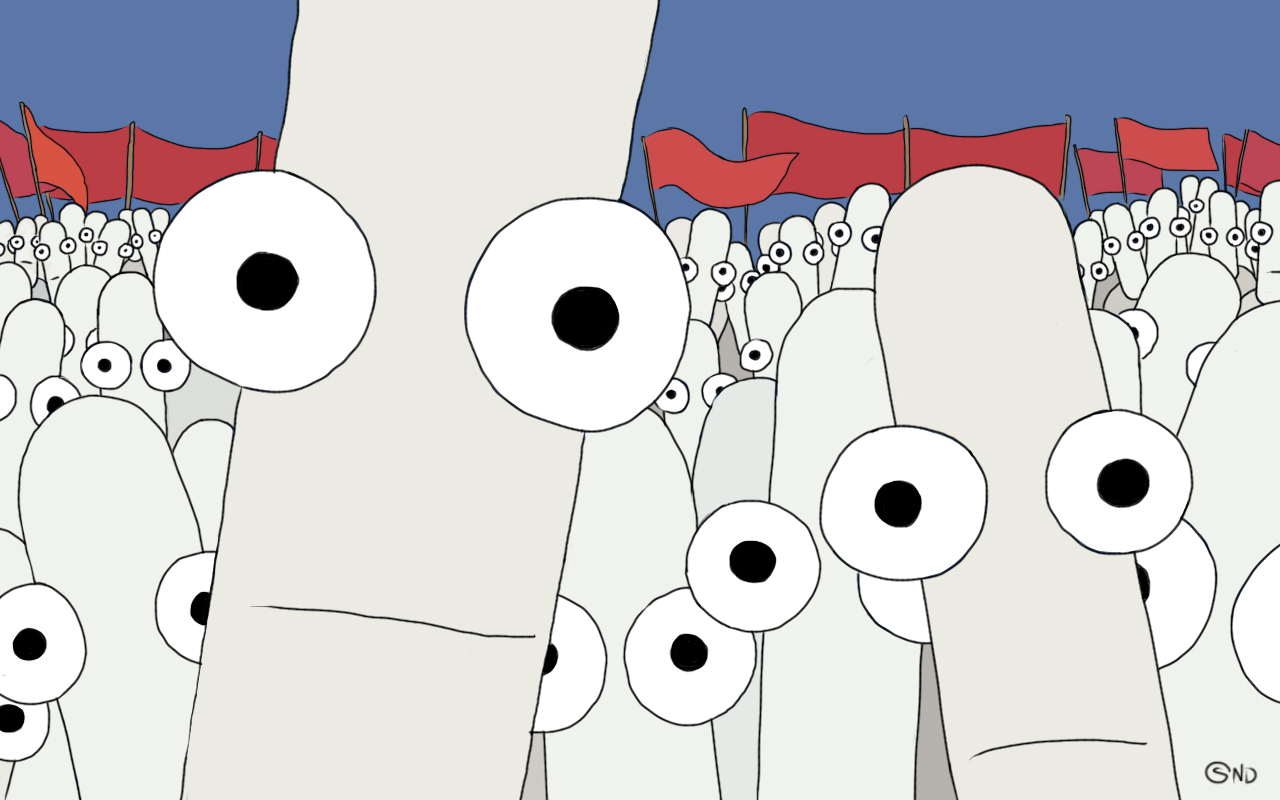di CANTIERE MILANO.
Confini di pietra, confini di carta
“Fosco e impuro, magico e violento: questo è il paesaggio che sin dall’antichità avvolge il gesto di tracciare e istituire un confine” (S. Mezzadra, Confini e Frontiere)
Il confine è un dispositivo che comanda il flusso dei corpi ed attraverso essi anche l’intelletto generale.
Per produrre è indispensabile passare attraverso l’intelligenza collettiva e la molteplicità dei corpi. Per estrarre valore (che sia rendita o profitto) è necessario segmentare, dividere, controllare. Perciò i confini dell’Europa si estendono oggi dal Sahara fino al cuore delle nostre metropoli, sono fisici e normativi.
Nel Mediterraneo si articola un grande gioco geopolitico in cui gli scontri neo-coloniali condotti per procura sono indirizzati allo sfruttamento delle risorse e alla regolazione dei movimenti degli esseri umani.
I campi di concentramento finanziati dai governi europei, nel cuore del deserto libico, per difendere “l’ordine delle cose” sono il primo posto di guardia. Il codice di condotta delle navi nel Mediterraneo che porta il nome di Minniti è l’istituzionalizzazione di un fossato: senza la guardia chi tenta di attraversarlo diventa invisibile.
Sulla costa Nord nelle anticamere d’Europa l’uso indiscriminato della forza si accompagna cinicamente alla celebrazione della magnanima superiorità occidentale. Essa si incarna nelle norme che impongono a chiunque arrivi in Italia e in Grecia di dichiararsi rifugiato, nelle norme carcerarie dell’accoglienza straordinaria, nei vertici che stabiliscono le quote massime di homo sapiens da accogliere nel consesso della specie umana propriamente detta, quella in cui anche i neri devono aspirare ad essere bianchi.
L’accoglienza stessa diventa terreno di scontro. I nemici dell’accoglienza sono coloro che propongono la guerra: casa su casa, frontiera su frontiera sostengono che la superiorità occidentale sarebbe meglio garantita limitandosi a sparare. Si scagliano contro chi propone di salvare qualche vita e, con essa, l’onore dell’Europa. Ovviamente noi non sappiamo che farcene dell’onore dell’Europa, è indispensabile però puntare lo sguardo sulle vite prese in trappola da questa macchina militare-normativa-linguistica-burocratica: vite migranti innanzitutto, prese in trappola senza diritto di fuggire e senza diritto di restare, vite solidali incastrate in un corpo complice e in ruolo coloniale, vite estranee, intossicate dalla passione triste del rancore contro i nuovi poveri che vengono a prendere il loro posto nel mondo.
Dentro l’Europa i confini si traducono immediatamente in comando sul lavoro, sfruttamento dei corpi e espropriazione monetaria.
L’agricoltura, la logistica, l’edilizia sono settori attraversati da forme di sfruttamento neo-schiavistico in cui il colore della pelle viene utilizzato esplicitamente come strumento di segmentazione della classe, ma questo schema si ripete anche nei quartieri popolari delle grandi città dove la precarizzazione della vita è fatta anche di mancanza di alloggi e criminalizzazione delle pratiche di illegalità diffuse dettate dalla necessità.
L’illegalità della vita migrante, dell’occupazione delle case o della “economia informale” ritagliano un ruolo specifico per la repressione da parte della legge: quella di confine onnipresente e selettivo. Un panopticon malfunzionante incombe sulla vita di milioni. Corrispondere alla legalità è impossibile, rifiutarla pericoloso: un ulteriore carico sulla precarietà esistenziale.
Rompere i confini, comunque essi si presentino, è dunque una necessità della vita, una istanza immediata di liberazione.
Corpi nella metropoli: meticciato e intersezionalità
“Come raccontare una storia / frantumata? / Diventando pian piano / ogni persona. No. / Diventando pian piano ogni cosa” (Arundhaty Roy, Il ministero della suprema felicità)
 Meticciato, dicono Nouss e Laplantine, è innanzitutto una nozione culturale che ha assunto valenze diverse nel corso dei secoli e della storia. Certamente il meticciato come pensiero della trasformazione, che si contrappone al mito della purezza della razza, o della nazione, o della comunità, ha tutta la nostra simpatia. Per lo stesso motivo gitani e ebrei apolidi sono stati (drammaticamente) l’incubo degli sciovinisti dell’inizio del secolo scorso, fino allo sterminio. Chi partecipa alla soggettività meticcia delle metropoli rivendica di essere cittadino del mondo in quanto cittadino del qui ed ora, contro ogni mistica nazionalista e nello stesso tempo incarna la ricchezza della molteplicità, rifiuta di essere ridotto all’uno anche se esso si presenta come “unità globale”. Un po’ come le lingue creole e le lingue dei porti, l’identità meticcia è inafferrabile, immanente e trasformativa per definizione.
Meticciato, dicono Nouss e Laplantine, è innanzitutto una nozione culturale che ha assunto valenze diverse nel corso dei secoli e della storia. Certamente il meticciato come pensiero della trasformazione, che si contrappone al mito della purezza della razza, o della nazione, o della comunità, ha tutta la nostra simpatia. Per lo stesso motivo gitani e ebrei apolidi sono stati (drammaticamente) l’incubo degli sciovinisti dell’inizio del secolo scorso, fino allo sterminio. Chi partecipa alla soggettività meticcia delle metropoli rivendica di essere cittadino del mondo in quanto cittadino del qui ed ora, contro ogni mistica nazionalista e nello stesso tempo incarna la ricchezza della molteplicità, rifiuta di essere ridotto all’uno anche se esso si presenta come “unità globale”. Un po’ come le lingue creole e le lingue dei porti, l’identità meticcia è inafferrabile, immanente e trasformativa per definizione.
Oggi nelle metropoli europee il meticciato è una condizione fondamentale della produzione e quindi della vita. Nella ricerca di un “divenire meticcia” incontriamo un processo di soggettivazione: lo sviluppo di un pezzo di coscienza di classe. Se è vero che ancora oggi le linee del colore, in tutto il mondo, segmentano la moltitudine, allora riconoscersi meticce significa praticare un esercizio di stare assieme, fuori e contro le linee di forza del comando, significa non accettare le deportazioni e abbattere i confini di fronte a sé.
Non è poi così diverso ciò che accade oggi grazie alla forza d’urto del movimento femminista. La lotta intersezionale delle femministe afroamericane segna un salto teorico e pratico nel modo di concepire la strada verso la liberazione.
L’intersezionalità non reclama la giustapposizione o la somma di istanze di conflitto ma problematizza il punto di vista dal quale esse vengono elaborate. La matrice di potere e oppressione si è globalizzata e ha corrotto e pervaso linguaggi e forme di vita ma rimane specifica di un sistema di pensiero collocato nello spazio e nel tempo. Non si tratta di un nemico universale, senza volto e senza nome ma di uno specifico modo di gerarchizzare e ordinare il mondo.
Gli strumenti filosofici, politici, culturali ed economici che da qualche secolo servono a questo scopo devono essere riconosciuti e riconoscibili in ogni loro parte; in questo caso la parte non vale per il tutto.
Classe, Genere, Razza. Questi criteri di suddivisione si formano e cominciano ad essere operativi ed efficaci dall’inizio della modernità proprio perché non isolabili gli uni dagli altri. La loro forza e durevolezza è garantita proprio dalla loro inestricabilità. Le forme di oppressione non si intersecano in un solo punto.
Per questo risulta artificioso e inefficace isolare questi criteri di oppressione. Se pensiamo di poterli vedere con maggiore precisione osservandoli nella loro purezza, allora costruiamo un’immagine falsata e parziale della storia materiale di questi dispositivi. Rischiamo di parlare delle vite di alcune persone, quelle che hanno il privilegio di vivere sulla loro pelle solo precarietà o solo discriminazione di genere. Ma queste soggettività privilegiate non esistono, sono esse stesse la reiterazione di un mito di indipendenza che si fonda sullo sfruttamento di altre vite. Proprio le soggettività che vivono nella claustrofobia di queste multiple gerarchizzazioni possono riconoscerle e avanzare verso una liberazione che metta il mondo sottosopra.
Arundhati Roy nel suo ultimo libro viaggia attraverso i corpi. Nello scontro tra la vita e il fascismo i personaggi si inventano, si trasformano, si ribellano. Non si tratta solo di essere uomini o donne, o meglio di non essere né l’uno né l’altro; di cercare la liberazione attraverso una identità oppressa e fuggire dalla stritolante macchina da guerra del fanatismo religioso; di ribellarsi alla dannazione perpetua dell’orribile sistema castale. Si tratta soprattutto della ricerca (inevitabilmente collettiva) della felicità. Paradossale ed insieme ovvio: il “ministero della suprema felicità” è un’istituzione del Comune.
Europa come nevrosi. Suprematismo e guerra civile
“La Francia, tempo fa, era il nome di un paese; attenti che non sia, nel 1961 il nome di una nevrosi” (Jean Paul Sartre, prefazione de I dannati della terra di Franz Fanon)
Il nostro umanesimo, se visto tutto nudo, non è mai stato bello. Di questo ci avvisava già Sartre, mettendo in guardia il lettore di Fanon. Andava preparato il lettore europeo, abituato al narcisismo del nostro Occidente perché poche pagine dopo avrebbe sentito qualcuno che non parlava a lui, nemmeno quando voleva parlare di lui.
Abbandoniamo quest’Europa che non la finisce di parlare dell’uomo pur massacrandolo dovunque lo incontra, in tutti gli angoli delle sue stesse strade, in tutti gli angoli del mondo. Sono secoli… che in nome d’una pretesa “avventura spirituale” essa soffoca la quasi totalità dell’umanità. (F. Fanon 1961)
Oggi, nel declino geopolitico dell’Europa si annida la possibilità del fascismo non meno che nell’apogeo della potenza coloniale. Ma questa volta è nevrotica. Come sempre l’Europa non vede altro che sé pur comprendendo in uno sguardo il mondo.
Un viaggiatore tornato in Francia 40 anni dopo l’indipendenza algerina avrebbe visto la rivolta delle banlieues. La solita violenza indigena, la solita incomprensibile “racaille”.
Colui che distrugge è in realtà colui che è incapace di produrre: è l’improduttività dei sobborghi nella migliore delle ipotesi: un’improduttività strutturale che è quasi “naturalizzata” perché si evita accuratamente l’interrogatorio; oppure peggio: un’improduttività radicata in questa “pigrizia naturale” e questo “amore della struttura” che si suppone ai buoni (e cattivi) selvaggi. (J. Revel 2005)
L’Occidente è in preda ad una frenesia suprematista, proprio quando dal punto di vista demografico e sociologico, ancora prima di porsi il problema di una soggettivazione, di una moltitudine, è diventato impossibile negare che la società sia una somma di minoranze. In USA Trump vince nonostante l’uomo bianco, wasp, conservatore sia diventato, dal punto di vista statistico, una frazione della popolazione.
Michael Moore con la consueta ironia ha sintetizzato questo come il “grido di un dinosauro”. Anche in Europa non esiste più un dentro e un fuori. La guerra suprematista è possibile solo come guerra civile, non tra classi ma tra retoriche reazionarie. In assenza di frontiere da reclamare è il tempo delle frontiere da inventare. Opposti fanatici che sono d’accordo su quasi tutto, tranne che sul nome da dare all’idea reazionaria che hanno del mondo.
È superiore l’Islam o l’Occidente? Cosa ci importa se chi li agita come clave ci chiede di chinare la testa? La natura fascista della destra europea risulta occultata proprio da questa finzione della difesa della superiorità “secolare” dell’Occidente.
La natura fascista del jihadismo si rivelava ieri nella sua pubblicistica, ed oggi nell’orribile strage al Bataclan, sprezzantemente definito “luogo di idolatri”. Così come nella duplice pratica della castità come valore, e della schiavitù sessuale imposta ai corpi femminili.” (G. De Michele 2016)
Alle lotte anche il compito di svelare l’inganno.
Popolazione, moltitudine, pachamama
“Un mondo che contiene molti mondi” (SubComandante Marcos, EZLN)
In un saggio intitolato “la natura della popolazione” Alessandro Pandolfi, dopo aver ripercorso l’analisi della nascita del concetto di popolazione, secondo Foucault, e lo sviluppo di una tensione antagonista tra ordine e desiderio conclude con queste parole:
Nei riguardi di questi due momenti teorico-politici – il malthusianesmo intrinseco all’economia politica e il razzismo –, Marx si pone, per Foucault, come un punto di resistenza e come un’alternativa. C’è, dunque, un’alternativa alla popolazione? E saremmo tentati di dire alla biopolitica?
Oggi, mentre il pianeta procede verso la catastrofe ecologica ma il dibattito delle “opinioni pubbliche” dei paesi che si vantano di averle si chiede “dove metteremo un miliardo e mezzo di Africani” è più che mai necessario cercare questa alternativa.
A nostro avviso lo sviluppo della moltitudine, come progetto di organizzazione politica, come espansione del comune, si pone su questa strada. Ma se questo progetto politico cerca la sua forza nella molteplicità, quali straordinarie possibilità schiude la contemporaneità?
La globalizzazione è un processo in cui domina il neoliberismo, non meno di quanto la “scoperta delle Americhe” fu un processo coloniale.
Ma è altrettanto importante non sottovalutare le tendenze utopiche che hanno sempre accompagnato la dinamica della globalizzazione, anche se sono state sconfitte dai poteri sovrani. L’amore per le differenze e la fede nella libertà e nell’uguaglianza universali espressi dall’umanesimo rinascimentale riappaiono su scala globale. (Negri, Hardt, 2000)
È una macchina del pensiero che diventa il programma politico di “rivoluzione globale”, la stessa che consente a Toussaint de l’Ouverture di dire alle armate napoleoniche che sbarcano ad Haiti per ripristinare la schiavitù: “credete davvero che gli uomini che hanno gioito per la benedizione della libertà accetteranno serenamente di esserne privati?”. Questa macchina non funziona certamente in una direzione sola: non solo un altro, ma molti mondi sono possibili. Bisogna far funzionare la macchina anche in senso inverso, da Sud a Nord.
Si calcola che a partire dalle prime deforestazioni e dai primi insediamenti agricoli l’uomo abbia trasformato tra un terzo e una buona metà della superficie terrestre, deviato il corso della maggior parte dei fiumi, modificato gli ecosistemi, alterato la composizione dell’aria e dell’acqua. Ma è senza dubbio a partire dalla prima rivoluzione industriale che questo processo ha visto un’esponenziale crescita della sua rapidità, dimostrando come sebbene l’uomo abbia sempre avuto un impatto considerevole sul clima, è il modello di “sviluppo” capitalista che sta rendendo la nostra condizione sempre più simile a quella dei dinosauri: le tempeste distruttive della prima era interglaciale avvennero con meno di un grado in più rispetto ad oggi.
Il capitalismo neoliberista si presenta come l’unica prospettiva possibile, ma è il frutto di una storia (e di una geografia) particolare. Viveiros De Castro sostiene che il capitalismo non avrebbe mai potuto affermarsi nelle regioni sudamericane, africane o orientali, non certo perché queste fossero selvagge o primitive, come ci hanno raccontato per anni le scienze sociali della struttura economica dominante, ma perché queste partivano da concezioni del mondo, e quindi da mondi, radicalmente differenti. Il capitalismo è nato in Europa e non poteva che essere così. In Europa si sono sviluppati gli antecedenti culturali in grado di creare l’humus adatto: l’enfasi posta sulla razionalità dei primi filosofi greci e la piramide degli esseri di Aristotele, l’uomo garante del Creato per il Cristianesimo, le partizioni dualistiche cartesiane (res cogitans/res extensa, mente/corpo, uomo/mondo), il contrattualismo, l’etica protestante del lavoro, la filosofia utilitarista, il posizionamento illuminista dell’uomo al centro del cosmo, la fede positivista nelle capacità delle scienza e della tecnica. Popolazioni che partivano da premesse culturali radicalmente differenti, approdano necessariamente a conclusioni altre. Non è un caso che, mentre annientavano intere popolazioni, le truppe di invasori europei abbiano dedicato una particolare attenzione alla distruzione delle biblioteche e dei centri di cultura, durante la conquista delle americhe. Chissà quali sarebbero oggi gli scenari se i processi coloniali non avessero rallentato e imbrigliato con le armi, con l’acciaio e con le malattie lo sviluppo delle linee di fuga originate da queste premesse. La colonizzazione si è peraltro dispiegata anche in Europa. Lo sterminio secolare degli eretici (dai poveri di Lione ai contadini di Müntzer) si è rivolto contro la sfida lanciata da un mondo ricco di desideri e saperi ostili al feudalesimo, la caccia alle streghe è stata l’intenzionale espropriazione dei speri femminili in materia di ri-produzione.
Con le migrazioni, assieme ai corpi, si spostano anche apparati di sapere: la sfida oggi è di cogliere l’opportunità del meticciato per aprire prospettive inedite. Non si tratta di attingere alle idee meno tossiche delle culture non–occidentali per salvare ancora una volta la pelle bianca, di stabilire un patto tra la terra e il profitto e chiamarlo “sostenibilità ecologica”. Si tratta di costruire alleanze tra ecologie radicali, movimenti metropolitani e rurali, ad esempio cominciando a immaginare la Pachamama, la madre terra delle culture indigene, come un punto di riferimento per tutti e tutte.