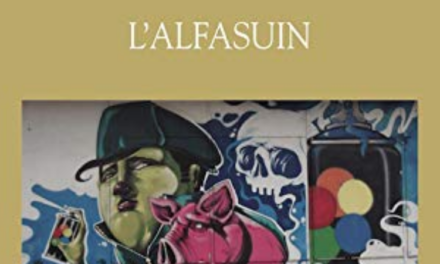Di SIMONE PIERANNI.
Leggere Mark Fisher giorno per giorno significa poter scegliere i temi – in modo random – da un algoritmo scevro di capitale, lasciandosi trasportare dai salti logici e di argomento come in un brano di Rufige Kru e poi vedere comporsi quello che poteva essere il suono di una nuova società socialista capace di spazzare via, di annientare, il realismo capitalista; cioè la constatazione che il capitalismo è stato in grado di ristabilire antichi rapporti di produzione e sociali, promettendo un futuro sempre uguale a se stesso, senza alcuna alternativa, senza alcuna possibilità di pensare a qualcosa di nuovo, di diverso. E a essere colpiti da questa forza del neoliberismo, pur cangiante nel tempo, è stata proprio la sinistra.
LEGGERE MARK FISHER giorno per giorno è un’occasione fornita da Il nostro desiderio è senza nome (Minimum Fax, pp. 392, euro 20, traduzione di Vincenzo Perna), primo di quattro volumi pubblicati da Minimum Fax che raccolgono quanto Fisher ha scritto sul suo blog k-punk prima del suo suicidio avvenuto tre anni fa, il 14 gennaio 2017. Una miscellanea, una tracklist senza gerarchia, un insieme di argomenti tipici della produzione di Fisher che disegnano un quadro dalle mille fughe, a rincorrersi e ritrovarsi in una anti-ontologia desiderante da contrapporre all’ontologia aziendale del realismo capitalista e della sinistra «iper-lavorista». Il linguaggio, immediato e colloquiale del blog, infatti, si scontra in modo letale con quel «linguaggio aziendale» che ha imposto il suo discorso affermando la necessità di eccellere, produrre, distinguersi.
E il filo sottile che accompagna il neoliberismo a imporsi in modo globale è il consueto di Fisher, la depressione individuale, non più mediata e contrastata dalle grandi organizzazioni di sinistra, i sindacati per esempio: in passato, scrive l’atore, «se la tua paga e le tue condizioni di lavoro peggioravano potevi rivolgerti ai sindacati e organizzarti, mentre oggi, se per esempio lo stress sul luogo di lavoro aumenta, vieni incoraggiato a considerarlo un tuo problema e risolverlo in modo individuale». Il realismo capitalista si prende tutto, distrugge il vecchio e crea forme apparentemente nuove, la flessibilità, la precarietà, che riportano ancora più indietro nel tempo in termini di sfruttamento e – sopra ogni cosa – di annientamento di alternative: there’s no alternative, si chiosava. E Fisher sottolinea – in un articolo del 2013 – il potere delle piattaforme e la sua natura implacabile di estrazione ed espropriazione di ricchezza da ciascuno di noi, convincendoci, in realtà, di essere liberi: «tutto il tempo è imprenditoriale perché la merce siamo noi, quindi tutto il tempo che non trascorriamo a vendere noi stessi è tempo perso».
La scrittura e l’elaborazione di Fisher – insieme alla sua storia – hanno costituito un passaggio fondamentale, molto prima che venisse tradotto in Italia, per quelle comunità nate negli anni ‘90 da collettivi di hacker e sballati di rave, libertari nel procedere filosoficamente e inseparabili da alcuni cardini del pensiero di Fisher, come Deleuze, Foucault, Rosi Braidotti e Donna Haraway e tutta la controcultura che aveva intravisto la possibilità di realizzazione del «desiderio».
PROPRIO DI FOUCAULT, Fisher riprende una citazione-manifesto di tanti hacklab e collettivi nati negli anni ‘90 in Italia -: «il problema non è recuperare la nostra identità perduta, la nostra natura imprigionata, la nostra verità di fondo, ma invece muoversi verso qualcosa di radicalmente diverso». Gli scritti politici costituiscono le basi acide di quanto Fisher aggiusterà, modificando o tagliando, in Realismo capitalista (pubblicato in Italia da Not). Il nostro desiderio è senza nome si presta a una lettura disordinata, permette un’osservazione del «dietro le quinte» del pensiero di Fisher in cui è presente sia la sua critica alla sinistra anglosassone, sia le sue passioni per tutto quanto è cultura pop, film, musica, libri, capaci di dialogare tra loro ed esemplificare molti dei meccanismi alla base del realismo capitalista, con svisate psichedeliche capaci di mischiare piani culturali e di lettura apparentemente lontani (I read the news today oh boy, la virata Lsd di «A day in the life» dei Beatles, per esempio). Nei tanti capitoli del volume non può mancare l’origine della passione di Fisher per la ricerca di qualcosa di nuovo, diverso, di completamente fuori da ogni schema già pensato, tanto capitalista, quanto di sinistra (basti pensare alla divertente parte della raccolta in cui uno dei protagonisti è l’arcigno Super-Ego-Leninista).
Mark Fisher, infatti, ha un percorso ben preciso, che nasce tra i suoni della jungle, dei live coding, del silicio che si fa rete e permette di immaginare qualcosa di prefigurato. C’è tutta l’esperienza di Warwick e di quella Ccru (Cybernetic Culture Reasearch Unit) che ha rappresentato un momento fondante, storico e in grado di rilasciare innumerevoli derive della controcultura. Quest’ultimo fenomeno è la speranza, talvolta uccisa e devastata, ma ancora latente che si possa cambiare: non qualcosa, ma tutto.
Ne Il nostro desiderio è senza nome si ritrovano tutti i filoni che Mark Fisher ha sviluppato nella sua poetica a cominciare da quella che lui stesso ha definito «l’ossessione» per gli anni ‘60. Un pungolo incessante che non è – intanto – una nostalgia, perché quest’ultima, come ha scritto Benedetto Vecchi che sul manifesto ha recensito, oltre a Realismo capitalista (24 gennaio 2018) anche The Weird and the Eeire (primo settembre 2018) e Spettri della mia vita (20 giugno 2019) (entrambi pubblicati in Italia da Minimum Fax) è un sentimento reazionario e Fisher lo definisce «chiamando a raccolta alcuni autori molto amati, Friederic Jameson e Jacques Derrida, in particolar modo le analisi sulla modalità nostalgica del marxista e critico del postmoderno statunitense e il mimetismo del filosofo francese emergente nella tematica dell’hauntology».
QUESTA OSSESSIONE per gli anni ‘60 non è solo sua, a dimostrazione di un percorso che non è stato un processo individuale. Lo scrittore inglese Hari Kunzru (di cui di recente il Saggiatore ha pubblicato il bellissimo Lacrime bianche) – anch’esso nel giro della Ccru – nel 2015 per il Guardian ha scritto di Dune (con riferimento sia al libro di Frank Herbert sia alla trasposizione cinematografica di Lynch), segnalando che «Ogni fantasy riflette il luogo e il tempo che l’ha prodotto. Se Il Signore degli Anelli parla dell’ascesa del fascismo e del trauma della seconda guerra mondiale e Il Trono di Spade, con la sua cinica realpolitik e i suoi personaggi imprenditoriali, è una fiaba del neoliberismo, allora Dune è il fantasy paradigmatico dell’Età dell’Acquario. Le sue preoccupazioni – lo stress ambientale, gli stati di coscienza alterati e la rivoluzione dei paesi in via di sviluppo contro l’imperialismo – si fondono in una visione che definisce l’era della trasformazione personale e cosmica».
FISHER ANNOTA in k-punk: «È possibile riprodurre, più avanti nella vita, l’impatto che libri, dischi e film hanno tra i quattordici e i diciassette anni?» In fondo, alla Ccru e nei suoi scritti Fisher non ha fatto che tornare lì, alla possibilità di ascoltare e vivere qualcosa di nuovo, di immaginato. Tecnicamente questo è il suono primordiale della sua poetica, l’«iperstizione», l’immaginario che diventa realtà. A ostacolare questo processo ci siamo noi, tutti noi, agguantati dal tonfo profondo del monocorde realismo capitalista.
Ne Il nostro desiderio è senza nome l’ultimo capitolo è costituito dall’introduzione ad Acid communism, un’idea di libro nella quale Fisher riprende un’espressione di Marcuse, «Lo spettro di un mondo che potrebbe essere libero» per raccontare che «il fallimento della sinistra dopo gli anni Sessanta è dipeso in buona parte dal suo ripudio delle fantasie generate dalla controcultura o dal suo rifiuto di affrontarle». Tra queste fantasie c’è, ed è presente quasi in ogni pagina del volume, il rifiuto del lavoro alla ricerca «di una nuova umanità, un nuovo modo di vedere, di pensare, di amare», il vero lascito di Fisher: non solo una società nuova, ma un’umanità totalmente differente da quella attuale.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 29 gennaio 2020.