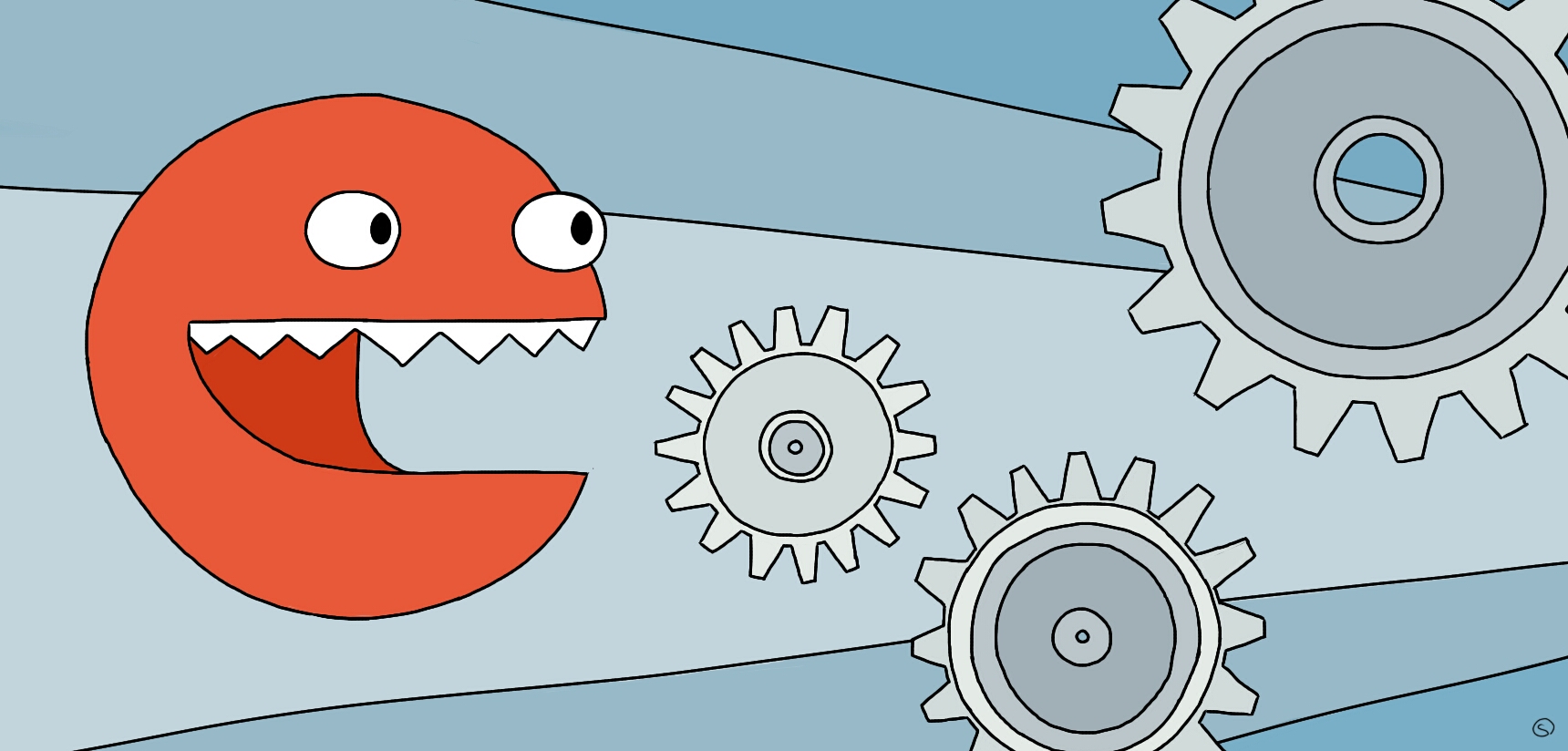di ANTONIO NEGRI.
Questo intervento è stato fatto in francese al Congresso Marx Internazionale IV, nel settembre 2004 a Parigi. Questa è la prima traduzione italiana. Ho ripreso questo intervento perché mi sembra utile nel discutere contro le tentazioni “nazionaliste” (in realtà solo “populiste”) che cominciano a nascere e a presentarsi nel dibattito delle sinistre riformiste in questa fase di crisi. Quanta nostalgia piccolo-borghese per un nulla di possibilità e di scopo! Abbasso l’ideologia!
La mia impressione, quando sono emerse le prime polemiche attorno al concetto di “Empire”, è stata che il rifiuto teorico di questo concetto (in quanto nuova figura della sovranità all’interno e al di sopra della mondializzazione dei mercati) non fosse pertinente. Il concetto di Impero, in sé, come ordine nella e sulla globalizzazione dei mercati, è infatti in qualche modo evidente. Quelli che rigettano il concetto di Impero in nome dell’importanza delle antiche categorie dell’imperialismo lo fanno piuttosto perché rifiutano – politicamente– quel primo concetto: essi vedono infatti nella figura e nella presenza dello Stato-nazione la condizione essenziale dell’agire politico. Essi rifiutano, per così dire, il concetto di Impero per sé, considerandolo insufficiente a fronte dell’urgenza della lotta e dell’organizzazione, che essi non possono concepire al di fuori del terreno costituzionale dello Stato moderno. Il problema, dunque, appare quando noi sosteniamo che è proprio su un terreno politico ed organizzativo che oggi è necessario andare al di là dello Stato-nazione.
[Per procedere sul terreno teorico, vorrei tuttavia sottolineare che una delle rare critiche che siano state sviluppate sul tema dell’Impero in sé (quelle di Jacques Bidet, che sostiene che questo concetto oltrepasserebbe e mistificherebbe quella tradizione dell’analisi marxista che stabilisce, da una parte, la struttura del potere e dello sfruttamento capitalista e, dall’altra parte, il sistema-mondo, articolato nella gerarchia della dipendenza), è stata successivamente presa in conto in “Multitude”. Presa in considerazione ma anche trasformata per non appiattirla sulle vecchie figure dell’imperialismo: comunque le conclusioni di Jacques Bidet, quando non tendano a sopravalutare la mediazione statale, sono in realità accettabili sul terreno politico, vale a dire sul terreno dell’Impero per sé, come vedremo in seguito.
Devo dunque difendere il concetto di Impero e rilanciare le tematiche politiche (che riprendono e sussumono le tematiche teoriche) qui presentate. Per farlo vorrei qui riprendere l’analisi a partire dall’identificazione della crisi dello Stato-nazione, non semplicemente per insistere su essa ma soprattutto per illustrare i problemi che essa pone per la costituzione del mercato mondiale e della sovranità imperiale.
1.
Il primo momento di critica lo si può affermare sul terreno della critica dell’economia politica. In realtà, è a partire dalla crisi dell’organizzazione internazionale del lavoro che si comincia a cogliere il superamento del concetto (e della realtà) dello Stato-nazione. Non penso naturalmente ai soli effetti, o meglio alla sola effettività politica, del regime mondiale degli scambi, alla crisi dei parametri monetari, economici e culturali che permettevano il controllo dello Stato-nazione sullo sviluppo: parlo di una dimensione più profonda, essenziale, vale a dire del mutamento radicale della forma della valorizzazione e dei dispositivi di sfruttamento. Oggi, la forma della valorizzazione è modificata dall’egemonia – tendenziale ma sempre più effettiva – del lavoro immateriale (intellettuale, razionale, linguistico, affettivo, ecc.) sopra e dentro il processo produttivo. Il nuovo processo di valorizzazione non può più essere contenuto dentro spazi territorialmente chiusi. È dominato dalla mobilità dei fattori produttivi e delle forze di produzione. Esige inoltre un’universale libertà di comunicazione. Appare così un nuovo tableau économique. Esso rappresenta unanuova figura di relazioni e di scambi fra settori produttivi; esso assicura la preminenza dei fattori sociali sui fattori imprenditoriali (o puramente industriali); mostra che i processi finanziari occupano una funzione predominante in rapporto all’investimento diretto; esprime l’enorme potenza dell’industria della comunicazione; manifesta la mobilità ormai irresistibile delle multinazionali produttrici di merci e di servizi, ecc.. Insomma, il tableau économique è nuovo ed è dominato dalle forze che hanno saputo interpretare il General Intellect produttivo. Il tableau économique del General Intellect ci fa saltare al di là dello Stato-nazione.
[Ed è del tutto irrilevante che la nostra concezione sia accusata, dal punto di vista doxografico, di essere un’interprezione troppo estensiva delle tematiche marxiane: quel che ci importa è che questo nostro discorso (e questo momento critico) siano politicamente efficaci nella tradizione del metodo marxista, cioè storicamente incisivi e determinati.]
In secondo luogo, anche i dispositivi dello sfruttamento sono completamente modificati. La legge del valore (e dunque del plusvalore), considerata secondo la definizione elementare che ne dà Marx, è divenuta inefficace salvo, forse, in settori marginali dello sviluppo. Lo sfruttamento si configura come espropriazione dei valori della cooperazione e della circolazione produttiva, come appropriazione capitalista dell’eccedenza innovatrice del lavoro immateriale nell’organizzazione sociale del lavoro, come captazione del comune.
[Invito il lettore a ripercorrere, a proposito di questi concetti, l’analisi marxiana della rendita fondiaria e le pagine sull’estrazione di plusvalore nell’industria dei trasporti: qui si trovano anticipazioni fondamentali delle nostre ipotesi.]
I dispositivi dello sfruttamento sociale si presentano ormai secondo l’estensione e la comprensione dello spazio globale. Lo Stato-nazione è assolutamente inefficace a fronte di quella forma cellulare fondamentale, ed alle metastasi, dello sfruttamento che si sviluppano immediatamente su scala mondiale. Questo significa che ogni forma dell’insubordinazione, di lotta contro il lavoro salariato, che ogni ribellione – quand’essa si rivolge contro lo sfruttamento, riconoscendone la nuova natura – deve essere capace di riconoscersi come moltitudine. Ecco in effetti che cos’è la moltitudine: il riconoscimento della singolarità delle nuove forme di produzione di valore, e quindi dello sfruttamento sociale che ne deriva, così come il superamento della dimensione ristretta del concetto di classe operaia nell’organizzazione della rivoluzione. Lo Stato moderno è la forma politica specifica dello sfruttamento capitalistico nello spazio-nazione. Questa determinazione statuale non tiene più a fronte dell’insubordinazione che si dà nelle condizioni attuali della valorizzazione e dello sfruttamento. Parlare di Stato-nazione e di imperialismo senza periodizzarne la figura e la durata diviene molto pericoloso – quasi reazionario.
2.
Il secondo elemento della crisi dello Stato-nazione può essere identificato a livello della teoria marxiana della crisi. Anche a questo proposito, lo spazio-tempo dello Stato-nazione manifesta la sua insufficienza per la spiegazione critica della figura attuale della crisi economico-politica. È in realtà evidente che, dei tre tipi di crisi capitalista studiate da Marx – crisi legata ad una sproporzione nel seno della produzione (sotto-produzione, sovrapproduzione); crisi di circolazione; crisi legata all’abbassamento tendenziale del tasso di profitto –, le due prime certamente, ma molto probabilmente anche la terza, rappresentano il tipo di crisi al quale rispondevano misure efficaci di controllo keynesiano e post-keynesiano: tutto ciò si è progressivamente sviluppato fuori dal terreno dello Stato-nazione, a livello mondiale (dagli accordi di Bretton Woods in poi). Inoltre, le ultime gradi crisi hanno definitivamente fatto saltare i vecchi modelli della dipendenza imperialista (e/o coloniale), ed hanno costantemente riqualificato l’integrazione globale, talvolta presentandola come interdipendenza. Dagli anni trenta, dal New Deal, la crisi è divenuta una crisi controllata (e/o provocata dentro un’articolazione di intervento economico e di comando politico poste fra struttura dello sfruttamento e sistema gerarchico mondiale – per riprendere lo schema di Bidet). Ma è qui che interviene la modificazione qualitativa. Se, in realtà, il processo di regolazione economica della crisi è stato condotto con tecniche sempre più efficaci e sofisticate (dalla disciplina al controllo, dal keynesismo al monetarismo, ecc.), esso è stato, per ciò stesso, portato ed istallato sempre di più sul terreno biopolitico. Ed è dunque sul terreno del biopolitico che la crisi deve essere oggi identificata e definita. Se è vero che le sproporzioni e i blocchi della circolazione non potevano più determinare degli effetti disastrosi e che si trovano ora controllati in anticipo, se la caduta del tasso di profitto è continuamente controbilanciata e/o compensata da un aumento della produttività del lavoro, allora gli altri temi dell’identificazione della crisi e le proposte di lotta dentro la crisi debbono essere essi stessi rapportati a queste nuove dimensioni. Ritroviamo qui la tematica proposta più sopra a proposito della riconfigurazione dell’organizzazione del lavoro e della riformulazione della teoria dello sfruttamento.
La crisi, oggi, si presenta essenzialmente come difficoltà di controllare le nuove forze sociali della produzione, tanto per quanto riguarda la loro potenza che si estende alla vita sociale, quanto perché la loro espressione è quella dell’eccedenza produttiva, della ricerca della libertà politica e culturale, dell’identificazione di valori comuni. Quando la produzione diviene biopolitica, che vuol dire che essa investe tutti gli aspetti della vita; quando il potere diviene biopolitico e cioè quando esso attraverso imperativamente (e tenta di configurare così) tutti i movimenti sociali – e le forme di vita – che producono valore, allora la crisi si definisce, dal punto di vista capitalistico, non solamente come difficoltà e ostacoli, più o meno marginali, della produzione e/o della circolazione, ma come il prodotto di un insieme di resistenze che nascono dall’attività produttiva, sempre eccedente, delle moltitudini. Ed è precisamente su questo terreno che il neoliberalismo è fallito, quando esso ha mantenuto (meglio, accentuato) il vecchio modello di controllo, senza rendersi conto che la composizione della forza-lavoro si era completamente modificata. L’eccedenza produttiva (che ha come base tecnica il lavoro immateriale e come sbocco politico l’attività costituente delle moltitudini) non può più essere racchiusa nelle forme e nei processi di controllo che i metodi “scientifici” di organizzazione del capitalismo moderno avevano costruito sulla base del lavoro massificato e fordista.
È a fronte di questa realtà che deve essere posto il problema dello Stato nazionale moderno. L’imperialismo è stato l’espansione dei capitalismi nazionali, dei capitalismi nazionali strutturati da sistemi di produzione, di controllo e di sovranità assolutamente tradizionali. Quando la mobilità e la flessibilità dei lavoratori, le immigrazioni interne ed internazionali e la produzione eccedente di valore da parte delle moltitudini entrano in gioco, se lo Stato-nazione si trova in difficoltà, quelle proiezioni imperialiste lo conducono al disastro. La polemica di “Empire” è rivolta contro lo Stato-nazione, nella misura in cui essa fa risaltare un tessuto politico-economico nel quale la lotta di classe ha introdotto elementi irriducibili (eccedenza, mobilità, nuova gestione operaia del tempo e dell’innovazione produttiva) dentro la vecchia forma dello Stato. La crisi dunque concerne il contesto sociale nel suo insieme. La crisi si presenta come una mancanza di controllo sugli eventi produttivi e politici, perché questi non possono più essere controllati: nel contesto biopolitico, gli eventi sono in realtà imprevedibili, crisi inattese, genesi radicali… Lenin ci ha offerto, dal punto di vista dell’analisi della crisi, delle anticipazioni teoriche infinitamente più utili (oggi, nel postmoderno) di quanto non abbiano mai potuto fare gli “economisti della cattedra”, fossero austriaci o sovietici. Lo Stato-nazione e l’imperialismo sono del tutto disarmati a fronte di quella potenza e di quell’imprevedibilità dei movimenti moltitudinari. Sviluppare oggi una teoria della crisi è inserire l’analisi e agire all’interno stesso dei parametri del nuovo tableau économique. Tutte le grandi esperienze di crisi economica nell’ultimo mezzo secolo si sono sviluppare secondo una complessità biopolitica di riferimento che le hanno rese ogni volta sempre più massicciamente offensive. Se noi consideriamo le cose dal punto di vista tradizionale sull’imperialismo, noi dovremmo ridurre le crisi ad un processo di produzione della “dipendenza”. Ora, si può certamente ancora “produrre della dipendenza”, ma questa dipendenza presenterà una figura di resistenza, immediatamente interna alle strutture ed alle dinamiche del biopotere, contro i tentativi imperialisti per neutralizzare le lotte e di ricostruire a questo scopo, “gabbie” adeguate (“nuove nazioni”, ad esempio, e non è certo un caso). La teoria dell’imperialismo (e della sovranità dello Stato-nazione) non fallisce dunque solamente attorno alla complessità delle relazioni e delle connessioni mondiali che non riesce a comprendere, ma anche attorno a fenomeni strutturali profondi e sul rifiuto inflessibile dello sfruttamento da parte delle moltitudini (o piuttosto da parte delle singolarità divenute comune).
Del resto, ci sono, legate al concetto dell’imperialismo (ed ancor più a quello di colonialismo), delle produzioni di immaginario che si collegano ad una specie di darwinismo economico o politico costruito e nutrito dallo Stato-nazione. L’idea avanzata da Bush dination building costituisce (dopo l’apogeo nazista della costellazione nazionalista) l’ultimo esempio di questa concezione. Che il ricorso ad elementi di identità locale – e talvolta fino a sindromi nazionaliste – permetta di resistere ai progetti dell’imperialismo non autorizza ad assimilare tale resistenza ai vecchi modelli di lotta anticoloniale ed antimperialista. Di fatto, nella struttura attuale biopolitica della resistenza, è l’idea stessa di modernità (oltre a quella di Stato-nazione) che viene messa in discussione. Che “un altro mondo sia possibile”, significa che le dimensioni nazionali ed imperialiste del progetto di dominazione sono in crisi. Il progetto moderno, come dispositivo di dominio e di razionalità strumentale del capitalismo nello spazio-nazione, residua piuttosto uno spazio al sabotaggio della modernità e per un disegno di costruzione globale del comune (dopo, oltre il moderno).
3.
Da questa fragilità della struttura capitalistica del potere, dall’inseparabilità delle dimensioni superficiali e strutturali, economiche e politiche dello Stato-nazione (e della conseguente categoria dell’imperialismo) deriva la crisi più importante e più determinante per la definizione dello Stato-nazione e dell’imperialismo: la crisi della sovranità. Come abbiamo visto, la teoria della sovranità rinvia ad un principio logico che vede l’anima dellasovranità nella riduzione all’unità e la sua costruzione adeguata nella costruzione dell’idea di un popolo. Non sarà difficile riconoscere che, in questo quadro, la sovranità non poteva presentarsi altrimenti che come un elemento mistico, irrazionale, frutto di una logica di decisione autoritaria: lo è nella storia del pensiero politico occidentale fin dall’inizio. Questa influenza è estremamente profonda. Nella stessa opera di Marx, il concetto di sovranità, benché sia ricollocato all’interno dell’analisi dei modi di produzione, non riesce tuttavia ad essere analizzato secondo quella nuova logica: anche in Marx (ed in generale in tutte le teoria che considerano la sovranità in termini di monopolio del potere, in termini di dittatura) c’è una sottovalutazione dell’operazione metafisica di riduzione all’uno della moltitudine e/o dell’universo globale delle singolarità. Ora, quello che appare evidente a questo punto della nostra esposizione, è che questa reductio ad unum della sovranità non è più possibile. Quando il biopotere sussume il mondo globale come sua categoria, o come prodotto di immaginazione trascendentale; quando esso penetra il globo con dispositivi più o meno immanenti ed ordinativi, allora contraddizione e crisi si aprono sull’interno tessuto biopolitico. Attraverso le politiche di controllo della crisi, fossero esse anche solo budgetarie o welfariste, la sussunzione della società nel capitale è data, ma nello stesso tempo vi si trovano– dentro questa sussunzione – la presenza e la trasformazione adeguate del rifiuto e della resistenza.
Non è dunque un caso se la guerra oggi non è più la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra oggi, nel postmoderno, è divenuta la base stessa della politica e di ogni governance possibile. Questa centralità della guerra dipende tanto dalla crisi della legge di valore (dunque dalla dismisura dello sfruttamento) quanto dalla nuova capacità che possiede la forza lavoro di produrre valore, in una maniera che eccede il sapere strumentale e il controllo politico capitalista. Il concetto di sovranità (come fissazione e ipostasi dell’uno) non arriva più a racchiudere nella sua sfera di controllo le dinamiche moltitudinarie della produzione. L’eccedenza del lavoro, ovvero la produzione di sé che il lavoro vivo ha già cominciato ad affermare in forme moltitudinarie (solo modo, d’altra parte, di creazione di ricchezza), riqualificando il concetto di crisi (introducendolo all’interno della relazione biopolitica), aprono immediatamente il problema (cioè ad una nuova definizione) del concetto di sovranità. La sovranità non è più capace di presentarsi come uno. Meglio: solo la guerra può imporre distruttivamente il dispositivo unitario. Già nelle teorie politiche degli epigoni della modernità (Schmitt, Benjamin, Derrida, Agamben) la guerra funziona come ultimo dispositivo unitario della sovranità e dunque come essenziale fondamento del potere politico (e, nella prospettiva biopolitica, della legalità stessa). L’eccezione è divenuta la regola.
Oltre alla crisi dell’idea di sovranità nello Stato-nazione, alla crisi per cosi dire esterna alla sua struttura – vale a dire riferita all’impossibilità di fissare in maniera unilaterale il valore degli scambi e quindi la moneta, la misura della forza e dunque il dispositivo imperialista, la forma della comunicazione e dunque l’autonomia ideologica –, si assiste oggi ad una crisi assolutamente nuova, interna e consustanziale allo Stato-nazione: una crisi di legittimazione che può essere solo risolta da una sovradeterminazione bellica. La sovranità si presenta come una vittoria distruttrice. Ma quando sia così, è l’idea stessa della sovranità che scompare, meglio, essa si presenta come una dualità sempre irrisolta, come una tensione sempre esplosiva. Virtualmente, l’uno si è diviso in due.
Sarà utile, a questo punto, riprendere il discorso dal punto di vista dell’analisi di classe, vale a dire a partire dai temi dell’organizzazione, del programma, e dunque dal progetto di rivoluzione. Non è qui il luogo per introdurre questi temi. Sia sufficiente insistere sul fatto che l’imperialismo (in qualsiasi forma si presenti, quale espressione ed estensione del potere dello Stato-nazione) non solo non resiste come concetto quando sia confrontato all’insieme dei rapporti politici e geopolitici, non solamente non si sostiene nel confronto con le nuove regole che il sistema di biopotere propone sull’orizzonte imperiale, ma va in crisi nelle sue stesse fondamenta. Quando esso assume la guerra come sola forza (e solo concetto) che condiziona e sovradetermina l’insieme dei rapporti di cittadinanza, l’Impero non rappresenta semplicemente un nuovo ordine esteso quanto il mercato mondiale – rappresenta una forza distruttrice, destituente i rapporti interni allo Stato-nazione. L’alternativa tra imperialismi e Impero non è cosa che concerne solo questioni relative al mercato globale: essa concerne soprattutto, e prima di tutto, i rapporti interni agli Stati-nazione, e dunque le regole stesse della cittadinanza.
Oggi noi viviamo certo un interregno, fra la fine della modernità e l’apertura della postmodernità, fra l’estinzione dello Stato-nazione e la fondazione dell’Impero. Mille contraddizioni attraversano questo periodo e nessuno può opporre Stato-nazione e Impero come se si trattasse di figure opposte per natura. Nell’interregno, il capitale gioca piuttosto la compenetrazione di queste due figure e talora si illude sull’evoluzione dell’una nell’altra: la dialettica per il capitale funziona sempre, e così all’affermazione dello Stato-nazione segue la negazione dell’interregno, poi la sua necessaria sublimazione nell’Impero. Ma la dialettica è una cosa che riguarda solo il capitale. Noi dobbiamo di contro giocare la tendenza materiale della lotta di classe, quella che organizza nell’egemonia del lavoro vivo, nell’interregno, nel tempo che resta, le condizioni per lo scontro a livello di Impero. È qui che il concetto di moltitudine diviene la matrice fondamentale di nuove figure della lotta di classe.