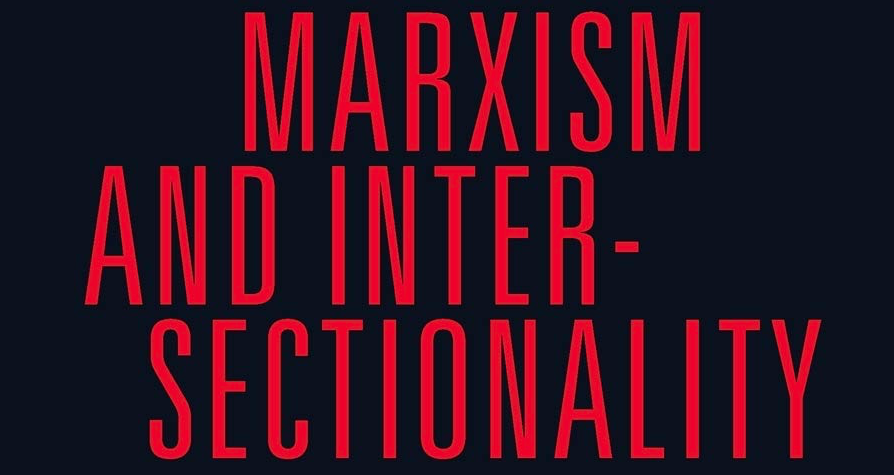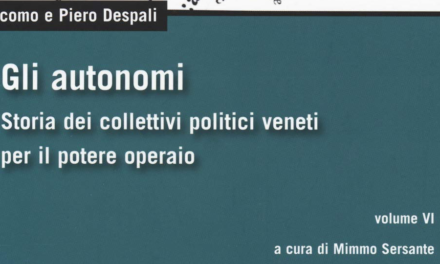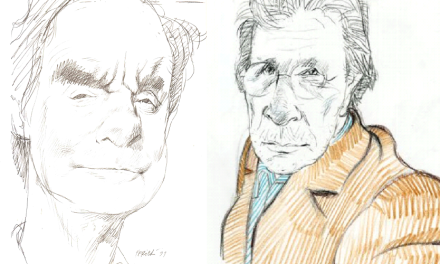Di SANDRO MEZZADRA
“Intersezionalità” è un termine che da qualche tempo circola anche nel dibattito critico italiano, in buona misura per via dell’azione del movimento transfemminista “Non Una Di Meno”. Anche in America Latina, in Paesi come l’Argentina e il Brasile, i movimenti femministi degli ultimi anni hanno creativamente ridefinito il significato dell’intersezionalità, appropriandosene per nominare la molteplicità di posizioni che caratterizzano l’esperienza dell’oppressione e dello sfruttamento (su basi di orientamento sessuale e “razza”, classe e “cultura”) e al tempo stesso per alludere a un piano di convergenza tra queste diverse posizioni. In questione è qui quella che Angela Davis (La libertà è una lotta costante, Ponte alle Grazie, 2018)chiama “non tanto una intersezionalità delle identità quanto una intersezionalità delle lotte” – una formula che ben si presta del resto a indicare la peculiarità degli stessi formidabili movimenti per le “vite nere” degli ultimi mesi negli Stati Uniti.
Si assiste dunque oggi in diverse parti del mondo a quella che potremmo definire una ripoliticizzazione del concetto di intersezionalità. Introdotto nel 1989 da Kimberlé Crenshaw per definire, nella prospettiva di uno studio critico del diritto, “i diversi modi in cui la razza e il genere interagiscono per determinare le molteplici esperienze delle donne nere sul terreno del lavoro”, il concetto di intersezionalità si è poi ampiamente affermato all’interno dell’accademia statunitense. E si è spesso (non sempre, sia chiaro) legato a doppio filo alla “politica dell’identità”, contribuendo a incentivare una frammentazione della critica dell’“oppressione” quando non una competizione tra le diverse identità oppresse. Ne è derivata una sostanziale difficoltà nell’immaginare processi di comunicazione e convergenza tra movimenti, lotte e rivendicazioni, che ha dato appunto luogo in molti casi a una spoliticizzazione del concetto di intersezionalità.
Nel nuovo quadro che oggi si presenta (ribadisco: per via dell’azione dei movimenti transfemministi e dei movimenti per le “vite nere”), l’intersezionalità torna tuttavia al centro del dibattito politico. Un contributo importante per orientarsi all’interno di questo dibattito è offerto da un libro recente di Ashley J. Bohrer, Marxism and Intersectionality. Race, Gender, and Sexuality Under Contemporary Capitalism (Transcript, 2019, pp. 279, euro 20,99). Bohrer rilegge la “tradizione intersezionale” dal punto di vista delle critiche che le sono state rivolte dal marxismo, accogliendone alcune ma soprattutto proponendo una lettura in chiave intersezionale di essenziali categorie marxiane. Più in generale, il libro è sostenuto da una forte tensione politica, che conduce l’autrice a riformulare in modo molto interessante nell’ultimo capitolo i principi di fondo di una politica della solidarietà e della coalizione.
Bohrer si oppone a stilizzazioni spesso caricaturali tanto del marxismo quanto dell’intersezionalità, per fare emergere una pluralità di posizioni tra cui è possibile e necessario instaurare un dialogo. Mostra poi in particolare come la genealogia dell’intersezionalità si intrecci con la lunga storia del femminismo nero e in particolare con il dibattito che si svolse all’interno del Partito comunista statunitense negli anni Trenta e Quaranta a proposito della specificità della condizione della donna nera: è in questo dibattito che furono originariamente introdotti concetti quali “triplo sfruttamento” (Louise Thompson) e “supersfruttamento” (Claudia Jones). Questi concetti continuarono a circolare all’interno del femminismo radicale statunitense, e furono riformulati da organizzazioni come la “Third World’s Women Alliance” e il “Combahee River Collective”, che negli anni Sessanta e Settanta posero le basi per l’emergere del concetto di intersezionalità.
La preistoria dell’intersezionalità è dunque caratterizzata da un’impronta militante e da un profondo intreccio tra femminismo nero e marxismo. Altri femminismi (quello chicano, ad esempio) sarebbero successivamente intervenuti ad arricchire il quadro. Già nelle formulazioni che si sono richiamate, in ogni caso, emergevano problemi che sarebbero rimasti al centro della discussione sull’intersezionalità. Si prenda ad esempio la nozione di “triplo sfruttamento” – ovvero l’idea che le donne nere siano sfruttate come lavoratrici, come donne e come nere: qual è il rapporto tra questi diversi regimi di sfruttamento? E ancora: possiamo parlare di sfruttamento a proposito di sessismo e razzismo, o dovremmo introdurre un altro termine, “oppressione”? Possiamo infine assumere le donne nere della classe operaia come un soggetto omogeneo o dovremmo piuttosto considerare le differenze al loro interno? Le domande si potrebbero moltiplicare.
Uno dei meriti del libro di Bohrer consiste nel fatto che offre un’analisi molto ricca, e sempre politicamente orientata, dei dibattiti che a partire da queste e altre domande si sono sviluppati all’interno della tradizione intersezionale, dando luogo ad esempio a una categoria come “matrice di dominazione” (Patricia Hill Collins). Fondamentale è per lei in ogni caso il fatto che l’intersezionalità “sottolinea l’inseparabilità delle diverse forme di oppressione, criticando ogni approccio che assuma la prospettiva di un pensiero del ‘singolo asse’”. Si tratta dunque di fondare teoricamente questa inseparabilità, compito che Bohrer svolge – sulla base di un impegnato confronto critico con la tradizione marxista – ripensando il concetto di capitalismo a partire dalla dialettica di omogeneità e differenza che lo costituisce.
È un punto particolarmente originale del libro di Bohrer, che può tuttavia appoggiarsi ai lavori di quanti (ad esempio Lisa Lowe, David Roediger e Dipesh Chakrabarty) hanno indicato nella “produzione sociale della differenza” un tratto saliente del capitalismo moderno e contemporaneo. “Per poter funzionare”, scrive Bohrer, “il capitalismo deve sia produrre e riprodurre differenze (nel carattere del lavoro, nelle merci prodotte e nelle posizioni soggettive che assicurano lavoro e produzione) e deve continuamente produrre omogeneità” (nell’imposizione della norma del lavoro astratto, della forma merce e del denaro, in particolare). Si vede bene, credo, come questa lettura del capitalismo si collochi all’interno dei dibattiti sull’intersezionalità: quelle che Bohrer chiama le diverse “posizioni soggettive” non possono certo essere rimosse, devono anzi essere politicamente valorizzate; e tuttavia resta essenziale riconoscere che nel loro insieme queste differenze dipendono dalle operazioni di una struttura che deve essere criticata e affrontata anche dal punto di vista della sua continua produzione di omogeneità.
Sono così poste anche le condizioni per affrontare un tema fondamentale nel dialogo tra marxismo e intersezionalità: ovvero il rapporto, già richiamato, tra “sfruttamento” e “oppressione”. Per lungo tempo il concetto di sfruttamento è stato considerato univocamente economico (quando non economicistico), eventualmente in grado di applicarsi alla “classe”, ma certo non alla “razza” e al “genere”, per non parlare delle molteplici figure in cui questi due “assi” si sono scomposti negli ultimi decenni. Bohrer spiazza queste polarizzazioni, proponendo una lettura “non riduzionista” dello sfruttamento e insistendo sul fatto che sfruttamento e oppressione, senza mai coincidere, sono “co-originari”. L’oppressione (il razzismo, il sessismo) entra così a determinare lo stesso sfruttamento, mentre quest’ultimo apre prospettive inedite sulla materialità dell’oppressione.
A risultare arricchito e modificato è così lo stesso concetto di classe, su cui Bohrer scrive pagine molto belle, che entrano tra l’altro in risonanza con quanto ha scritto recentemente Michael Hardt a proposito di una “‘classe-moltitudine’, una classe intersezionale”. Nella prospettiva di Bohrer non si tratta certo di rinunciare a insistere sull’elemento dell’antagonismo fondamentale “tra capitalisti e proletari”, ma piuttosto di portare l’analisi sui diversi modi in cui l’esperienza della “proletarizzazione” è vissuta, dando conto anche del fatto che “spesso questi diversi modi assegnano a determinati settori del proletariato un potere e dei privilegi su altri settori”. Ripensata dal punto di vista della differenza, la classe si presenta così come un terreno di comunanza e al tempo stesso di conflitto: se la sua unità non può essere assunta come data, si tratta di lavorare affinché possa essere politicamente costruita, secondo un processo che fa necessariamente della lotta contro il razzismo e il sessismo momenti costitutivi e non subordinati di una politica di classe.
“È all’interno delle nostre differenze”, ha scritto Audre Lorde, “che siamo al tempo stesso più potenti e più vulnerabili, e uno dei compiti più difficili nelle nostre vite consiste nel rivendicare le differenze e nell’imparare a usarle come ponti piuttosto che come barriere tra noi”. Gli scritti di Lorde figurano tra le principali fonti di ispirazione per il ripensamento dei principi della solidarietà e della coalizione su cui, come si è detto, si conclude il libro di Bohrer. Se è qui netta la critica della “dittatura del frammento” (ovvero di una politica dell’identità chiusa in se stessa, a protezione dei confini che la distinguono da altre identità), risulta particolarmente interessante la presa di distanza da un astratto universalismo, che configura la solidarietà come una sorta di “equivalente universale”, a partire dall’idea di una sostanziale “commensurabilità” tra le diverse forme di sfruttamento e oppressione. È piuttosto focalizzandosi sulle relazioni tra queste diverse forme che una solidarietà materialmente in grado di valorizzare le differenze e di aprire spazi di convergenza diviene possibile. “Coalizione” è per Bohrer il nome di questa convergenza, che assume caratteri creativi – ben al di là di una mobilitazione che si organizzi semplicemente attorno al “minimo comune denominatore” tra diversi movimenti. In questione è infatti la costruzione, sempre aperta ma per questo potente, di quella unità di cui parlavo a proposito della politica di classe.
A me pare che questo modo di intendere la solidarietà e la coalizione sia di grande interesse dal punto di vista teorico e che consenta al tempo stesso di cogliere alcuni tratti salienti dell’azione di molti movimenti contemporanei – a partire da quelli femministi e per le “vite nere” che citavo all’inizio. Il libro di Ashley Bohrer giunge a questo esito a partire dalla ricognizione di un insieme di dibattiti (quelli sulle diverse varianti dell’intersezionalità, in particolare) all’interno dei quali agisce con forza una lunga storia di lotte per la liberazione – di donne nere e chicane, di dissidenze sessuali, queer, antirazziste. Costruito fondamentalmente attorno a esperienze teoriche e politiche statunitensi, si offre tuttavia naturalmente a esercizi di traduzione politica in altri contesti, tanto più a fronte della diffusa ripresa e appropriazione del linguaggio dell’intersezionalità a cui stiamo oggi assistendo.