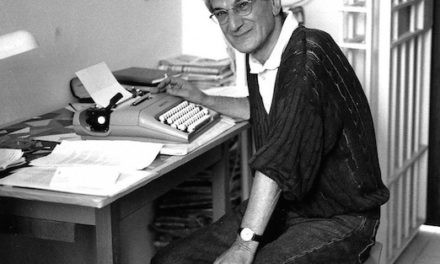di FEDERICO RAHOLA.1
Dopo essersi smarrita tra le pieghe dei testi, nei transfert e contro-transfert di esercizi esegetici, riflessivi o dialogici, l’antropologia sembra aver ritrovato un terreno (del resto mai disertato) e riscoperto la forza carsica del pensée d’autrui: quella “potência de alteridade”, come la definisce Eduardo Viveiros de Castro, che da sempre costituisce il movente di questo “sapere (anti)coloniale” rendendolo un territorio conteso, di incerta sovranità, attraversato da un’onnivora volontà di sapere pronta a rovesciarsi nel suo opposto e farsi possedere dai soggetti che studia.
Per questo, una buona definizione dell’antropologia è anche “uma boa definição da antropofagia”, da cui scaturisce qualcosa di radicalmente altro rispetto al discorso onnicomprensivo e normalizzante che l’Occidente continua a pronunciare: qualcosa che ci restituisce un’immagine degli altri e di noi che non conosciamo e non riconosciamo, imponendo una presa di distanza. Accanto alla riscoperta di altri luoghi, materiali o simbolici, della fisicità violenta di contatti, rituali e corpi con le loro tecniche, le loro simbologie e le loro secrezioni, ritorna poi anche quella di “mitologie” e opposizioni strutturali che interpellano direttamente un nume tutelare, l’autore che, spingendosi fino a un punto lontanissimo, sembra aver fatto seppuku della disciplina. Claude Lèvi-Strauss è morto da poco più di due anni, dopo aver superato il secolo, ma la sua esistenza, come del resto il suo lavoro, pareva idiosincratica al tempo. Da Tristi tropici alle Strutture elementari fino ai tre volumi delle Mythologiques, passando per quel frammento assoluto delle scienze sociali del Novecento che è l’introduzione all’opera di Marcel Mauss, l’uomo che ha aperto e chiuso la lunga estate dello strutturalismo incombe ancora sul presente, come punto di massima visibilità e vicolo cieco dell’antropologia culturale, presenza inassimilabile e anacronisticamente attuale. Ai classici, d’altronde, è riservato il destino ingombrante di congiurare contro i tempi, motivo per cui aspettiamo ancora qualcuno che sappia scrivere di lui come lui è riuscito a scrivere di tutto parlando di Mauss. A partire da quest’eredità che sembra provenire da un futuro remoto, diverse voci hanno delineato un percorso simile a un ritorno sul luogo del delitto. Penso a Michael Taussig con i suoi lavori à la Conrad su feticismo delle merci e sciamanesimo in America latina, ai coniugi Comaroff che esplorano lo statuto ibrido e millenarista del capitale nel clima postcoloniale, e ovviamente a molti altri (da Philippe Descola, Roy Wagner, Stanley Tambiah fino ad Anna Tsing). Penso, appunto, a Viveiros de Castro, bizzarra sintesi di antropologo da museo (è direttore del Museo etnologico dell’Università federale di Rio de Janeiro) ed etnologo militante. Il suo nome è legato soprattutto a due parole, “prospettivismo” e “multinaturalismo”, scaturite da un lavoro decennale che riannoda i fili della tradizione modernista brasiliana del manifesto antropofagico di Oswald de Andrade a quelli della filosofia “continentale”, a scelta strutturalista o poststrutturalista, attraverso etnologie che puntano l’indice su una tonalità specifica della linea del colore che taglia la democrazia multicolore: “o que é indio?” Questione aperta e centrale, che dalla dittatura arriva dritta alla transizione democratica e alla costituente del 1988, per restare ancora drammaticamente aperta nel post-lulismo, tra leggi ascrittive, deforestazioni ed espropri di terre. Questione che per Viveiros va rovesciata come un guanto: “Todo mundo é ìndio exceto quem nao é”, a indicare deleuzianamente un certo modo di divenire indio, “qualcosa di essenzialmente invisibile”: non una differenza, ma un movimento incessante di differenziazione. Nel suo ultimo lavoro, pubblicato in Francia prima che in Brasile (Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, PUF 2010), Viveiros riprende il filo del viaggio nelle mythologiques indigene e ne riassume i principali approdi, conferendogli il carattere di un manifesto. L’intenzione è di radicalizzare un gesto restitutivo, di dare agli indio quel che è degli indio, permettendo così che l’antropologia diventi “una teoria e una pratica di decolonizzazione permanente del pensiero”.
Non senza spocchia, Metafisiche cannibali è costruito come un libro su un’opera fantasma, sull’intenzione di un libro. L’idea, ci viene detto, era in origine quella di un omaggio a Deleuze, il cui titolo avrebbe dovuto essere “L’Anti-Narciso: sull’antropologia come scienza minore”, opera che però si rivela borghesianamente invisibile, diventando il movente per un altro libro che la racconti e ne parli come fosse “già scritta da altri”. La domanda che aleggia tra le pagine riguarda il debito concettuale dell’antropologia nei confronti dei popoli che ha studiato, debito che viene paradossalmente offuscato dal senso di colpa inestirpabile per l’assoluta sovrapposizione con ciò che Georges Balandier definisce la “situazione coloniale”, dando vita a uno complicato percorso interiore, quasi un’eterogenesi. La storia più o meno la conosciamo: nata dal colonialismo, con il suo retaggio esotista e primitivista, l’antropologia non può che essere il teatro perverso in cui l’“altro” è sempre rappresentato e inventato, motivo per cui i libri degli antropologi ci informano soprattutto di loro e delle loro società. Al rifiuto dell’oggettività, all’abdicazione a pretese di “verità” tassonomiche e assiologiche sulle società e i popoli descritti, si è infatti accompagnato il ripiegamento nei testi, divenuti principale fonte e oggetto di analisi. Il fatto è che questo gesto all’apparenza riparatorio o restitutivo, che ricolloca l’oggetto del sapere antropologico nella mente e nel ventre delle società occidentali, si rivela anche un inganno, l’ennesima trappola per silenziare doppiamente i nativi, riaffermando un “paternalismo compiacente” che normalizza ogni differenza e rafforza il centro della scena. “A forza di vedere il medesimo nell’altro, non abbiamo fatto altro che scrivere un’infinita storia su di noi”: così opera Narciso, ulteriormente potenziato dal fatto che la de-esoticizzazione dell’indigeno ha permesso di esotizzare l’antropologia e gli antropologi, proiettandoli in uno spazio-tempo altro, un finto ieri che, senza scomodare Proust, appare molto più affascinante del presente bonificato dei soggetti che studia. Ma davvero è così? Davvero si può dire che l’antropologia e più in generale il colonialismo siano una storia solo occidentale?
Una delle conseguenze inattese ma implicite della vicenda coloniale, uno dei suoi esiti nemmeno troppo latenti, quello per cui il prefisso post- si arricchisce dei significati forse più corrosivi, consiste proprio nel fatto che da quell’incontro violentissimo anche l’Occidente è stato per certi versi “colonizzato”, fino al punto di recuperare un’immagine di sé che non riconosce più (Conrad docet). Per la stessa ragione, contro l’assunto riflessivo che attraversa la svolta testuale disseminata nella maggior parte dei lavori tardo o post-antropologici, l’idea cioè che dai giri per il mondo a raccogliere informazioni (per lo più funzionali alla dominazione) e interpretare altre forme di vita restino solo pagine in cui recuperare una storia di sé, specchi in cui l’Occidente si riflette, si staglia la “potenza dell’alterità” che anima fino a divorare antropofagicamente i racconti degli antropologi. In realtà, l’antropologia/antropofagia coltiva dentro di sé una assoluta esteriorità e per questo, secondo Viveiros, deve restare lèvi-straussianamente un’arte delle distanze. Da qui l’invito a una radicale inversione prospettica, perchè la “verità” del pensiero antropologico risiede nel fatto che i concetti, i problemi e gli elementi più interessanti in esso contenuti nascono “dal potere immaginativo delle società, dei popoli, dei collettivi che si è voluto studiare”: sono al più delle “versioni” di teorie e conoscenze indigene.
È un fatto di prospettiva, quindi, e proprio su uno di questi concetti indigeni, quello yudjà di “punto di vista”, si costruisce una concezione prospettica e molteplice, del resto condivisa da quasi tutte le popolazioni del nuovo mondo e rilevata da molti etnologi, per cui ogni essere costituisce un centro di intenzionalità, che “apprende” gli altri esseri in base alle loro caratteristiche specifiche. Su queste basi prende corpo l’idea di un prospettivismo irriducibile alle epistemologie occidentali, che taglia ortogonalmente la contrapposizione tra relativismo e universalismo come pure quella paradigmatica, vero caposaldo della metafisica occidentale e al primo capitolo della costituzione della disciplina, tra Natura e Cultura. Per descrivere questa sovversione Viveiros ricorre a un’osservazione di Lèvi-Strauss in Razza e storia: “Nelle grandi Antille, qualche anno dopo la scoperta dell’America, mentre gli spagnoli inviavano commissioni di inchiesta per verificare se gli indigeni avessero o meno un’anima, questi ultimi immergevano nell’acqua i prigionieri bianchi per verificare, attraverso un controllo prolungato, se i loro cadaveri fossero o meno soggetti a putrefazione”. Nello scontro tra due etnocentrismi si disegna un chiasmo antropologico: dove gli occidentali dubitano del fatto che gli indigeni siano dotati di un’anima, gli indigeni invece, dando prova di un atteggiamento per certi versi più speculativo e scientifico, non dubitano dell’anima ma del corpo degli occidentali. A parità di ignoranza, conclude Lèvi-Strauss, il modo di procedere dei secondi si rivela indubbiamente più elegante. La vicenda, però, può essere l’indizio di un messaggio più generale: per esempio, del fatto che l’“altro dell’altro” non è esattamente lo stesso dell’“altro del medesimo/occidentale”; e quindi che il particolare prospettivismo dei nativi dubiti che altre anime o spiriti (di cui sono certi essere in possesso, malgré tout, gli occidentali) possano essere provvisti materialmente di un corpo simile al loro. Si tratta di un’idea diffusa, che si riflette nel lavoro etnologico e pervade tutte le concezioni oggettivate unilateralmente come “animiste”: l’anima/cultura è universale e il corpo/natura è particolare. Origina da qui la prospettiva multinaturalista di Viveiros de Castro, per designare un tratto distintivo del pensiero amerindiano rispetto alle moderne cosmologie “multiculturaliste”: se queste si fondano sull’implicazione reciproca tra unicità della natura e molteplicità delle culture (oggettività del corpo e della sostanza versus particolarità soggettiva dello spirito e del significato), il primo invece suppone un’unità dello spirito nella differenza dei corpi, dove “la ‘cultura’ e il soggetto sono forme dell’universale e la ‘natura’ e l’oggetto del particolare.”
La domanda allora è: come rapportarsi a questo pensamento prospettivo e multinaturale, oltre a prenderlo sul serio? Senza cioè volerlo spiegare, interpretare, contestualizzare e comparare, e cercando invece solo di pensarlo. Cosa significa “pensare il pensiero indigeno”? In primo luogo non neutralizzarlo, mettendo tra parentesi la questione di sapere se esprima degli universali o invece una visione particolare; e quindi non “credergli”, tanto come atto di fede quanto per il valore di verità di ciò che non è né un’opinione né di un insieme di proposizioni veritiere, né fonte di verità né necessariamente dotato di un fondo di verità. La risposta, un impossibile incontro tra Deleuze e Lèvi-Strauss, è forse proprio nell’atto di “prendere sul serio” il pensée d’autrui, come espressione di un possibile che deve essere sempre attualizzato per moltiplicare il mondo in una continua logica di trasformazione: l’altro degli altri è sempre un altro, ci ricorda Lèvi-Strauss, ed è sempre altro, aggiunge Deleuze. Su questi presupposti, l’antropologia può decolonizzare il pensiero e aspirare a uno statuto universalmente prospettico, a patto di mettere in crisi i propri assunti universalistici e di riconoscere di essere parlata da ciò di cui parla e pensata da ciò di cui pensa. L’atto antropofagico, come noto, è sintomo di una doppia possessione: chi mangia è anche mangiato, chi si impossessa è anche posseduto. Nella transizione di un’anima condivisa tra corpi distinti, che poco ha a che fare con la transazione, lo scambio e il valore di scambio, tutto si gioca sul dono e sul furto, su un altro scambio inteso come circolarità del dono e del furto. È questo, in fondo, il senso dell’antropofagia, come pure dell’antropologia.
Pubblicato su “il manifesto”, 4 febbraio 2012. ↩