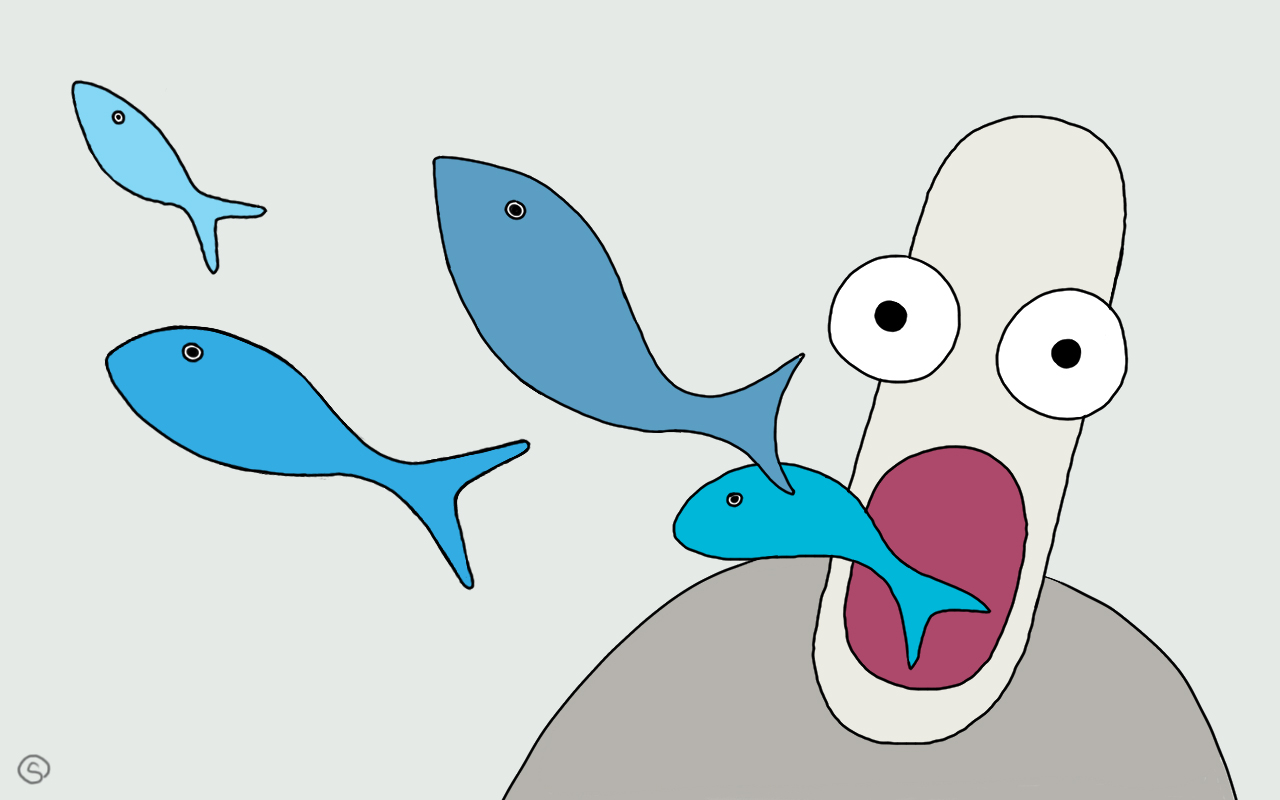di GIROLAMO DE MICHELE.
Il sintagma nominale “taxi del mare” è stato coniato, a quel che sembra, da Luigi Di Maio il 21 aprile 2017, in una glossa – “Chi paga questi taxi del Mediterraneo?” [⇒ qui] – a uno status di Beppe Grillo su “L’oscuro ruolo delle Ong private”. Di fatto, è la firma a un patto non ancora scritto con la Lega di Salvini: verranno, un anno dopo, accordi, patti e governo.
“Taxi del mare” ha la stessa potenza persuasiva e retorica del suo antecedente nazista “Blut und Boden” (sangue e suolo): due parole che, affiancate, si contestualizzano a vicenda. Il contesto del mare determina il significato di taxi come un mezzo di trasporto che si estende fantasiosamente non fra due capi di una città, ma fra due coste del Mediterraneo; e il contesto taxi del determina il significato di mare come luogo attraversabile con relativa facilità, purché si disponga di adeguato denaro per il trasbordo. Da questo sintagma è partito Roberto Saviano, che intitola In mare non esistono taxi (Contrasto, 2019, pp. 176) un oggetto narrativo composto da una raccolta di fotografie (di Bacigalupo, Calvo, Meloni, Pellegrin, Penso, Piscitelli, Saman, Sestini, Spottorno), cui si aggiungono brevi testi giornalistici, e cinque conversazioni con cinque fotoreporter. Tre diverse tipologie testuali, che invece di integrarsi complicano la narrazione, lasciando aperture di senso e problematizzazioni, pur senza trascurare un taglio informativo di base utile per chi arriverà a questo libro attratto dalla qualità, altissima, delle immagini, piuttosto che da una preliminare conoscenza di quel groviglio di questioni che si aggruma nel termine “migrazione”. Dalle parole dei fotoreporter emerge infatti un tratto comune: l’oggetto delle foto non si esaurisce con l’esaurirsi del lavoro del suo autore. Ed è un bene che sia così: come afferma Giulio Piscitelli, una sola foto non può sintetizzare le molte articolazioni della questione migratoria – e sarebbe anzi rischioso se lo facesse, «perché più la sintetizzi, meno la capisci». D’altro canto, c’è fra i reporter intervistati la comune consapevolezza che oggi una foto, persino quelle più note (il piccolo Alan Kurdi annegato) non può avere lo stesso impatto performativo sull’opinione pubblica delle foto della guerra del Vietnam (la piccola Kim Phúc nuda e ustionata in fuga dal bombardamento al Napalm di Trang Bang). Con franchezza, Piscitelli riconosce che «siamo sotto posti a un continuo flusso di immagini e questo ci porta a essere toccati per un periodo troppo limitato del tempo. E il breve momento di shock che viviamo guardando queste fotografie non ci spinge a ragionare sulle cause profonde di ciò che vediamo»: di conseguenza, la fotografia oggi non ha «quella capacità, che prima aveva, di spingere le persone a muoversi, a partecipare, a farsi promotrici di un cambiamento, di un’azione».
Una spiegazione tecnica corretta, ma non sufficiente: perché oltre la modalità di fruizione dell’immagine, va riconosciuta l’esistenza di un contesto in via di radicale polarizzazione, nel quale alla capacità di resistenza e reazione al potere corrispondono, in modo speculare, processi di costituzione identitaria che, ne siano consapevoli o meno, evidenziano un riemergere identitario del fascismo e del razzismo. Identitario significa che ci sono soggetti che non hanno alcuna remora a non celare, e anzi a rivendicare, tali soggettività. E quindi la lotta politica non può sperare di conseguire risultati attraverso il mero “smascheramento” – o, su un parallelo piano, del debunking; men che meno, può bastare la denuncia dell’intima relazione fra questi soggetti che si presentano (e talvolta si percepiscono) avversi al potere, e le maglie del potere nelle quali sono, prima ancora che irretiti, prodotti. Smascheramento, debunking, denuncia devono essere accompagnati e seguiti da una capacità di intervento sulle cause e i processi di costituzione identitaria che producono simili soggetti.
Qual è, allora, la funzione della fotografia oggi? Una prima risposta è nel riconoscere che se la verità è frutto di un processo di veridizione, in una società dove anche la più banale evidenza (l’allunaggio del 1969, la sfericità della Terra, il processo evolutivo del vivente) dev’essere costruita e argomentata in modo persuasivo, la fotografia è un importante tassello nella costruzione della verità: processo che è anche una costruzione dei soggetti che la verità affermano. Si prendano ad esempio le foto di Paolo Pellegrin: dove la scelta del bianco e nero permette di «far coincidere lo specifico con l’universale; togliendo un elemento del reale si permette alla foto di diventare metafora». Al tempo stesso, la fotografia, mentre mostra sul piano tecnico il processo che la differenzia dalla mera esposizione dell’evidenza, mantiene quel carattere che le riconosceva Barthes: è l’unica forma d’arte che può affermare l’esistenza del suo oggetto. A questa caratteristica va aggiunta la capacità di “farsi storia” di una foto nella modalità dello storytelling, che caratterizza le immagini di questa raccolta: una foto che (come nei dipinti di Roy Lichtenstein) lascia immaginare il “pre” e il “post” dello scatto, che si propone non come immagine unica, ma all’interno di una virtuale sequenza che sta allo spettatore (meglio sarebbe dire: al lettore) ricostruire. In questo, la fotografia preserva un elemento biografico, che è fondamentale nella narrazione delle migrazioni – come sottolineava Alessandro Leogrande, cui il libro è dedicato: senza raccontare il “prima” della storia si rischia di negare quella storia, e di ricostruire, deformandola, la biografia del migrante. O di avvolgerla in un vuoto, nel quale si insinuano le narrazioni negazioniste e/o razzistiche.
Elemento biografico centrale nel libro di Concetto Vecchio Cacciateli! Quando i migranti eravamo noi (Feltrinelli 2019, pp. 190), che parte dalla biografia di James Schwarzenbach, il politico svizzero fondatore del primo partito anti-stranieri d’Europa. Già autore di un’attenta ricostruzione dell’assassinio di Giorgiana Masi (dove “ciò che non può essere ancora detto” emergeva fra le pieghe di “ciò che si può dire”), Vecchio aggiunge alla foto dell’ur-xenofobo svizzero una serie di polaroid in bianco e nero – dai propri genitori a Gaspare Bono, rintracciato a partire da una sua lettera all’Unità – che gettano il lettore nelle atmosfere del Cammino della speranza di Germi: un neo-realismo inteso come ri-costruzione del reale attraverso l’assemblaggio dei suoi elementi di base. Dove alla fine la distanza temporale dei suoi “migranti italiani” narrati – così come quella spaziale dei soggetti delle foto dei “migranti non-italiani” – viene decostruita. Una decostruzione che lascia al centro l’umanità, intesa come insieme di possibilità e potenzialità, con cui la vita dei migranti ci interpella, a partire dalla pretesa al rispetto e alla dignità dell’altro che esprimono la narrazione, scritta o fotografica: è in questo senso, per dirla col fotografo Scianna, che «una bella foto non migliora il mondo, ma una brutta lo peggiora».
una versione più breve di questa recensione è stata pubblicata sul manifesto del 4 luglio 2019; la foto sotto il titolo è stata scattata da Paolo Pellegrin