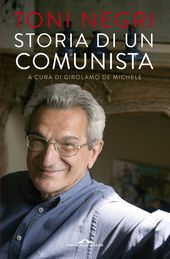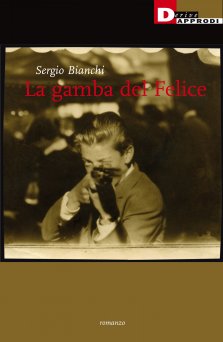di MIMMO SERSANTE.
Storia di un comunista: leggendo questa autobiografia di Toni Negri non sorprende il silenzio che ha accompagnato la sua uscita e la qualità delle poche recensioni apparse finora. Torna il refrain del cattivo maestro al quale non si perdona l’internità alle lotte operaie degli anni Sessanta e soprattutto a quelle degli anni Settanta ad opera delle bande autonome di “giovani perduti dietro un folle velleitarismo” [Simonetta Fiori, Repubblica 05-01-2016].
Sul senso di questa internità soprassiede tranquillamente anche Gad Lerner interessato ad attribuire la paternità di quelle bande per l’appunto al cattivo maestro (la “sua” creatura movimentista, quella in cui maggiormente si riconosce dal suo Blob 05-01-2016).
Se così stanno le cose, la censura ha ben altra motivazione che il mero imbarazzo che a suo tempo avrebbe provato il Pci a fronteggiare l’eresia del pensiero negriano. Quand’è che l’eresia non può essere contenuta? Evidentemente quando essa trova il suo inveramento in un’effettiva politica di liberazione. Se il ripiegamento sull’autonomia del politico ha salvato Tronti, il padre dell’operaismo, dalla demonizzazione picista, la fedeltà a quell’impianto teorico e la ricerca di una sua verifica pratica direttamente nella lotta di classe operaia hanno inchiodato Negri alla condizione di chi ha subito una messa al bando che si vuole perpetuo. E infatti nel linguaggio della gran parte di questi recensori Negri resta un bandito, anzi il bandito. Ma l’Autore avrebbe dovuto aspettarselo visto che la sua storia vuole essere quella di un comunista.
È di questa eresia comunista che vorrei parlare.
Personalmente scelgo le mie letture sulla base di taluni criteri personalissimi, in particolare sul fatto che leggendo devo sentire che quelle pagine sono state scritte per me e che per questo motivo mi desiderano. Sto rovesciando ovviamente una tesi di Barthes pensata per la scrittura, ma tant’è. Partirei allora dalla Terza Parte, da quei “dieci anni di ’68” che io ho vissuto in gioia e spensieratezza militando nel movimento studentesco e in Potere operaio prima, nell’Autonomia operaia dopo. Il passato si nasconde ma è presente, dice da qualche parte Malamud e ha ragione a condizione però che si sia vissuto quel passato in possessione felicitatis. Da dove altrimenti avremmo ripescato allora l’idea di comunismo? È questa banale verità che i nostri recensori non capiranno mai. Negri ha ricostruito quel passato, di Potere operaio e dell’Autonomia, con la puntigliosità dello storico indiziario avvalendosi di una memoria formidabile ma soprattutto della documentazione scritta prodotta dalle due organizzazioni. Nelle cronache delle lotte in fabbrica e sul territorio metropolitano di quel decennio cerca la conferma ora della estraneità dell’operaio massa al regime di fabbrica, ora dell’irriducibilità dell’operaio sociale al rapporto di capitale perché il dispositivo operaista va provato nelle lotte, sempre. Così il militante e il professore, dopo il lungo tirocinio sotto la guida esperta del Comitato operaio di Marghera durante gli anni sessanta, finiscono per confondersi proprio dopo il ’68. L’autobiografia esalta questa confusione di ruoli e questo è il motivo per cui tutti quelli che mal digeriscono una siffatta indistinzione, accusano l’Autore di aver dimenticato tutto il resto perché troppo preso a raccontare il suo assalto al cielo.
 Insomma Negri nel raccontarsi avrebbe dovuto quanto meno smorzare l’enfasi sulle lotte autonome e parlare delle fabbriche in rivolta come solo il sindacalista sa fare, svuotandole della presenza viva degli operai. L’autobiografia sarebbe quindi un ego-biografia che dimentica la Storia, ovviamente quella dei padroni e dei suoi scherani.
Insomma Negri nel raccontarsi avrebbe dovuto quanto meno smorzare l’enfasi sulle lotte autonome e parlare delle fabbriche in rivolta come solo il sindacalista sa fare, svuotandole della presenza viva degli operai. L’autobiografia sarebbe quindi un ego-biografia che dimentica la Storia, ovviamente quella dei padroni e dei suoi scherani.
Stando così le cose, non dobbiamo meravigliarci se la produzione teorica del professore segue il ritmo delle lotte del militante. Già l’apprendistato cattolico nella GIAC nei primissimi anni ’50 vuole essere un ritorno al cristianesimo vivente, a una pratica di verità in rotta di collisione con la gerarchia ecclesiastica collusa con i poteri forti e nemica dei poveri. L’eresia negriana nasce da qui, esattamente dall’impatto con la miseria dei contadini della Bassa veneta e dalle primissime inchieste nelle bidonville padovane: la verità si poteva testimoniare solo trasformandosi in un essere collettivo, umano, in un comune anch’esso in rivolta! Che “comune” sia nome di oggi e non di ieri torna utile a Negri per sottolineare una costante della sua eresia, vale a dire l’idea dell’essere come potenza: ieri contro una verità di fede, quella del Dio trascendente e nascosto all’uomo, oggi contro una verità di fatto che ci vuole tutti appaesati alla ragione neoliberista. Ma questa prima redazione dell’ontologia dal forte sapore dolciniano è solo la premessa a una seconda eresia diretta questa volta contro le verità proposte dall’altra chiesa presente in campo, anch’essa con pretese ecumeniche: il Pci. È il secondo Partito comunista per numero di iscritti in Europa, dopo quello sovietico. La cultura della sinistra più o meno comunista penetra in ogni ambiente: il PCI fa cultura, cinema, movimento, costruisce élite importanti che si muovono in ogni settore della società. Era difficile, se si era giovani e intelligenti, non stare col PCI.
Negri non entra nel Partito. Era abbastanza weberiano, ci ricorda, per farlo. Gli preferisce un partito più leggero e sicuramente più laico, il PSI, il meno peggio fra le forze politiche presenti sulla piazza. E poi cosa centrava il Lukács di Storia e coscienza di classe con Croce e i crociani convertiti all’ultima ora? Neppure Gramsci, diventato nel frattempo il padre della nuova Chiesa, viene preso in considerazione. A entrambi Negri aveva preferito lo storicismo tedesco estraneo al culto togliattiano della continuità. Ma come sempre accade per le eresie degne di questo nome, è la “scelta” di leggere il pensiero del padre fondatore in un determinato modo a fare la differenza. Negri legge il Capitale in modo trontiano, vale a dire politicamente orientato. E infatti il confronto è agli inizi degli anni Sessanta con la conricerca e le lotte dei chimici di Marghera. Lì dentro c’è tutto Marx versione trontiana, a partire da quel laboratorio della produzione squadernato reparto per reparto, linea per linea nel mentrela forza lavoro che si fa classe rivoluzionaria con la lotta. Al Pci di questa lettura risulta inaccettabile proprio questa produzione di soggettività che minaccia di sottrargli la “direzione politica” (concetto caro a Togliatti) della classe operaia nella lunga marcia verso il socialismo e di gettare un’ombra sui fondamenti della stessa linea politica ispirata fin dalla svolta di Salerno alla difesa dello status quo. Ma il problema non è solo di linea politica; se il gruppo dirigente del partito può perseguirla con ostentazione e senza vergogna, è perché le sue élite intellettuali lavorano alacremente per legittimarla. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta a mobilitarsi in prima persona sono i filosofi del partito, in particolare quelli di scuola storicista, convinti assertori non solo della storia come progresso ma del primato in esso delle classi lavoratrici purché a sostenerle sia un adeguato livello di coscienza mentre la concreta azione rivoluzionaria volta a negare dialetticamente il carattere privato del profitto – come si esprime con eleganza Badaloni – è consegnata per intero al Partito. È il motivo per cui non solo per questi filosofi il tema della produzione della soggettività, del farsi della classe operaia, non esiste come problema, ma quando esso è sollevato per la prima volta dalla scuola operaista, la levata di scudi è immediata e la reazione virulenta.
L’ipotesi che avanzo per darmi una ragione dell’accoglienza riservata a questa importante autobiografia di Negri è che la posta in gioco reale sia proprio la figura del filosofo Negri, più esattamente la sua proposta oggi di un’ontologia materialista. Essa è annunciata nell’autobiografia: «L’essere è potenza. L’essere si rappresenta come tensione – espansività assoluta e perciò, in quanto assoluta, creativa, aperta a una potenza che si confonde nel divino»: così comincia la prima redazione dell’ontologia del giovane Toni.
Ancora durante gli anni Settanta essa resta in fieri, allusa nel gioco a rimpiattino delle due composizione ma imposta alla riflessione dalla radicalità delle lotte promosse da un soggetto ancora difficile da decifrare. Saranno il carcere e la sconfitta dei movimenti, la controrivoluzione neoliberista, l’esilio e l’incontro con la filosofia francese a permettere la sua maturazione. Di questa ontologia che arriverà a maturazione negli anni Novanta sottolineo solo un aspetto a mio parere importante anche per capire l’isteria che la Storia di un comunista ha sollevato tra i suoi detrattori. Mi riferisco al rinnovato bisogno di verità di cui si fa portatrice quandola verità è fatta sparire dalle bugie del potere. In questa pretesa di verità ciò che fa scandalo è che Negri intende cercarla ancora nelle lotte e nelle rivolte degli sfruttati.
L’autobiografia di Negri ci racconta la sua storia e quella delle lotte dell’altro movimento operaio fino agli anni Settanta ma questa storia, mi piace citare J. Roth, è del resto così singolare che solo la vita stessa avrebbe potuto inventarla.