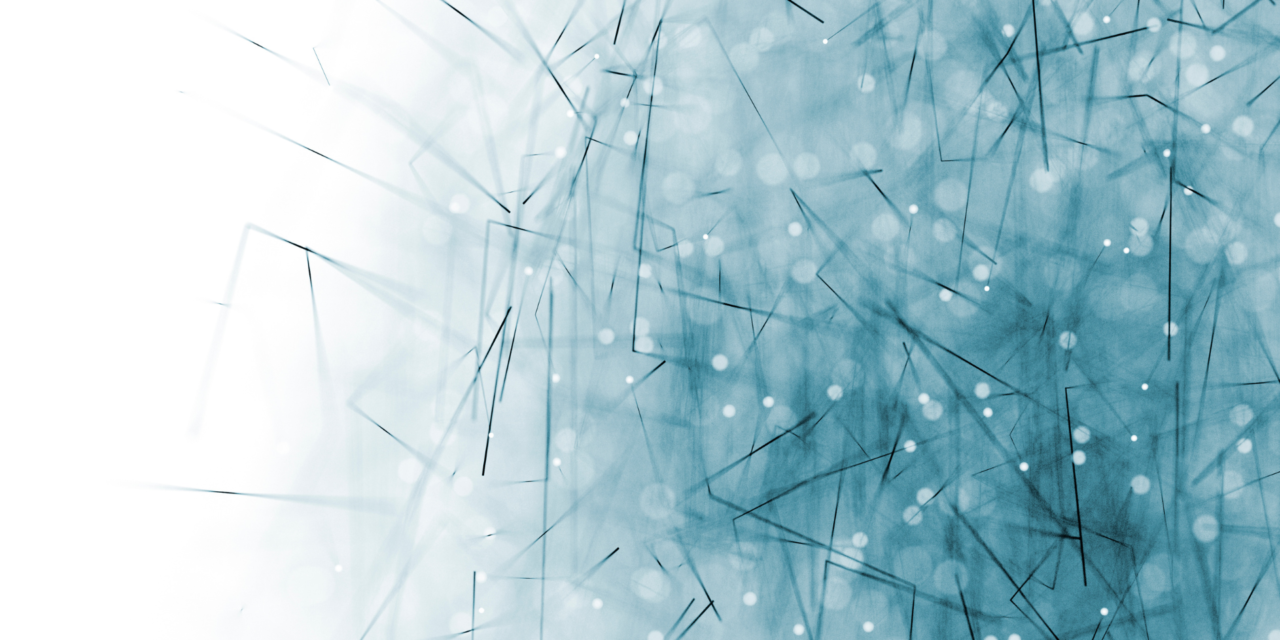Di DAVIDE GALLO LASSERE
Abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo capitalistico, poi le lotte operaie. È un errore. Occorre rovesciare il problema, cambiare il segno, ripartire dal principio: e il principio è la lotta di classe operaia.
(Mario Tronti)
Fin dal XIX secolo, l’internazionalismo è stato uno dei pilastri fondamentali dei movimenti rivoluzionari, siano essi antischiavisti, operai, anticoloniali o altro. L’internazionalismo, come estensione del campo di lotta al di là dello Stato-nazione, è una delle tre caratteristiche principali dei movimenti comunisti, insieme all’abolizione della proprietà privata e allo smantellamento della forma-Stato. Tuttavia, se si considera la vastità e l’importanza della storia dei movimenti inter- o transnazionali (a seconda che si snodino tra o oltre i confini nazionali), si rimane sorpresi dalla ricchezza del materiale empirico e storiografico rispetto a una certa povertà nella teorizzazione[1]. In effetti, si potrebbe sostenere che l’internazionalismo, come fenomeno storico e politico, sia fondamentalmente sotto-teorizzato. Fino a che punto, ci si può allora chiedere, è possibile sviluppare, se non una filosofia politica, almeno una teoria sociale e politica dell’internazionalismo? O, al contrario, possiamo andare oltre e immaginare che esistano un’ontologia e un’epistemologia specifiche dei movimenti inter e/o transnazionali? E poi, al di là dei vezzi nominali, quale o quali appellativi sono più adatti: inter-nazionalismo o trans-nazionalismo? Internazionalismo subnazionale o transnazionale (Van der Linden, 2010)? Locale o globale (Antentas, 2015)? Forte o debole (Antentas, 2022)? Materiale o simbolico? Rivoluzionario o burocratico? Comunista o liberale? Operaio? Femminista? Antirazzista? Ecologista? L’internazionalismo è un mezzo o un fine in sé? E naturalmente l’elenco potrebbe continuare[2]…
Tuttavia, ciò che è altamente significativo, oggi più che mai – in un momento di grande crisi economica e sociale, in cui tornano a soffiare i venti di guerra tra le potenze mondiali, in un mondo post-pandemico e surriscaldato – è il fatto che la questione strategica dell’internazionalismo stia tornando in primo piano all’interno dei movimenti sociali e politici: cresce la consapevolezza che non si possono sconfiggere queste forze ostili combattendo in ordine sparso, ognuno per sé, confinati nel perimetro dei nostri Stati nazionali, o rimanendo ancorati ai territori, mettendo in atto esclusivamente delle pratiche micro-politiche. È necessario poter intervenire allo stesso livello di tali processi, i quali sono per definizione globali e planetari. Per far ciò, dobbiamo dunque essere in grado di sviluppare ragionamenti e pratiche all’altezza delle sfide poste dalla geopolitica, dai meccanismi di governance, dal mercato globale, dal cambiamento climatico, ecc. Ma nella storia dei movimenti radicali e rivoluzionari, tali ragionamenti e pratiche vanno sotto il nome di internazionalismo e, in misura minore, cosmopolitica[3].
Ecco perché oggi sembra più importante che mai ripensare l’internazionalismo. La buona notizia è che non partiamo dal nulla. Infatti, gli anni 2010 sono stati costellati dall’esplosione di numerose rivolte e sommosse contro le conseguenze radicalmente antisociali e antidemocratiche delle varie crisi (economica, politica, sanitaria, climatica, ecc.). La cattiva notizia è che il decennio in corso e quelli a venire sono e saranno sempre più stravolti dall’inasprimento degli scontri geopolitici e dall’approfondimento delle tendenze alla catastrofe ecologica. I cicli di lotta futuri sorgeranno in un mondo sempre più sconvolto da contraddizioni e antagonismi evidenti. E saranno costretti a operare in questo mutato contesto. Quelle che seguono non sono quindi che nove semplici tesi, elaborate a partire da alcune esperienze francesi ed europee, con l’obiettivo di sottolineare quelli che potrebbero essere considerati i punti di forza e le carenze dei movimenti globali degli anni 2010. Esse vogliono essere allo stesso tempo un piccolo e parziale contributo al dibattito politico immanente a questi movimenti, ma anche un tentativo preliminare e non esaustivo di inquadrare in modo originale la questione dell’internazionalismo, in modo da rileggere in controluce i duecento anni di storia delle lotte inter- o transnazionali, dalle risonanze mondiali del 1789 al ciclo alter-globalista, passando per le date simboliche del 1848, 1917 e 1968[4].
Tesi 1. Ontologia I: Fabbrica terrestre
Le lotte sociali e politiche sono al centro della transizione all’Antropocene. In quanto motori dello sviluppo capitalistico, sono cruciali per comprendere i processi che definiscono le molteplici crisi ecologiche contemporanee. Detto altrimenti: l’esplosione delle emissioni di CO2 nell’aria e la progressiva distruzione della natura sono intimamente legate alle lotte di classe e anticoloniali; sono un “effetto collaterale” della risposta capitalista alle impasse indotte dalle pratiche di resistenza e controsoggettivazione dei subalterni. Il riscaldamento globale, ad esempio, è il risultato degli antagonismi tra gruppi umani e in quanto tale esso alimenta ancor più le tensioni sociali, economiche e politiche. Questa è l’idea di base di parte della storiografia eco-marxista, la sua diagnosi del presente e le sue prospettive di rottura futura. Il cambiamento di temperatura sulla Terra – determinato in primo luogo dall’uso capitalistico dei combustibili fossili – è un prodotto impuro dei conflitti sociopolitici passati e presenti. Sia che si assuma uno sguardo sincronico e globale, sia che ci si concentri sull’Inghilterra (pre)vittoriana, resta chiaro che la lotta di classe è fondamentale. Dalla metà del XIX secolo e in tutto il mondo, l’adozione dei combustibili fossili come fonte energetica primaria dell’accumulazione del capitale è stata infatti imposta con la forza in reazione al rifiuto del lavoro e all’appropriazione della terra da parte dei lavoratori e dei colonizzati; è la combattività degli sfruttati ad aver portato il capitale e i governi a introdurre prima il carbone e poi il petrolio e il gas. Come mostrano mirabilmente Andreas Malm (2016) e Timothy Mitchell (2013), il passaggio dal carbone al vapore intorno al 1830 e dal carbone al petrolio intorno al 1920 sono meglio compresi come progetti politici che rispondono a interessi di classe piuttosto che come necessità economiche proprie delle dure leggi del mercato.
Ciò che forse non viene sufficientemente sottolineato da questi studiosi è il fatto che le misure messe in atto dalle classi dominanti per domare il conflitto hanno comportato non solo cambiamenti socio-energetici, mutazioni tecno-organizzative e riconfigurazioni geo-spaziali, ma anche una più consistente socializzazione delle forze produttive e una crescente integrazione della natura nelle maglie del capitale. In questo modo, la Terra – e non solo la società – si è trasformata sempre più in una sorta di gigantesca fabbrica. Oggi, infatti, una quantità crescente di relazioni sociali e naturali è direttamente o indirettamente sottomessa al capitale. Dall’istruzione e dalla salute della forza lavoro alla miriade di esternalità positive fornite gratuitamente dall’ambiente, dalle piante e dagli animali, oggigiorno quasi nulla sfugge più alla logica del profitto. E il dominio della produzione sociale sulla riproduzione naturale sta alterando gli equilibri ecosistemici, al punto da mettere a rischio le condizioni stesse della sopravvivenza della specie. Di conseguenza, l’internazionalismo stesso richiede una revisione radicale. Se, infatti, la globalizzazione del commercio e della produzione ha costituito la base materiale dell’internazionalismo abolizionista e operaio, e se la dimensione mondiale dell’imperialismo ha rappresentato l’arena geopolitica dell’internazionalismo anticoloniale, gli effetti planetari delle crisi ecologiche configurano l’intera Terra come teatro dei nuovi scontri in corso. Questo cambio di paradigma, tuttavia, non implica semplicemente un allargamento di scala e una complessificazione del quadro di riferimento, ma comporta una vera e propria rivoluzione nelle nostre abitudini di pensiero e di azione.
Ecco perciò la prima tesi socio-ontologica attraverso la quale si può elaborare un internazionalismo adeguato alle sfide poste dall’Antropocene: all’interno della fabbrica terrestre – essa stessa frutto di precedenti cicli globali di lotte – non ci sono solo gruppi contrapposti di esseri umani che lottano l’uno contro l’altro, ma anche i non-umani e i non-viventi partecipano a pieno titolo alla tragedia storica in corso. Infatti, la distruzione di ecosistemi, ambienti, nature, ecc. in una parte del mondo produce sempre più spesso cicli di retroazione imprevedibili con effetti catastrofici in regioni completamente diverse. E gli ambienti e le entità sconvolte dall’impronta umana sono sempre meno dei semplici sfondi inerti; la loro irruzione violenta sulla scena politica, come nel caso della pandemia di Covid-19, spesso polarizza ancor più gli antagonismi, senza necessariamente aprire scenari rosei.
Tesi 2. Epistemologia: Composizione socio-ecologica
L’inclusione dell’altro-che-umano non solo nella scacchiera politica, ma come scacchiera politica ribalta le carte in tavolo, e non di poco. Tra le varie cose, uno sconvolgimento di portata così generale è di grande importanza per l’annosa questione della classe, della sua composizione e organizzazione. Secondo una “corrente calda” del marxismo che va dagli scritti storico-politici di Marx all’operaismo italiano, non esiste classe senza lotta di classe. Questo assunto attribuisce un primato ontologico alla soggettivazione politica rispetto alle determinazioni socioeconomiche. Mario Tronti (2013) ha raccontato questa epopea antagonista, i cui protagonisti – operai e capitale – incarnano i caratteri mitici di una filosofia della storia culminante nella società senza classi. Se la fiducia in un futuro radioso non appare più appropriata, tale approccio relazionale, dinamico e conflittuale alla realtà di classe è oggi ancora valido. Contrari a qualsiasi visione sociologizzante e/o economicistica, gli operaisti non si sono mai accontentati di mere descrizioni empiriche volte a sviscerare la collocazione oggettiva dei soggetti all’interno delle strutture sociali. Per loro, il passaggio dal proletariato alla classe operaia non è avvenuto automaticamente sulla base di una semplice concentrazione di massa di lavoratori all’interno delle grandi fabbriche del XIX secolo. Al contrario, è stato il risultato di un salto interamente politico-organizzativo e di autocoscienza. Per riconoscere e spiegare tale cambiamento qualitativo, gli operaisti hanno forgiato il concetto di composizione di classe, il quale chiarisce le differenze materiali e soggettive che caratterizzano la forza-lavoro e che devono essere prese in considerazione nella questione dell’organizzazione.
La composizione di classe, infatti, è lo strumento analitico e politico che ha permesso prima di tutto, attraverso le inchieste operaie, di distinguere diverse soggettività all’interno della classe operaia (l’operaio di mestiere, l’operaio-massa) e poi di estendere l’appartenenza a tale categoria a soggettività che andavano oltre la forma salariale classicamente intesa (la casalinga, il lavoratore precario, ecc.). In questo modo, il concetto di classe ha cessato di essere una sorta di passe-partout politico e discorsivo, per trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia, attraversato da interessi materiali e prospettive politiche non sempre ricomponibili. Se un aggiornamento dell’analitica della composizione di classe appare oggi più indispensabile che mai per cogliere la moltiplicazione dei rapporti di lavoro e la loro compenetrazione con le oppressioni di genere e di razza, essa non può più limitarsi ai processi di sfruttamento e resistenza interumani. Negli anni successivi, infatti, studiosi e attivisti hanno superato le tradizionali analisi della composizione tecnica e politica (le relazioni dei lavoratori con le macchine e le tecniche, e i processi di soggettivazione politica), cominciando a parlare di composizione sociale e spaziale, al fine di integrare nella matrice composizionista le sfere della riproduzione sociale e dell’appartenenza territoriale. Tale innovazione è risultata importante per pensare a forme di solidarietà transnazionale tra coloro che vivono e si oppongono a logiche di dominio di diverso tipo e a grande distanza gli uni dagli altro. Oggi, però, dobbiamo fare un passo in più. Infatti, come hanno illustrato con grande efficacia Léna Balaud e Antoine Chopot (2021) attraverso un’enorme varietà di casi, non siamo i soli a praticare la politica delle rivolte terrestri. Di conseguenza, così come il capitale ha progressivamente imparato a valorizzare in termini monetari non solo la forza-lavoro, ma anche le relazioni sociali al di là del luogo di lavoro e una miriade di elementi della natura umana ed extraumana, allo stesso modo dobbiamo imparare a valorizzare politicamente non solo le nostre singolarità collettive, ma anche l’attivazione di poteri privi di intenzionalità e la cui mobilitazione non produce sempre delle ricadute emancipatrici.
Ciò conduce alla seconda tesi: d’ora in poi qualsiasi internazionalismo coerente ed efficace deve necessariamente presentarsi come una cosmopolitica, basandosi su una comprensione allargata dell’agency politica – o, per dirla con Paul Guillibert (2021), del “proletariato vivente”. Tale rottura fondamentale non implica solo ancorare la politica all’ecologia e alla terrestrità, ma anche riconoscere il nucleo ibrido di qualsiasi coalizione, ben aldilà di ciò che l’intersezionalità delle lotte è stata in grado di concepire e praticare, con la sua articolazione e sincronizzazione delle interdipendenze di classe, genere e razza. Di conseguenza, la soggettività e l’identità dei collettivi coinvolti dovranno lasciarsi rimodellare alla radice, poiché qualsiasi alleanza di questo tipo implica un drastico ripensamento dell’antropocentrismo che ha caratterizzato sino ad oggi e la politica internazionalista e la visione del mondo storico-naturale di molti movimenti sociali. Tale è l’enigma da sciogliere della composizione socio-ecologica di classe.
Tesi 3. Geopolitica: (Critica dei) dualismi
Nel XX secolo la lotta di classe è assurta al livello di scontro geopolitico: prima con la trasformazione sovietica nel 1917 della guerra mondiale interimperialista in guerra civile rivoluzionaria, poi con gli interventi occidentali e giapponesi del 1918 nella guerra civile russa e infine con la fondazione nel 1919 della Terza Internazionale, o Internazionale Comunista. Tale situazione di guerra di classe globale, nonostante i numerosi rovesci e punti di svolta, si è cristallizzata nella Guerra Fredda, con il consolidamento delle due macroaree in competizione e il conseguente tentativo del movimento dei non-allineati di sottrarsi a tale rigida bipartizione del pianeta. La configurazione attuale è per molti aspetti drasticamente diversa, soprattutto per quanto riguarda i temi del dualismo e della catastrofe. Infatti, con la prospettiva della guerra nucleare sempre presente, la seconda metà del XX secolo ha comportato la divisione del mondo in due campi geopolitici e l’assegnazione di continenti e nazioni all’uno o all’altro. Al contrario, il disordine globale emerso dopo l’11 settembre e la fine della cosiddetta pax americana non contrappone più un blocco a guida liberal-capitalista a uno alternativo, sotto la cui egida si suppone possano prosperare forze radical-progressiste o addirittura rivoluzionarie. Per il momento, più ci addentriamo nell’Antropocene, meno vediamo all’orizzonte grandi spazi capaci di catalizzare processi emancipatori su larga scala. A trentacinque anni dalla caduta della cortina di ferro, il mondo è certamente diventato meno unipolare, ma il lento declino dell’egemonia occidentale è andato di pari passo con uno scenario geopolitico sempre più instabile, caotico e pericoloso, in cui i pretendenti a una ridefinizione degli assetti di potere sono sempre più assertivi. L’arresto del disarmo si accompagna infatti oggi a una folle corsa all’accaparramento di risorse preziose e di sbocchi di mercato, ma anche di soft e hardpower, oscurando le prospettive di transizione verso un modello socio-economico ecologicamente sostenibile in cui i rapporti di forza geopolitici siano più equilibrati.
L’esacerbazione delle tensioni inter-imperialiste in un mondo sempre più multipolare, lungi dal sostenere la formazione di movimenti di resistenza/alternativi, può non solo rafforzare le tensioni autoritarie dei capitalismi occidentali, ma accentuare ulteriormente le tendenze bellicose e militariste volte a ridisegnare le linee di faglia geopolitiche dell’inizio del XXI secolo. In una simile congiuntura globale, è chiaro che la (ex) superpotenza statunitense e i suoi alleati non detengono più il monopolio dell’iniziativa tramite le loro mani armate militari (NATO) e finanziarie (FMI): Cina e Russia, così come numerosi altri Paesi e attori non-statali, si sottraggono sempre più ai diktat occidentali, alimentando tendenze centrifughe che non porteranno necessariamente ad un miglioramento delle condizioni di vita delle classi subalterne o dell’abitabilità del pianeta. Al contrario, gli antagonismi geopolitici in corso incitano sempre più Stati ed imprese all’appropriazione sfrenata di materie prime e combustibili fossili, all’attraversamento delle frontiere e all’invasione di spazi dentro e fuori i proprio confini nazionali. Da questo punto di vista, non solo le frontiere del capitale e della sovranità statale si sono smarcate rispetto alla stretta relazione di cui godevano durante l’era moderna, ma le ripercussioni negative di tali operazioni estrattive non riguardano più, come nell’imperialismo tradizionale, principalmente le popolazioni locali, bensì hanno un impatto immediato su scala planetaria. Infatti, le guerre attuali, ancor più di quelle passate, manifestano una dimensione geo-ecologica, di cui le lotte anti-estrattiviste dei popoli indigeni costituiscono spesso il fronte più avanzato. Sebbene nella loro ormai secolare storia anticoloniale esse non si siano rappresentate come ecologiche in sé e per sé, esse assumono un nuovo significato proprio alla luce del riscaldamento globale.
Terza tesi, dunque: oggi l’internazionalismo, nella sua dimensione costitutivamente antimperialista, non può che tingersi di verde, poiché nell’Antropocene l’invasione di spazi e territori non avviene più solo manu militari, con mezzi anfibi e aerei, ma si realizza in modo molto più insidioso, ramificato e persistente attraverso l’inquinamento dei suoli, dei mari e dei cieli e attraverso la devastazione multiscalare degli equilibri ecosistemici. Tale quadro richiede almeno due precisazioni: 1. l’abbandono definitivo della vecchia logica campista tale per cui il nemico del mio nemico è mio amico – abbiamo infatti molteplici nemici in guerra tra loro, dentro e fuori i confini degli Stati nazionali in cui viviamo e aldilà delle rispettive sfere di influenza geopolitica; 2. la necessità di collegare le lotte territoriali contro l’estrattivismo, ovunque esse si svolgano (Nord o Sud America, Cina o Russia, Europa o Oceania, Africa o Medio Oriente), a quelle dei migranti climatici e per la giustizia ambientale e climatica. Ma questa triangolazione virtuosa può essere realizzata solo su scala transnazionale, ben oltre i confini della cosiddetta Nuova guerra fredda.
Tesi 4. Geografia: Composizione spaziale e circolazione transnazionale
Secondo la visione dominante, dopo il crollo del socialismo reale si sarebbe instaurato un gioco a somma zero in cui “più globalizzazione” equivale a “meno confini”. In questa prospettiva, l’allentamento delle barriere tra gli Stati nazionali (accordi di libero scambio, trasferimenti di tecnologia, liberalizzazione degli investimenti diretti esteri, integrazione dei sistemi di produzione, costruzione di spazi istituzionali sovranazionali, ecc) segnalerebbe in modo inconfutabile la graduale erosione di significato delle frontiere. In realtà, dopo la caduta del Muro di Berlino, i confini si sono moltiplicati e diversificati. Come mostrano brillantemente Sandro Mezzadra e Brett Neilson (2014), non solo le tendenze alla “denazionalizzazione” sono state bilanciate da controtendenze alla “rinazionalizzazione”, ma i confini si sono moltiplicati ed eterogeneizzati. Se da un lato la deregolamentazione finanziaria ed economica è andata di pari passo con il rafforzamento delle forze di polizia e di sicurezza, dall’altro il mondo ha vissuto un’esplosione di spazi intra e transnazionali: zone economiche speciali, corridoi logistici, distretti finanziari, enclavi estrattive e così via. Negli interstizi tra questi siti e lungo le linee di demarcazione che tracciano i contorni delle geografie sociali contemporanee, la sovranità nazionale così come è stata elaborata nel corso della modernità è stata significativamente superata e i capitalismi contemporanei hanno assunto nuove costituzioni materiali. Attualmente, infatti, il paesaggio globale non solo sembra traballante, ma appare anche fondamentalmente composito e in costante riconfigurazione. Inoltre, la materialità ontologica dell’attuale capitalismo globale ha superato le distinzioni binarie tra Occidente e resto del mondo (the West and the rest), costringendoci a riconsiderare i presupposti epistemologici delle teorie del sistema-mondo e delle teorie dello “sviluppo ineguale e combinato”. Le descrizioni delle relazioni geoeconomiche e geopolitiche del (neo-)colonialismo e del (neo-)imperialismo proposte da questi approcci si basano infatti il più delle volte su una concezione rigida della divisione inter-nazionale del lavoro, o addirittura su dicotomie topografiche che oppongono direttamente il “centro” alle “periferie” o “semi-periferie”. La fase più recente della globalizzazione, invece, sta generando un nuovo intreccio tra ciò che per lungo tempo è stato rigidamente gerarchizzato, vale a dire: una tendenza a diventare Nord di (certe parti del) Sud e una tendenza a diventare Sud di (certe parti del) Nord.
Questo sconvolgimento geografico non ha tardato a manifestarsi sul piano politico. Dal punto di vista della composizione spaziale e della circolazione transnazionale delle lotte, i movimenti degli anni 2010 sono riusciti a rompere ogni rigida schematizzazione tra Nord e Sud globale – una distinzione che, come abbiamo detto, è parzialmente sempre più obsoleta per la stessa accumulazione del capitale. Le occupazioni delle piazze, ad esempio, sono partite dalla costa meridionale del Mediterraneo per circolare in gran parte del Maghreb e del Medio Oriente, passando poi per la Grecia e la Spagna, per attraversare infine l’Oceano Atlantico e arrivare negli Stati Uniti, prima di riemergere due anni dopo in Turchia e in Brasile. Il nuovo movimento femminista globale ha avuto una traiettoria di simile portata: nato in Polonia e Argentina nell’autunno del 2016, ha presto raggiunto gli Stati Uniti, la Spagna e l’Italia, poi la Turchia e molti altri Paesi dell’America Latina, prima di esplodere nel fenomeno globale del #metoo. E anche se prendiamo un caso sui generis come quello dei Gilet Gialli, possiamo vedere come le tradizionali geografie della politica francese siano state stravolte: la mobilitazione emersa dalle aree periurbane, dalle periferie vicine e diffuse (i margini interni della Repubblica) è stata subito accolta con grande entusiasmo nei territori d’oltremare (i “resti” dell’impero coloniale), e successivamente – soprattutto durante le manifestazioni del sabato – nei cuori dorati di tutte le più grandi città francesi. Inoltre, è una simile lezione che si trarre da una rivolta straordinaria come quella delle proteste contro la violenza della polizia negli Stati Uniti nella primavera del 2020: all’interno del “cuore” stesso dell’Impero, le persone razzializzate devono lottare contro l’eredità tutt’ora in corso della schiavitù, cioè il carattere strutturale del razzismo e della supremazia bianca.
La quarta tesi potrebbe quindi essere espressa come segue: la vecchia coincidenza stabilita dall’operaismo tra composizione tecnica e politica (Lenin in Inghilterra), così come il vecchio credo leninista/terzomondista, non sono più attuali; ora non possiamo pensare di puntare tutto politicamente sul “punto più avanzato dello sviluppo capitalistico” o, al contrario, sull'”anello più debole del comando imperiale”. La composizione spazio-temporale del capitalismo contemporaneo richiede un cambiamento di prospettiva. I casi citati ci mostrano che d’ora in poi non possiamo più stabilire aprioristicamente un sito (il Nord o il Sud, l’Ovest o l’Est, la metropoli o la “campagna”) come spazio privilegiato da cui nasceranno le lotte. Il mondo di oggi è molto più complesso e interconnesso rispetto al passato e lo stesso vale per la composizione spaziale e la circolazione transnazionale delle lotte.
Tesi 5. Ontologia II: Sulla dialettica particolare/universale
Il capitale è una forza storica che omogeneizza e differenzia; fin dagli albori della modernità, si sviluppa su scala globale attraverso operazioni universalizzanti, che tuttavia non riducono mai alla completa uniformità i territori e le soggettività su cui esercita il potere. Al contrario: il capitale produce sia identità che singolarità; è una relazione sociale generale che si esprime in modi specifici a seconda dei contesti storico-geografici e politico-economici. In tal senso, il capitale manifesta una tendenza totalizzante senza mai dare luogo a una vera totalità, pienamente realizzata e racchiusa in sé stessa. È, infatti, costitutivamente caratterizzato da un legame intimo con l’esterno, con ciò che lo supera e si trova al di fuori di esso. E sono proprio tali esternalità a sostanziare la contingenza e l’eterogeneità in cui di volta in volta si incarna. La sua poliedricità è quindi data dalla capacità di adattarsi alla varietà delle situazioni, traendo vantaggio dalla pervicace diversità dei fattori oggettivi e soggettivi che gli si presentano dinnanzi. Attraverso le sue continue spinte espansive – estensive (o orizzontali) e intensive (o verticali) – esso tende costantemente ad assorbire e produrre nuovi spazi, risorse e ambienti, soggiogando al contempo, per quanto possibile, nuove forze del lavoro (Silver, 2008). Se non incontrano resistenza, infatti, le spirali tridimensionali della valorizzazione si allungano sempre più verso l’esterno e si densificano sempre più verso l’interno. Le frontiere mobili del Gesamtkapital, tuttavia, nella loro incessante necessità di assorbire nuovi elementi naturali, sociali e umani, incontrano dei limiti alla loro crescita. Ma tali limiti non sono sempre e solo determinati da contraddizioni oggettive e immanenti – variazioni nella composizione organica, obsolescenza tecnologica e organizzativa, esaurimento di alcuni mercati, diverse forme di concorrenza, e così via. Essi possono anche trascendere, per quanto parzialmente, tali contraddizioni e assumere una natura soggettiva e politica.
In quanto relazione sociale, il capitale è infatti intrecciato per definizione con l'”alterità”. La fenomenologia dei suoi “altri” è piuttosto copiosa: una natura sempre più storicizzata, tutta una serie di campi, sfere e domini sociali che resistono alla più completa mercificazione, ma anche e soprattutto il lavoro-vivo e i comportamenti d’insubordinazione. Ora, nel corso dell’ultimo decennio, abbiamo assistito all’emergere sulla scena globale di diversi cicli di mobilitazione che hanno ripreso a loro volta la dialettica del particolare e dell’universale che caratterizza, sia da un punto di vista logico che storico, l’accumulazione capitalistica. In molti casi, infatti, negli ultimi dieci anni i movimenti hanno cercato di unire delle lotte mirate a dei progetti di più ampia trasformazione sociale. Che si trattasse del rovesciamento di un tiranno, dell’opposizione a una ristrutturazione sociale austeritaria, della rivolta contro gli effetti della speculazione finanziaria, della protesta contro un piano di riqualificazione urbana, della contestazione dell’aumento dei costi dei trasporti pubblici, della lotta contro la violenza sessuale e di genere, della battaglia per aggirare i regimi di frontiera, o della frustrazione generalizzata per l'”alto costo della vita”, le ingiustizie fiscali, la brutalità della polizia, la corruzione del sistema politico, il negazionismo climatico e pandemico, ecc., i movimenti emersi nel corso degli anni 2010 hanno cercato di andare oltre i quadri (più o meno ristretti) delle loro lotte specifiche per sfidare la crisi del sistema capitalista nel suo complesso e le sue ricadute antisociali, antidemocratiche e antiambientali. Nonostante tutti i loro limiti e le loro difficoltà, molto spesso essi sono stati in grado di mostrare il carattere strutturale delle forme di dominio contro cui lottano, rimanendo sempre capaci di elevare la generalità delle prospettive politiche a partire da rivendicazioni specifiche.
Quinta tesi: questo ci mostra come nessuna singola istanza possa aspirare apriori ad occupare il centro della scena, determinando i ritmi e le poste in gioco delle rivolte e spingendo tutti a ricomporsi attorno ad essa: i diritti sociali e politici, certo, ma anche le tanto decantate identity politics o, ancora di più, le molteplici sfaccettature della crisi ecologica: ognuna di queste cause, nel vivo degli eventi, può di fatto fornire un punto di raccolta attorno al quale lanciare ampie dinamiche di mobilitazione… potenzialmente capaci di determinare una rottura storica! Sono quindi i punti di forza e i limiti/le debolezze dei movimenti realmente esistenti che vanno considerati, esaminando nel dettaglio e da un punto di vista radicalmente immanente la particolarità di ogni situazione concreta, senza rimpiangere i bei tempi in cui i movimenti sociali e rivoluzionari osavano realmente far paura allo Stato e male al capitale.
Tesi 6. Pratiche I: Resistenza e prefigurazione
Queste osservazioni ci portano a riprendere questioni che hanno a lungo assillato le forze rivoluzionarie del XIX e XX secolo: ad esempio, l’opposizione tra riforma e rivoluzione, l’articolazione tra tattica e strategia, il rapporto tra sindacati, partiti e movimenti sociali. Come appaiono oggi il ruolo e la consistenza dell’idea di democrazia, di fronte all’aggravarsi delle crisi, all’ascesa dell’estrema destra e alla svolta autoritaria dello Stato? In che modo un mondo pandemico e soggetto a riscaldamento globale accelerato ci obbliga a ripensare il rapporto tra pratiche antagoniste e istituenti? In che misura gli scenari di guerra permanente e la nuova situazione geopolitica ci spingono a porre in modo nuovo problemi pratici e organizzativi? Questi temi contribuiscono a delineare un panorama drammatico in cui la politica dell’antipotere e la politica della presa di potere devono essere ripensate alla luce dell’urgenza cronica – l’unico orizzonte insuperabile del nostro tempo. Non è un caso, quindi, che i movimenti sociali contemporanei cerchino di lavorare nella direzione di una pluralizzazione delle prospettive, intrecciando, da un lato, le lotte sociali, politiche, ecologiche, transfemministe e decoloniali nel Nord globale con quelle nel Sud globale e, dall’altro, combinando diversi repertori di azione: manifestazioni, scioperi, blocchi, accampamenti, occupazioni, rivolte, sabotaggi o campagne elettorali.
E infatti, nell’ultimo decennio i movimenti antirazzisti, ad esempio, non hanno esitato a sperimentare una molteplicità di tattiche (confronto con le forze dell’ordine, sommosse, saccheggi, incendi, ma anche occupazioni di spazi pubblici, costituzione di assemblee basate sulla democrazia diretta, processi per l’ottenimento di verità e giustizia), per svelare le molteplici stratificazioni del razzismo (nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle carceri, nell’accesso all’assistenza sanitaria, alla casa, ecc.) a partire dagli omicidi di giovani uomini non-bianchi da parte della polizia. Per quanto riguarda le rivolte popolari del 2018-19, la maggior parte delle quali è stata innescata dall’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi di base, i picchi insurrezionali, i blocchi dell’economia e delle metropoli e l’invenzione di forme orizzontali di auto-organizzazione sono stati in grado di tenere insieme conflittualità e contropotere, chiedendo più denaro e riappropriandosi la politica. Lo stesso vale per diversi movimenti transfemministi ed ecologisti: la volontà di opporsi al patriarcato o di lottare contro lo sfruttamento indiscriminato della natura non solo non esclude, ma anticipa l’autentica liberazione del desiderio e la sperimentazione concreta di forme di vita quotidiana alternative, in cui le interazioni interpersonali e le relazioni con l’ambiente e gli altri esseri viventi non riproducono le logiche di potere oggi prevalenti. Queste espressioni di resistenza e di alternativa, di offensività e autodifesa, di creazione di legami e costruzione di spazi di autonomia, costituiscono esempi molto concreti e produttivi di potere politico, i quali si concretizzano nella combinazione di due logiche largamente complementari: 1. l’efficacia immediata dell’opposizione allo Stato, ai padroni e alle forze dell’ordine; 2. il lavoro di costruzione, a breve/medio termine, di aree di autonomia e luoghi capaci di sperimentare controistituzioni non-sovrane e anticapitaliste, nei quali organizzare spazi di concentrazione diffusa della forza.
Ecco allora la sesta tesi: nella maggior parte dei casi, per i movimenti sociali contemporanei la necessità di resistere a molteplici relazioni di dominio (in casa, al lavoro, nelle strade, nei quartieri, nei territori, ecc. ) non è dissociata dalla volontà di affermare nuovi modi di vivere nel mondo e con gli altri, alludendo, anche solo implicitamente, alla dissoluzione di molte dicotomie che hanno strutturato la tradizione rivoluzionaria, come quelle tra: centralizzazione e decentralizzazione, unità e diversità, macropolitica e micropolitica, partito e movimento, organizzazione e spontaneità, egemonia e autonomia, e così via. Questa indicazione, tuttavia, rimane troppo spesso per lo più sbilanciata a favore del secondo polo delle diadi. Infatti, nel loro stesso dispiegarsi, i movimenti recenti richiedono l’attuazione, qui e ora, di pratiche che prefigurano un futuro emancipato, rinunciando alla vecchia subordinazione dei mezzi ai fini o alla gerarchizzazione dei motivi di lotta.
Tesi 7. Pratiche II: Processi di soggettivazione e inchiesta militante
Le ultime tesi non implicano che i movimenti sociali non possano essere criticati, né tanto meno che tutte le rivendicazioni da essi manifestate siano equivalenti. Si tratta piuttosto di seguire le loro dinamiche dall’interno, partecipando attivamente al loro autosviluppo attraverso, ad esempio, la chiarificazione delle ragioni e degli obiettivi e il consolidamento dei percorsi di mobilitazione. In tal senso, la pratica dell’inchiesta militante, il cui ruolo consiste in un processo di trasformazione reciproca della soggettività in lotta e del contesto materiale, è di grande utilità. Praticare l’inchiesta militante significa rimanere sempre fedeli alla singolarità della contingenza o, per dirla in altro modo, sviluppare un approccio radicalmente materialista e fondamentalmente pragmatico, rifiutando qualsiasi tipo di apriorismo politico – sia esso d’avanguardia, savant o identitario. Con l’indagine militante, l’attenzione si concentra sui processi di soggettivazione, chiedendosi: cosa spinge i soggetti a non subire più passivamente le condizioni imposte loro, ma a reagire, a fare qualcosa insieme, ad assumere pratiche di lotta più conflittuali, a mettere in piedi forme organizzative più avanzate? Oppure, dove il conflitto non è aperto ed esplicito, dove si possono trovare solo tracce sottili o indirette di resistenza: quali sono le dinamiche attraverso cui la norma viene interiorizzata? Cosa porta gli individui o i gruppi ad accettare, riprodurre passivamente o addirittura promuovere attivamente relazioni o condizioni di assoggettamento? In entrambi i casi, la soggettività è una questione di lotta. Da questo punto di vista, ciò che conta (di più) non è (tanto) l’affinità politica che precede il momento dell’incontro, ma il percorso che si fa assieme. Come si co-evolve, cosa si porta gli uni agli altri, cosa si impara a vicenda e cosa si fa lungo il cammino.
Non è quindi (solo) la posizione occupata all’interno delle relazioni sociali a fare di un gruppo un soggetto politico privilegiato. Così come la classe non è un dato sociologico, il lavoro (salariato) – nonostante la sua innegabile centralità – non esaurisce il terreno del conflitto: uno studente, un disoccupato o un lavoratore precario che si batte con determinazione può valere molto di più, in termini politici, di un operaio stacanovista e scioperante che occupa un nodo vitale nel processo di accumulazione. Inoltre, è l’insieme delle condizioni materiali di vita che appare decisivo, anche se il lavoro, nei suoi molteplici avatar, conserva un posto che non può essere ignorato. Di conseguenza, è necessario non separare “sfera della produzione” e “sfera della riproduzione”, o le lotte “economiche”, “sociali”, “politiche” ed “ecologiche”, ma lavorare sull’accumulo di conoscenze critiche e sull’espansione dell’antagonismo. E ancora una volta, recentemente la questione della combinazione tra lotte contro lo sfruttamento e lotte contro il dominio è stata affrontata in modo stimolante da numerosi movimenti sociali. Senza farsi illusioni sui rapporti di forza realmente in atto, le mobilitazioni contemporanee hanno dato alcuni segnali preziosi. A Tunisi, al Cairo, ad Atene, a Madrid o a New York, la battaglia “economica” contro la povertà assoluta, lo smantellamento dello Stato sociale, lo sgretolamento del mercato del lavoro o il cappio dell’indebitamento non è stata dissociata dalla necessità e dal desiderio “politico” di prendere in mano le decisioni riguardanti la produzione e la riproduzione delle condizioni materiali della vita collettiva. Con lo sciopero transfemminista globale assistiamo alla trasposizione nella sfera economica della cessazione temporanea di ogni attività lavorativa – monetizzata o meno, come il lavoro domestico o il lavoro affettivo e sessuale – di questioni di genere come l’aborto, lo stupro, il femminicidio, ecc. Lo stesso vale per le marce per il clima: gli studenti di mezzo pianeta si sono astenuti dai loro impegni scolastici il venerdì per scuotere l’opinione pubblica mondiale e la comunità internazionale, invitandole a non nascondere la testa di fronte all’urgenza e alla gravità delle molteplici crisi ecologiche. Da un punto di vista militante, in tutti i casi il compito principale consiste quindi nello spingere sempre più in là i processi di soggettivazione, radicalizzando i livelli di conflitto, ampliando lo spettro delle rivendicazioni, approfondendo la messa in discussione delle relazioni esistenti e collegando le diverse lotte e i rispettivi nuclei. La pratica dell’inchiesta militante, dedicata alla co-produzione di conoscenza di parte, si rivela altamente costruttiva. Contro ogni visione pastorale o coscientizzante della politica, il metodo dell’inchiesta militante propone un approccio processuale in cui la posta in gioco riguarda l’autotrasformazione delle soggettività attraverso la loro stessa attività di trasformazione del mondo circostante. Non si tratta quindi di istruire i dominati, di insegnare loro ciò che sanno già molto bene per sperimentarlo nella vita quotidiana in modo che possano cambiare le loro idee e i loro modi di pensare, ma di creare insieme le condizioni materiali e soggettive affinché ci si possa comportare in modo diverso.
Settima tesi: la soggettività è e rimane un campo di battaglia. Di conseguenza, solo costruendo internalità alle lotte e stabilendo una presenza che possa radicarsi nei luoghi in cui viviamo e lavoriamo – una presenza che possa riprodursi nel tempo – possiamo migliorare la nostra capacità di rendere i processi di (contro-)soggettivazione sempre più virtuosi, forti e duraturi. Ma il nostro comune potere di pensare agendo e di agire pensando si nutre delle analisi, delle narrazioni e dei saperi pratici fatti da e per le lotte. Ecco perché la produzione e la circolazione delle diverse esperienze di lotta (le loro pratiche, simboli, immaginari, parole d’ordine, ma anche le loro sconfitte, punti ciechi, ecc.) costituiscono un momento preliminare e complementare a qualsiasi tentativo di transizione verso una società post-capitalista.
Tesi 8. Organizzazione I: Contropotere – Doppio potere – Contropotere
Da quanto detto finora si possono intraprendere diverse strade. La più decisiva, tuttavia, riguarda l’approfondimento del livello organizzativo. La gravità della situazione attuale, con la sua concatenazione di crisi di portata abissale, riattiva la prospettiva politica altamente tragica del doppio potere. Il doppio potere, infatti, non solo costituisce una valida alternativa all’ambiguità degli approcci populisti e alla fiacca ripresa della variante riformista, ma si staglia anche in un orizzonte di critica della sovranità e della centralità dello Stato-nazione quale è emerso da queste succinte considerazioni. Inoltre, permette di combinare e federare l’ampia varietà di sensibilità e orientamenti che animano i movimenti contemporanei, rafforzandone i legami transnazionali. All’incrocio tra politica autonoma e politica istituzionale, la prospettiva del doppio potere offre una via d’uscita dalle impasse in cui sono cadute quasi tutte le esperienze radicali emerse nel corso degli anni 2010. Nessuna di esse, per quanto dirompente o massiccia, è riuscita finora a segnare una svolta duratura: non le perturbazioni della classe operaia delle catene globali del valore, né le irruzioni delle insorgenze di BLM o dei Gilet Gialli; non il pacifismo ecologico del Nord globale, né le lotte sindacali, indigene e contadine di quello del Sud globale; non gli scioperi femministi, né gli esodi dei migranti; non l’assemblea costituente cilena, né le ipotesi progressiste della sinistra europea, nord- e latino-americana.
Oggi, ovviamente, gli Stati sono sempre più sotto il controllo di organismi sovra-, inter- e transnazionali e sono sempre più soggetti ai vincoli di dispositivi di governance, attori politici e processi economici che trascendono le loro frontiere. Di conseguenza, sembra illusorio considerarli come il campo di battaglia prioritario per le dinamiche di liberazione. Tuttavia, ciò non significa che si debba a priori disinvestire questo spazio da qualsiasi impegno politico per trincerarsi in un puro “al di fuori”, a distanza di sicurezza da questa macchina ricuperatrice di ogni spinta e percorso di emancipazione. Oggi più che mai non possiamo pensare di ritirarci nel perimetro dello Stato-nazione, facendo di esso l’unica linea di difesa di un anticapitalismo coerente. Ma non possiamo nemmeno pensare di poter incidere davvero su macrofenomeni come le guerre (inter)imperialiste o il riscaldamento globale senza l’apporto delle leve statali o sovrastatali. Il punto è trovare un modo costituente per tenere insieme e organizzare politicamente la pluralità di istanze espresse dalla moltiplicazione soggettiva delle situazioni di lavoro e di vita, costruendo, rafforzando, sperimentando e collegando tra loro contropoteri in grado di coprire più fronti a diverse scale: dentro e contro l’apparato statale, fuori e in alternativa ad esso, fuori e contro di esso. Dai quartieri popolari agli spazi di frontiera, passando per i luoghi di vita, formazione, lavoro, informazione, ecc. ogni “realismo rivoluzionario” (Rosa Luxembourg) deve cercare e praticare il consolidamento reciproco tra istanze eterogenee di liberazione all’interno di un quadro ontologico-politico che faccia saltare le posture di mero principio. Né verticale né orizzontale, come direbbe Rodrigo Nunes (2021).
In effetti, da un punto di vista storico, i movimenti rivoluzionari hanno sempre concepito il doppio potere come un modo per preparare il terreno per una società post-capitalista. Nella prospettiva socialista, il doppio potere dà luogo a una transizione lunga e graduale; mentre nella prospettiva comunista la transizione è accelerata e completata da una rottura insurrezionale. Al contrario, seguendo ancora Mezzadra e Neilson (2021), sarebbe necessario ridefinire la questione del doppio potere in termini di teoria dell’organizzazione: si tratterebbe allora di costituire un’impalcatura politica stabile capace di rafforzarsi e dispiegarsi attraverso la proliferazione di nuclei di contropotere. Il doppio potere, quindi, come architettura permanente per l’auto-organizzazione dei movimenti e il governo della società, che si ramifica attraverso una fitta rete di contropoteri. Sebbene in forma embrionale, è questa eredità che consegna i successi parziali e le grandi sconfitte dei cicli di lotta degli anni 2010. Le recenti rivolte hanno avuto la capacità di far circolare slogan, mettere in moto pratiche e accumulare esperienze soggettive, organizzative e discorsive che hanno scosso i governi di tutto il mondo, ma non hanno saputo interrompere l’approfondimento delle tendenze alle crisi – siano esse finanziarie, sociali, geopolitiche, sanitarie o climatiche. Ad esempio, sulla scia del primo ciclo di confinamenti, abbiamo assistito a significative lotte operaie e rivolte antirazziste, accompagnate da politiche statali e istituzionali molto contraddittorie – perlomeno fino alla ricalibrazione della governance capitalistica della pandemia. A tal proposito, Alberto Toscano (2021) e Panagiotis Sotiris (2021) hanno parlato di doppio biopotere. Questa prospettiva, ancorata alla sfera della riproduzione (salute, istruzione, abitazione, ecc.), contiene in sé le tracce germinali di una contro-strategia antagonista alla sovranità statale e alla governance neoliberale, essendo interamente incentrata sulle lotte sociali e sul sapere democratico. Più in generale, dall’eredità delle Pantere Nere nelle downtown all’invenzione di nuove istituzioni e forme di autogoverno in Chiapas e Rojava, passando per le pratiche di contro-conoscenza di ACT UP, la difesa della terra da parte delle comunità indigene e così via, tali esperimenti mostrano importanti punti di forza, ma rendono anche espliciti i limiti da superare. Da un lato, essi possono costituire il cuore pulsante di un’attività già in corso di smantellamento delle relazioni sociali capitalistiche e delle forme di vita ad esse inerenti. Ed essi possono inoltre indurre rotture politiche di vario tipo: dalle secessioni territoriali all’autonomia di certi settori sociali attraverso opzioni elettorali solide e radicali. D’altro canto, però, troppo spesso tali esperienze non attingono alle sfere più alte della politica e mancano di coordinamento transnazionale, non riuscendo a incidere realmente sulle forze inerziali che riproducono le disuguaglianze sistemiche. A questo proposito, le minacce pandemiche e climatiche, così come lo spettro dell’escalation militare e del riarmo nucleare, rendono ancora più evidenti le lacune di queste indispensabili esperienze. Pertanto, se vogliono continuare ad avere voce in capitolo in un mondo sull’orlo del disastro, esse non possono che andare oltre sé stesse.
Tesi numero otto: l’elaborazione e la realizzazione della prospettiva politica del doppio potere riguarda l’aumento della potenza prodotto dalla molteplicità e dall’eterogeneità dei contropoteri; o, per dirla in altro modo, l’espansione delle frontiere dei processi di liberazione che i diversi contropoteri – e le loro azioni reciproche – aspirano a/possono/devono determinare. Di conseguenza: il contropotere come precondizione e orizzonte del doppio potere. A tal proposito, una doppia precisazione. Per quanto riguarda i contropoteri dal basso, essi non devono limitarsi a essere fini a sé stessi nel loro potenziale di prefigurare relazioni realmente emancipate, ma devono anche svolgere un ruolo cruciale nella sfida all’ordine esistente. Al contrario, i contropoteri che operano a livello meso- e macro-politico devono sempre rimanere variabili dipendenti dai e funzionali ai processi di liberazione, altrimenti rischiano di sclerotizzarsi in dinamiche autoreferenziali, burocratiche e strumentali, condannandosi a perdere, prima o poi, ogni spinta trasformativa.
Tesi 9. Organizzazione II: Alleanze transnazionali
Alcune delle esperienze più significative degli anni 2010 si sono svolte e coordinate su scala eminentemente transnazionale, dagli scioperi transfemministi alle marce per il clima, dagli esodi dei migranti alle reti di soccorso e accoglienza. Questo non implica, ipso facto, il loro successo. Tuttavia, è indiscutibile che l’eco mediatica e le (deboli) strutture organizzative attraverso le quali si sono sviluppate abbiano beneficiato di tale trascendenza dei confini nazionali. Altri movimenti, come BLM o le occupazioni delle piazze, hanno prodotto risonanze al di là del proprio Paese, rafforzando le lotte su questioni simili altrove. Altri ancora, come le rivolte popolari che hanno costellato il biennio pre-pandemico, hanno imitato gli uni gli stili, le pratiche e le rivendicazioni degli altri, ispirandosi e citandosi a vicenda, ma senza incontrarsi realmente su un terreno comune. Altri, come l’incredibile sciopero agrario in India nel 2019 (il più grande sciopero mai avvenuto nella storia dell’umanità), o più recentemente le lotte dei lavoratori cinesi contro le politiche di zero-covid, o le proteste delle donne (e delle giovani generazioni) iraniane contro il regime di Teheran, per quanto potenti e dirompenti, non sono riusciti a innescare autentici processi di solidarietà, materiale e simbolica, altrove. Questi nodi irrisolti ci spingono a porre la questione, teorica e organizzativa, della sincronizzazione e federazione delle differenze, rinnovando la pratica politica delle alleanze. Se, infatti, dopo i fallimenti del periodo post-2008, la questione politica primaria consiste 1. nell’intensificazione della pluralità delle lotte venute alla ribalta e 2. nel loro collegamento sulla base delle proprie autonomie rispettive, allora la prospettiva di una proliferazione dinamica, di un collegamento e di una sintonizzazione dei centri di lotta, cioè il rafforzamento, la propagazione e l’armonizzazione delle lotte provenienti da diversi focolai di mobilitazione, costituisce un orizzonte fondamentale del lavoro politico contemporaneo. Per dirla altrimenti, l’internazionalismo implica sempre, per definizione, la capacità politica di tradurre organizzativamente e discorsivamente lotte e rivendicazioni differenti attraverso spazi, scale e soggettività eterogenee.
Infatti, la relativa autonomia di ciascuna delle strutture di dominio, la loro reciproca irriducibilità, non richiede affatto il sacrificio di una componente a scapito delle altre. Al contrario, rivela la loro simultaneità, aprendo a una politica dell’articolazione (Hardt, Negri, 2020). Tale approccio si declina spazialmente in due modi diversi ma intrecciati, a seconda che si tratti di processi organizzativi su scala locale o transnazionale. Nel caso delle alleanze locali, ciò implica non separare le oppressioni di genere-razza-sesso dallo sfruttamento lavorativo, senza limitarsi ad una semplice sommatoria delle diverse forme di dominio: come lavoratrice + donna + nera + lesbica, andando alla ricerca delle soggettività più sfruttate/oppresse. Il nocciolo della questione non è immaginare alleanze esterne o semplici coalizioni tra una pluralità di soggettività disparate, ognuna delle quali sostiene le lotte delle altre senza lasciarsi trasformare intimamente da esse dall’interno. Si tratta di tenere presente il fatto che la classe è plasmata dalle dimensioni di razza, genere, sesso, disuguaglianze spaziali e ambientali, ecc. e che le lotte ecologiche, transfemministe, antirazziste, ecc. sono costitutive della (lotta di) classe. Ecco ciò che Sadri Khiari ha definito prima “internazionalismo domestico” e poi “internazionalismo decoloniale” (2013), e ciò che Angela Davis, in un registro un po’ diverso, ha chiamato “intersezionalità delle lotte” (2016). Nel caso delle alleanze transnazionali, invece, si tratta soprattutto di costruire a distanza reti di sostegno attivo alle dinamiche in atto, a partire dalle rivendicazioni ad esse inerenti. Dalle questioni alimentari, sanitarie e umanitarie che sempre più spesso agitano vaste regioni (non solo) del Sud globale, alle rivolte basate su rivendicazioni più classiche come lavoro, reddito, giustizia, democrazia, ecc.: le soggettività coinvolte non solo non possono rimanere intoccate, ma devono tenere il passo insieme.
Nona tesi: una coalizione intersezionale e un’alleanza transnazionale sono spazi di composizione per una moltitudine eterogenea di persone, la cui sintonia è vitale per il rinnovamento dell’internazionalismo oggi. Infatti, è proprio sulla base dell’irriducibile pluralità e diversità delle soggettività che lottano contro lo stato di cose esistente che sorge l’enigma organizzativo delle a-sincronicità da accordare: da questo nodo dipende non solo lo sviluppo del capitale, ma anche quello dell’anticapitalismo. Ciò detto, un internazionalismo all’altezza delle sfide del presente deve sempre essere in grado di evitare il doppio scoglio dello storicismo e della cinica prioritizzazione degli obiettivi che hanno caratterizzato molte esperienze novecentesche (Chatterjee, 2016). Nonostante i loro innegabili limiti e fallimenti, non v’è dubbio, però, che gli esperimenti dell’alter-globalismo dei primi anni Duemila e la moltitudine di rivolte del 2010 abbiano offerto un’opportunità concreta per ripensare le pratiche di solidarietà e alleanza politica al di là delle specificità delle condizioni di vita e di lavoro e oltre i confini dei singoli Stati nazionali. Come il canovaccio di una polifonia ancora in fase di scrittura, essi aiutano a prefigurare ciò che il transnazionalismo nel XXI secolo può e deve essere.
Bibliografia
– P. Anderson, “Internationalism: A Breviary”, in New Left Review, 14, 2002;
– J. M. Antentas, “Sliding Scale of Spaces and Dilemmas of Internationalism”, in Antipode, 47, pp. 1101-20, 2015;
– Id., “Global Internationalism: An Introduction”, in Labor History, 63/4, 2022, pp. 425-40;
– L. Balaud, A. Chopot, Nous ne sommes pas seuls, Seuil, 2021;
– E. Balibar, Cosmopolitiques, La découverte, 2022;
– A. Bayat, Revolution Without Revolutionaries, Stanford University Press, 2017;
– P. Chatterjee, “Nationalism, Internationalism, and Cosmopolitanism”, in Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, 36, 2016, pp. 320-34.
– S. Clayton (edited by), The New Internationalists, MIT, 2020;
– A. Davis, C. West, Freedom is a Constant Struggle, Haymarket, 2016;
– V. Gago, La potenza femminista, Capovolte, 2022;
– P. Guillibert, Terre et Capital, Editions Amsterdam, 2021;
– M. Hardt, A Negri, “Impero, vent’anni”, in Euronomade, 2020;
– C. Johnson, After Black Lives Matter, Verso, 2023;
– S. Khiari, Malmcom X, Editions Amsterdam, 2013;
– A. Malm, Fossil Capital, Verso, 2016;
– Id., Come far saltare un oleodotto, Ponte alle grazie, 2022;
– S. Mezzadra, B. Neilson, Confini e frontiere, Il Mulino, 2014;
– Id., Operazioni del capitale, Manifestolibri, 2021;
– T. Mitchell, Carbon Democracy, Verso, 2013;
– K. Moody, On New Terrain, Haymarket, 2017;
– R. Nunes, Neither Vertical nor Horizontal, Verso, 2021;
– B. Silver, Forze del lavoro, Mondadori, 2008;
– P. Sotiris, “Thinking Beyond the Lockdown”, in Historical Materialism, 27, 2020;
– A. Toscano, “The State of the Pandemic”, in Historical Materialism, 28, 2020;
– M. Tronti, Operai e capitale, DeriveApprodi, 2013;
– M. Van der Linden, Workers of the World, Brill, 2010.
[1] Esistono molte storie delle tre (o quattro) internazionali e del movimento dei non-allineati, così come esistono molti libri che raccontano o analizzano episodi singolari ed esperienze significative dell’internazionalismo: dalla guerra di Spagna alle lotte di liberazione nazionale, passando per le rivoluzioni che hanno segnato il XX secolo, il ruolo dei vari partiti comunisti, il panarabismo, il panafricanismo, ecc. o, più recentemente, lo zapatismo, l’alter-globalismo, le lotte dei migranti, le rivolte che hanno scosso gli anni 2010 – la maggior parte delle quali si sono espresse su scala transnazionale. È semplicemente impossibile riportare qui le fonti. Per la migliore letteratura sugli anni 2010, si può fare riferimento, tra l’altro, per le primavere arabe al lavoro di Asef Bayat, in particolare (2017), a Kim Moody (2017) per la nuova situazione delle lotte sindacali (con una forte attenzione agli Stati Uniti), a Veronica Gago per gli scioperi transfemministi (2021), ad Andreas Malm (2022) per i movimenti ecologisti, a Sue Clayton (2020) per l’attivismo innescato dalla cosiddetta crisi dei migranti in Europa e a Cedric Johnson (2023) per una critica immanente a BLM.
[2] Sebbene nel testo ricorrano alcuni nodi concettuali – come quelli tra globale, planetario e terrestre, intersezionalità e (ri)composizione, universalità e differenza – l’obiettivo delle tesi non consiste nell’approfondire tali dibattiti teorici (su cui torneremo a breve), ma nel fornire alcuni elementi di ragionamento per impostare una discussione politica sull’internazionalismo oggi.
[3] Per una brillante discussione dell’eredità dell’internazionalismo storico e della cosmopolitica, si veda Balibar (2022). Secondo Balibar, l’universalismo difeso dal primo risale alla figura del proletariato teorizzata da Karl Marx e trova nella lotta di classe la sua pietra angolare; l’universalismo difeso dal secondo, invece, ha in Kant il suo padre spirituale e trova nell’ospitalità dello straniero la sua incarnazione paradigmatica. Per Balilbar, nella misura in cui non si escludono a vicenda, le due tradizioni devono intensificare il dialogo e trovare il modo di articolarsi a vicenda. L’internazionalismo, infatti, può fornire una maggiore coerenza conflittuale e organizzativa; mentre la cosmopolitica può aiutare a sviluppare una maggiore sensibilità verso l’altro, e verso la dialettica di diversità e comunanza di cui è portatrice. L’evento pandemico, con il suo carico di contagiosità e mortalità, avrebbe poi reso ancora più pressante l’incontro tra questi due approcci. Tuttavia, la posizione di Balibar, per quanto originale e forte, non tiene in debito conto la gravità e la novità della crisi ecologica, limitandosi a un’analisi della pandemia.
[4] Come sostiene Perry Anderson (2002) in quello che è uno dei migliori articoli sul tema, qualsiasi analisi delle diverse esperienze che hanno segnato la storia – gloriosa e infame – dell’internazionalismo non può non prendere in considerazione le forme, le operazioni e le geografie del capitale ad esse coeve. L’articolo di Anderson è estremamente istruttivo e fonte di grande ispirazione, ma criticabile per almeno due motivi, i quali costituiscono il cuore teorico e politico dell’approccio sviluppato in queste pagine. In primo luogo, il filo conduttore della ricostruzione di Anderson è decisamente storicista e lineare: si parte dalla Prima Internazionale dei lavoratori, si prosegue con la Seconda Internazionale dei principali partiti socialisti e sindacati, si passa poi alla Terza Internazionale degli Stati comunisti, per arrivare all’alleanza tricontinentale delle lotte di liberazione anticoloniali. In secondo luogo, l’analisi di Anderson mira soprattutto ad analizzare le istituzioni dei movimenti rivoluzionari, adottando per lo più una prospettiva dall’alto verso il basso. Al contrario, alla stregua di queste tesi, è possibile immaginare un approccio che si ancori in una visione multilineare della storia, attenta alla produttività politica delle lotte autonome e alla loro circolazione dal basso.
Questo articolo è stato pubblicato su EuroNomade ed Effimera.