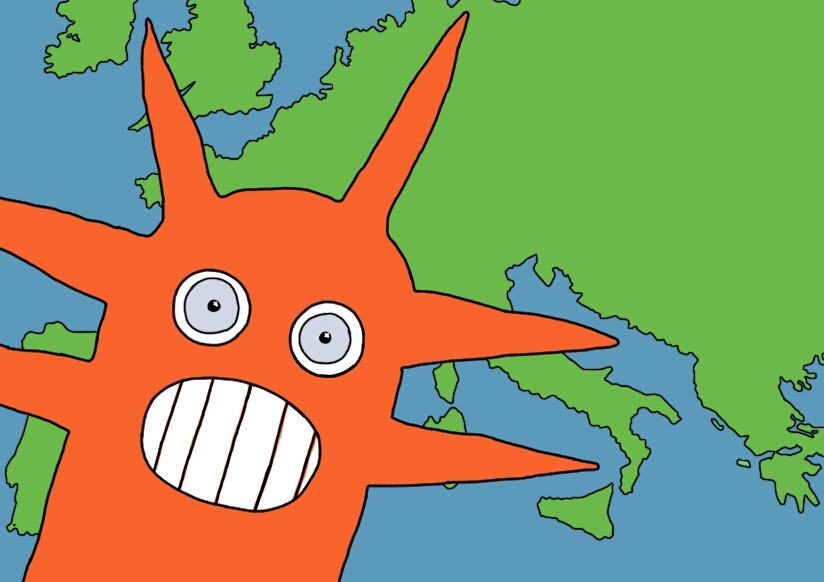di VERÓNICA GAGO, SANDRO MEZZADRA.
Realismo della potenza
Tanto in America Latina quanto in Europa la politica dell’autonomia è oggi al centro di vivaci discussioni. In questione è l’esigenza di riqualificare l’autonomia come criterio di organizzazione e azione eminentemente politica, criticando la sua definizione sia in termini puramente “sociali”, spesso associata a un’ostilità di principio nei confronti delle istituzioni, sia in termini “statici” (quando l’autonomia viene ridotta a una serie di principi immutabili e in fondo identitari). Tanto la proposta di un “realismo della potenza” avanzata in Argentina dall’Instituto de Investigación y Experimentación Política quanto il lavoro attorno al tema delle “istituzioni del comune” sviluppato in Italia dal collettivo Euronomade si collocano all’interno di questo orizzonte problematico, definito in una fitta rete di rapporti con esperienze maturate in altri luoghi sulle due sponde dell’Atlantico.
Sullo sfondo di queste discussioni ci sono ovviamente gli sviluppi delle lotte degli ultimi anni, e i rapporti che queste lotte hanno intrattenuto con il tema del “governo”. Si tratta di sviluppi molto diversi, in America Latina e in Europa. Le esperienze dei “governi progressisti” latinoamericani, contraddittoriamente radicate all’interno di lotte la cui circolazione a partire dalla fine degli anni Novanta ha assunto una scala continentale, hanno determinato trasformazioni profonde, che non si possono ignorare, nell’agenda politica, nelle strutture istituzionali e nello stesso tessuto sociale. In Europa, in particolare nei Paesi del Sud, le lotte si sono dispiegate in condizioni di dura crisi e a fronte di violenti programmi di austerity, e sono sembrate trovare soltanto di recente (con la vittoria di Syriza in Grecia e con la crescita di Podemos in Spagna) un pur difficile e contrastato sbocco politico.
In ogni caso, queste esperienze di lotta interpellano direttamente il concetto stesso di autonomia, lo sfidano a trasformarsi in un concetto strategico all’interno di un nuovo campo politico. Ci pare significativo, anche dal punto di vista della radicale trasformazione delle coordinate geopolitiche e geoeconomiche che caratterizza l’attuale fase della globalizzazione capitalistica, che in Europa si guardi spesso oggi, all’interno della sinistra, all’America Latina come a un “modello”, o comunque come a una fonte di “ispirazione”. La nostra prospettiva, tuttavia, si distingue da quelle maggiormente diffuse: non ci interessa ragionare sulle condizioni di una più o meno lineare importazione di “modelli” (e non crediamo d’altro canto che gli sviluppi latinoamericani degli ultimi anni abbiano “modelli” da offrire: piuttosto pongono e riqualificano problemi su cui si tratta di continuare a lavorare). Il nostro tentativo, coerentemente con lo stile di dialogo e confronto che ormai da molti anni cerchiamo di promuovere, è quello di produrre effetti di risonanza tra dinamiche, storie, esperienze, strutture anche significativamente eterogenee. Siamo infatti convinti che questi effetti di risonanza possano contribuire a meglio illuminare alcune questioni che, pur presentandosi in modo diverso in America Latina e in Europa, ci sembrano oggi cruciali dal punto di vista di una politica dell’autonomia: la maturità e la composizione delle lotte a fronte delle trasformazioni che caratterizzano il capitalismo contemporaneo e il modo in cui queste lotte investono direttamente la questione del potere. Potere e potenza: un tema classico che si ripropone oggi alla luce di nuove problematiche politiche, di nuove sfide, conquiste e dilemmi.
Parliamo di questione del potere sottolineando che essa al tempo stesso interseca ed eccede il problema del “governo”. Un governo “progressista” può certo contribuire a spostare in avanti i termini dello scontro sociale e politico, può assicurare specifiche conquiste e aprire nuovi spazi per la lotta di classe. Di per sé, tuttavia, occorre realisticamente riconoscere che un governo (un governo “nazionale”) non ha il potere sufficiente neppure per regolare in modo efficace e duraturo un capitalismo che si è riorganizzato attorno alla centralità della finanza e della rendita, privilegiando operazioni che in un nostro precedente articolo abbiamo definito come estrattive. Porre la questione del potere significa dunque per noi prendere seriamente e riqualificare il problema del governo, riconoscendo il ruolo positivo che singoli governi possono giocare (tanto più in una fase che a livello mondiale registra un nuovo protagonismo degli Stati nazionali come snodi cruciali per l’articolazione dei processi globali), ma al tempo stesso sottolineando la necessità di una duplice apertura: da una parte (“verso il basso”, per così dire) in direzione del consolidamento della politica dell’autonomia, di una rete di istituzioni e contropoteri capaci di contrastare il neoliberalismo sul terreno che con Foucault possiamo chiamare della “governamentalità”, della “condotta delle condotte”; dall’altra parte (“verso l’alto”) in direzione di processi di integrazione su scala regionale e transnazionale, nella prospettiva di quel governo conflittuale dell’interdipendenza che costituisce una condizione necessaria per il confronto con il capitale finanziario.
Porre in questi termini il problema del potere e del governo, riqualificare su questo terreno la politica dell’autonomia ci conduce del resto a riconsiderare criticamente una categoria che abbiamo molto usato in questi anni, anche perché si riferisce agli ambiti al cui interno si è svolta prioritariamente la nostra militanza politica: la categoria di movimenti sociali. In questo articolo proponiamo qualche elemento di bilancio a questo proposito, assumendo come riferimento lo sviluppo dei movimenti e le loro complesse relazioni con i governi “progressisti” in America Latina.
Cooptazione o conflitto?
Non è questo il luogo per ricostruire la genealogia della categoria di movimento sociale, che affonda le proprie radici nella storia della lotta di classe operaia nell’Europa del XIX secolo – e che risulta difficilmente comprensibile senza tenere presente la radicale sfida lanciata da Marx ed Engels con la loro definizione del comunismo come “movimento reale che abolisce lo stato di cose presente”. In America Latina, d’altra parte, questa genealogia dovrebbe essere ampliata per includervi una lunga storia di rivolte indigene e popolari, che hanno sfidato e arricchito lo stesso concetto di classe. Ci interessa qui piuttosto evidenziare come un insieme di movimenti e di lotte abbia materialmente costruito e formulato una sorta di “mandato” per politiche di segno opposto rispetto a quelle neoliberali che avevano caratterizzato in America Latina gli anni del “consenso di Washington”, determinando l’apertura di un piano istituzionale di negoziazione di determinate rivendicazioni e conquiste sociali. Non è possibile oggi affrontare il tema dei movimenti sociali nella congiuntura latinoamericana senza contemporaneamente porre il problema delle relazioni tra i movimenti e i governi “progressisti” che negli ultimi dieci anni si sono affermati in molti Paesi della regione. In questo senso, tuttavia, conviene sottolineare la specificità della congiuntura attuale: da una parte perché questa congiuntura necessariamente influenza il modo in cui si legge lo sviluppo dei movimenti a partire dall’inizio del secolo; dall’altra perché il momento presente è caratterizzato da una crisi di produttività politica dei governi “progressisti”, che costituisce una condizione essenziale delle riflessioni che proponiamo sugli stessi movimenti sociali.
Da questo punto di vista, la nostra analisi si distingue significativamente dalle letture, molto diffuse, che riducono le esperienze dei movimenti latinoamericani degli ultimi anni alla grande alternativa tra “conflitto e cooptazione”. Questa alternativa ha assunto come riferimento essenziale le politiche sociali “redistributive” e di fronteggiamento della povertà che sono state adottate in molti Paesi, con differenze anche significative ma all’interno di quello che si configura come un ciclo politico unitario: per chi ha parlato di un rapporto lineare di cooptazione, le politiche sociali ne sono state lo strumento privilegiato; per chi ha puntato su un rapporto organico (e altrettanto lineare) con i governi “popolari” queste stesse politiche hanno rappresentato la conquista fondamentale degli ultimi anni. I limiti di entrambe le ipotesi ci sembrano evidenti. Dal primo punto di vista si perde completamente di vista la ricchezza di relazioni e sperimentazioni che sul terreno delle politiche sociali sono state pur contraddittoriamente messe in campo, mentre dal secondo resta oscurata la qualità dello sviluppo da cui derivano le risorse oggetto di (più o meno limitata e parziale) redistribuzione – ovvero l’insieme delle condizioni da cui quest’ultima materialmente dipende. Essenziale, in questo senso, diventa dunque una riflessione sul modello di sviluppo che si è affermato a livello regionale negli ultimi anni, sulla realtà e sulla natura del capitalismo oggi in America Latina.
Riassumiamo da questo punto di vista quanto abbiamo sostenuto in un nostro precedente articolo, che già abbiamo menzionato: mentre le retoriche dei governi “progressisti” puntano sulla riattivazione di un immaginario “neo-sviluppista”, e dunque sulla continuità con progetti storici di sviluppo economico e politico fondati sulla sostituzione delle importazioni attraverso politiche di industrializzazione, il modello che si è affermato in America Latina in questi anni ha come propria base l’egemonia della rendita e persistenti processi di finanziarizzazione. Questo vale in primo luogo per la rendita “estrattiva” in senso proprio che, attraverso l’intensificazione di attività minerarie ed estrattive (tra cui vanno fatte rientrare colture come la soia), offre in buona misura le risorse per le stesse politiche redistributive. Ma vale anche per la dipendenza (divenuta evidente negli ultimi anni con il rallentamento della domanda asiatica) dalle dinamiche finanziarie e monetarie globali che governano tanto i prezzi delle materie prime quanto i regimi di scambio. E vale per processi, sempre più evidenti in molti Paesi latinoamericani, di penetrazione della finanza all’interno delle “economie popolari”, in particolare attraverso un’estensione senza precedenti del credito al consumo.
L’ipotesi che ci interessa sviluppare è che la specificità delle forme di gestione sociale dei governi “progressisti” latinoamericani consista precisamente nel tentativo di articolare queste diverse figure della rendita, e in particolare la rendita finanziaria, con le condizioni aperte dalla rivolta “plebea”, la cui vitalità viene così tradotta sul terreno dell’economia politica. Questa formula ci permette di comprendere in tutta la loro costitutiva ambivalenza materiale (considerandole come un essenziale “campo di lotta”) le politiche sociali redistributive degli ultimi anni. Al tempo stesso, apre la possibilità di un uso delle categorie di estrazione ed “estrattivismo” sganciato dalla semplice denuncia della “ri-primarizzazione” delle economie latinoamericane. Queste categorie si prestano in modo particolare a indicare il modo in cui il capitale finanziario presidia le “cuciture”, le connessioni e le articolazioni di quella cooperazione sociale profondamente eterogenea che costituisce la base dell’estrazione di plusvalore all’interno di economie che continuano a presentarsi, come “barocche” (nel senso che questo termine ha assunto negli ultimi anni all’interno dei dibattiti latinoamericani, a partire dal fondamentale lavoro di Bolívar Echeverría). Il “neo-sviluppismo” si combina qui in forme inedite con il “neo-liberalismo”, attraverso sperimentazioni che, come quelle legate alla finanziarizzazione delle economie e dei consumi popolari, prendono avvio da spazi e soggetti tradizionalmente considerati “periferici” (dal punto di vista della norma salariale, della struttura urbana e della regolazione giuridica) per riverberare i propri effetti sulla società nel suo complesso.
Interpretate in questo modo, le categorie di estrazione ed estrattivismo offrono da una parte un punto di vista particolare da cui leggere le trasformazioni, la composizione e la stessa produttività del lavoro in America Latina, mentre dall’altra consentono di evidenziare la persistente rilevanza dell’inserimento della regione nel mercato globale, e in particolare dell’intensificazione negli ultimi anni delle relazioni con la Cina. La stessa forma-Stato è completamente immersa nella nuova costellazione del capitalismo a cui queste categorie fanno riferimento: e l’azione di ogni governo è sottoposta a specifici limiti e a specifiche compatibilità, che si affermano in forme diverse rispetto a quelle che hanno caratterizzato la storia dei rapporti tra Stato e capitale industriale. A noi pare che il mancato riconoscimento di questa condizione, di questi limiti e di queste compatibilità sia all’origine della crisi che stanno affrontando molti governi “progressisti” in America Latina, anche al di là delle recenti affermazioni elettorali di alcuni di essi.
È necessario formulare una diagnosi per quanto possibile precisa in questo senso. Il rallentamento dei processi di integrazione regionale, evidente negli ultimi anni, non ha semplicemente indebolito i singoli governi dal punto di vista del confronto con le dinamiche globali. Come mostrano in modo particolare i casi di Venezuela ed Ecuador, il conseguente ripiegamento sulla dimensione nazionale si è anche tradotto in una chiusura di quegli spazi di conflitto e negoziazione, di reciproco incitamento tra azione di governo e mobilitazioni sociali, da cui i processi di trasformazione avevano derivato la propria forza e la propria efficacia. In Brasile, il rifiuto del PT di cogliere nelle sollevazioni di giugno del 2013 una formidabile occasione per riqualificare l’azione e il programma di governo ha determinato il ricorso a politiche ormai esplicitamente neoliberali per far fronte alla crisi del modello che si era affermato negli anni di Lula. In Argentina, nel crepuscolo del kirchnerismo e in attesa delle elezioni di ottobre, una nuova destra si è presentata sulla scena, in particolare politicizzando quella “questione della sicurezza” che su scala regionale costituisce uno dei vettori fondamentali attorno a cui si sta ridefinendo l’identità di un nuovo “partito dell’ordine” – ovvero di una “classe media” (di una borghesia) aggressivamente ostile a ogni processo di democratizzazione che pretenda di incidere direttamente sulla questione della povertà.
La violenza della rendita e dell’estrazione, nelle molteplici forme in cui si manifesta tanto nei territori rurali quanto in quelli metropolitani, è al tempo stesso all’origine di un gran numero di nuovi conflitti sociali in molti Paesi latinoamericani. Facciamo qualche esempio: le mobilitazioni contro l’intensificazione dell’attività mineraria in Perù, i conflitti in Bolivia e in Ecuador attorno all’avanzamento di progetti di “sviluppo” in territorio indigeno (Tipnis e Yasuní), gli scontri attorno alle occupazioni di terre in Argentina, al saccheggio di intere comunità e alle privatizzazioni in Messico. Sono conflitti che i governi, quando non intervengono con modalità puramente repressive (come accade in Perù e in Messico), si guardano bene dal cogliere come segni dei limiti delle loro stesse politiche di “sviluppo” e di “inclusione sociale”. Gli stessi “movimenti sociali”, e questo è un punto molto importante per il nostro discorso, sono del resto continuamente spiazzati dalle forme in cui questi conflitti si manifestano, delegando spesso alla Chiesa un intervento che, con il pontificato di Bergoglio, si è fatto sempre più insistente, assumendo forme che meriterebbero un’analisi specifica.
A noi pare che, a fronte del sostanziale esaurimento della produttività politica del ciclo dei governi “progressisti”, sia questo il terreno privilegiato per il rilancio di una politica dell’autonomia in America Latina. Più che guardare ai “movimenti sociali” esistenti, che possono ovviamente giocare un ruolo in questo processo ma difficilmente ne saranno i principali protagonisti, si tratta di ripartire dagli elementi di “eccedenza” che ne hanno caratterizzato l’azione negli scorsi anni e che ci proponiamo di fare emergere nelle pagine seguenti. Sono precisamente questi elementi a rimanere spesso oscurati all’interno delle concettualizzazioni più diffuse dei movimenti sociali in America Latina. I sedimenti materiali dell’azione dei movimenti sono tuttavia ben presenti: una nuova politica dell’autonomia non può che assumerli come base per immaginare un insieme di rotture della continuità di un processo che va nel senso della stabilizzazione di un nuovo capitalismo di natura fondamentalmente “estrattiva”. E contemporaneamente non possono che partire da qui nuove sperimentazioni su terreno della costruzione di istituti di contro-potere, capaci anche di articolarsi in modo aperto con processi di governo rinnovati nella loro natura democratica.
Il continente dei movimenti sociali
Riprendendo direttamente la questione dei movimenti sociali, ci sembra importante sottolineare preliminarmente come il dibattito attorno a questa categoria (ma anche all’interno degli stessi movimenti) sia oggi profondamente condizionato dalla stagione di studi (sociologici e politologici) che si è aperta con l’emergere tra gli anni Settanta e Ottanta in Europa e negli Stati Uniti, e verso la fine del decennio successivo in America Latina, di quelli che sono stati chiamati “nuovi movimenti sociali”.
Indipendentemente dall’importanza e dalla ricchezza di questi studi, vorremmo far notare due aspetti che ci sembrano problematici nel loro sviluppo. In primo luogo, concentrandosi su movimenti sociali il cui carattere di “novità” è essenzialmente identificato con la loro distanza dal movimento operaio, gli studiosi dei movimenti sociali hanno progressivamente escluso dal loro campo di ricerca la questione del lavoro e del suo rapporto con il capitale (proprio in un momento in cui il rapporto tra lavoro e capitale cominciava a trasformarsi radicalmente, andando oltre la sua forma tradizionale, attorno a cui il movimento operaio si era sviluppato). E hanno privilegiato i temi dell’“identità”, della cultura, dei “repertori” e delle risorse simboliche per l’azione collettiva. In secondo luogo, hanno contribuito a consolidare l’immagine di una “divisione del lavoro” tra movimenti sociali e governi secondo la quale (per semplificare) ai primi spetta l’organizzazione di campagne più o meno prolungate e strutturate per affermare specifiche “rivendicazioni” che sono poi i governi ad accogliere o meno (con un ruolo di mediazione più o meno significativo riconosciuto ai partiti).
Tenendo a mente questi aspetti, che ci appaiono come limiti per lo sviluppo di una politica dell’autonomia all’altezza delle sfide contemporanee, presentiamo di seguito alcuni spunti analitici e alcune tesi politiche a proposito dello sviluppo dei movimenti in America Latina nel corso degli ultimi anni. Per certi aspetti, l’America Latina può essere considerata come il “continente dei movimenti sociali” (e non a caso la letteratura sul tema, tanto quella accademica quanto quella prodotta dall’interno degli stessi movimenti, è letteralmente sconfinata). A noi pare tuttavia che proprio lo sviluppo dei movimenti e delle lotte in America Latina presenti una serie di elementi e caratteristiche che sfidano il linguaggio concettuale e le tassonomie elaborate dagli studi sui movimenti a cui ci siamo sinteticamente riferiti. E anche da questo punto di vista, siamo convinti che non manchino le “risonanze” con altri contesti, a partire da quello europeo. È una questione che non affrontiamo direttamente nell’articolo, ma che teniamo sempre sullo sfondo del nostro discorso.
È bene in ogni caso sottolineare che in America Latina, all’inizio del nuovo secolo, la presenza e il protagonismo dei movimenti sociali hanno effettivamente determinato una svolta epocale e un cambiamento radicale nel vocabolario e nella grammatica della politica. La forza dei movimenti si è imposta chiaramente come il più efficace surrogato – e come la critica pratica – della forma partito. In alcuni casi, al tempo stesso, i movimenti sono giunti a rinnovare profondamente i partiti esistenti (come ad esempio il PT in Brasile) o a promuovere la costruzione di “nuovi strumenti elettorali” (come è accaduto alle origini del MAS in Bolivia). Diversi aspetti hanno giocato un ruolo chiave in queste forme di intervento dei movimenti: in primo luogo, l’idea del “sociale” (sostantivato) come forza direttamente “politica”, dall’interno di lotte e pratiche che attaccavano la “corruzione” delle strutture istituzionali esistenti (tanto per via dei loro legami con le dittature dei decenni precedenti quanto per via delle trasformazioni determinate dal neoliberalismo negli anni del “consenso di Washington”) e prefiguravano dunque orizzonti costituenti. D’altro canto, se è pur vero che i movimenti di inizio secolo si sono presentati e sono stati diffusamente percepiti come “nuovi”, non mancavano certo molteplici risonanze con il passato: nel momento stesso in cui i movimenti procedevano a una vera e propria resa dei conti con le tradizionali strutture organizzative (in particolare con i sindacati, oltre che con i partiti), riprendevano e sviluppavano linee di politica radicale che, pur con tutte le differenze programmatiche che venivano opportunamente sottolineate, si ricollegavano in vari modi alle esperienze di lotta rivoluzionaria degli anni Sessanta e Settanta.
La questione del potere non era certo assente nelle pratiche e nei discorsi politici dei movimenti: il modo in cui veniva articolata era tuttavia essenzialmente “critico”, a partire dallo “spiazzamento” di ogni politica associata alla centralità dello Stato come suo luogo privilegiato, dalla critica della rappresentanza come logica fondamentale della partecipazione democratica e da un sostanziale scetticismo nei confronti del diritto inteso come cristallizzazione di conquiste sociali per la maggioranza della popolazione. Quel che ci sembra importante sottolineare, tuttavia, è che i movimenti di inizio secolo in America Latina esprimevano al tempo stesso le trasformazioni e le difficoltà crescenti incontrate da quelle forme di “cittadinanza sindacale” che avevano articolato l’espressione della forza operaia nei decenni precedenti. Lungi dall’essersi sviluppati al di fuori di queste trasformazioni e di una più generale riorganizzazione del mondo del lavoro (collegata alla scomposizione delle sue forme e figure tradizionali), i movimenti ne hanno offerto una prima espressione e interpretazione conflittuale.
Considerati sotto questo angolo visuale i movimenti hanno da una parte reagito ai processi che, nel segno dell’egemonia neoliberale, delle privatizzazioni e della deregolamentazione, avevano reso sempre più instabile e precario il lavoro; dall’altra, hanno determinato un’apertura verso forme di politicizzazione, esperienze e figure soggettive che non avevano nel lavoro il proprio riferimento fondamentale e che tuttavia, nel contesto dei medesimi processi, erano state progressivamente investite e messe a valore dal capitalismo.
Le mobilitazioni per i “diritti umani” (in particolare a proposito del recente passato delle dittature), lo sviluppo di nuovi movimenti contadini per il “diritto alla terra”, le lotte all’interno dei quartieri per l’appropriazione di risorse urbane e i movimenti dei disoccupati – per richiamare quattro casi emblematici di movimenti che si sono manifestati in forme diverse ma hanno caratterizzato gli sviluppi regionali nel loro complesso – sono esempi di esperienze che hanno radicalmente ampliato l’orizzonte politico delle lotte, aprendo nuovi spazi e prospettive per quella che nel dibattito latinoamericano viene spesso definita “democratizzazione plebea” (è un punto su cui torneremo: basti qui aggiungere che il riferimento fondamentale per questa definizione è il lavoro collettivo svolto in Bolivia fin dall’inizio degli anni 2000 dal gruppo Comuna). All’incrocio tra queste dinamiche ha cominciato a manifestarsi una politicizzazione conflittuale della cooperazione sociale, della produzione degli spazi e delle risorse fondamentali per l’organizzazione della vita comune, di cui occorre nuovamente sottolineare il rapporto con le trasformazioni che si erano prodotte – sullo stesso terreno del lavoro – nel corso degli anni dell’egemonia neoliberale.
Gli sviluppi di questi e altri movimenti si sono del resto incrociati all’interno di un processo che può essere ricostruito retrospettivamente nei termini della continuità di una dinamica insurrezionale di tipo nuovo. È opportuno distinguere analiticamente questo processo dallo sviluppo dei singoli movimenti sociali. Il 1989, l’anno dell’ultima grande offensiva militare della guerriglia in Salvador (che, è importante sottolineare, non si concluse con una sconfitta), è anche l’anno della grande insurrezione dei poveri di Caracas contro le politiche del governo di Carlos Andrés Pérez, l’anno del Caracazo. È sufficiente ricordare i successivi levantamientos indigeni in Ecuador (a partire da quello del 1990), la sollevazione del 19 e 20 dicembre 2001 in Argentina, la “guerra dell’acqua” a Cochabamba nel 2000 e la rivolta di El Alto e della sierra contro la privatizzazione del gas naturale nel 2003 in Bolivia, per dare conto della continuità e della circolazione su scala regionale di un movimento insurrezionale che è giunto a decretare la fine della legittimità del neoliberalismo. All’interno di questo movimento va fatta rientrare la stessa irruzione nello scenario politico messicano e globale dell’EZLN nel 1994, non solo per la sua grande risonanza ma anche per il protagonismo indigeno, che costituisce un ulteriore elemento essenziale tanto dei movimenti sociali latinoamericani degli ultimi anni quanto della composizione della dinamica insurrezionale di tipo nuovo di cui stiamo parlando.
Conviene ripeterlo: è stata questa dinamica insurrezionale ad aprire gli spazi al cui interno si sono sviluppate le esperienze dei nuovi governi “progressisti”. Questi ultimi, se non hanno certo preteso di “rappresentarla”, ne hanno tuttavia – almeno in una prima fase – riconosciuto la potenza accettando il “potere di veto” dei movimenti, esercitato nelle strade e nelle piazze rispetto a ogni “ritorno” alle politiche neoliberali. I movimenti sono così divenuti un riferimento essenziale per la legittimità dei nuovi governi “progressisti”, che hanno ripreso più o meno selettivamente un’agenda politica forgiata all’interno di lotte e di resistenze che, oltre a destituire di legittimità il neoliberalismo, erano giunte ad aprire nuovi spazi politici programmatici. In Paesi come l’Ecuador e la Bolivia, questo “potere di veto” ha profondamente condizionato gli stessi processi costituenti e ha trovato significativi riconoscimenti nelle nuove carte costituzionali approvate nel 2008 e nel 2009.
Tessiture
Questa combinazione di insorgenza e “potere di veto” ci pare un primo elemento che ha caratterizzato l’azione dei movimenti in America Latina a partire dalla fine degli anni Novanta e che si pone quantomeno in tensione con le immagini e le concettualizzazioni più diffuse dei “movimenti sociali”. Ne vorremmo segnalare almeno un secondo: il radicamento dei più significativi tra questi movimenti (da quelli indigeni a quelli dei poveri urbani, da quelli dei disoccupati alle esperienze delle “imprese recuperate”, da quelli dei contadini a quelli delle “minoranze”) all’interno di un tessuto estremamente ricco, denso ed eterogeneo di pratiche sociali quotidiane, su cui si fonda la riproduzione materiale della vita di milioni di donne e uomini. Il dibattito e le stesse iniziative di molti governi latinoamericani sui temi delle “economie cooperative”, “popolari”, “sociali”, “solidali” (definizioni che fanno spesso riferimento a interpretazioni e proposte anche significativamente diverse) registrano l’enorme importanza di questo tessuto di pratiche quotidiane nella produzione e riproduzione della vita collettiva. Anche a questo proposito, del resto, è opportuno segnalare che le formule appena menzionate sono state in vari modi recepite dalle Costituzioni di Bolivia (art. 307), Ecuador (art. 283) e Venezuela (art. 70).
Proprio per via di questa “immersione” nella quotidianità, la trama di lotte che abbiamo sinteticamente richiamato non può essere facilmente ridotta alla formulazione di un insieme di “domande” che in un secondo tempo sarebbero state soddisfatte in forme più o meno compiute da specifiche politiche pubbliche. Si tratta certo di una lettura diffusa in America Latina, che può anche trovare – su un piano descrittivo – significative verifiche nelle esperienze degli ultimi anni. Quel che però va perduto in questa lettura sono i momenti di scarto, “sconfinamento”, rottura ed eccesso – ovvero la specifica produttività politica che a partire da questo tessuto quotidiano di pratiche ha consentito ai movimenti di aprire e problematizzare una serie di questioni e di terreni di lotta non riducibili a specifiche “domande”. Quello a cui ci riferiamo è un processo di conquista di potere non semplicemente in termini “democratici”, ma piuttosto direttamente incardinato sul terreno produttivo: o, detto in altri termini, un processo che disloca la questione democratica sul terreno della produzione.
E’ la sedimentazione materiale di queste pratiche che ci interessa sottolineare: esperienze di costruzione e gestione collettiva di infrastrutture urbane, attraverso vere e proprie reti “subalterne”, il rifiuto di ogni gestione “miserabilista” del tema del diritto al reddito e al lavoro, la politicizzazione di forme di attività economica che vanno oltre il lavoro salariato (dalle molteplici esperienze di “imprese recuperate” alle forme altrettanto molteplici di mobilitazione e sindacalizzazione di lavoratori e lavoratrici nei settori “informali”), la critica della stessa nozione di “minoranza” (riconosciuta dal multiculturalismo “neoliberale” in molti Paesi latinoamericani) a partire da trame espansive di relazioni che hanno riaperto in modo originale prospettive di costruzione politica “maggioritaria” oltre e contro ogni confinamento “etnico”, nuovi incroci tra tematiche ambientaliste, lotte per il “comune”, diritto alla terra, alla casa e “sovranità alimentare”. Questo insieme di esperienze si è sviluppato trasversalmente rispetto all’azione di singoli movimenti sociali, attraverso molteplici risonanze che hanno contribuito a rinnovare positivamente la scala delle lotte e il loro stesso rapporto con il territorio.
I paesaggi metropolitani ne sono usciti profondamente trasformati in molti Paesi latinoamericani, così come d’altra parte i rapporti tra spazi urbani, suburbani e rurali. Sul punto di congiunzione tra dinamiche politiche di lotta ed “economie popolari” si è andata formando e consolidando una trama di soggettività, di modi di vita e di infrastrutture materiali che sfugge tanto agli immaginari e ai linguaggi dei tradizionali “movimenti sociali” quanto alle politiche di “sviluppo” e “inclusione sociale” dei nuovi governi “progressisti”. E’ uno scarto che va valorizzato tanto dal punto di vista analitico quanto dal punto di vista politico: non perché apra prospettive su mondi “idilliaci”, che possano essere assunti come modelli. Ma piuttosto perché consente di vedere come processi di forte politicizzazione abbiano investito in America Latina sia le forme di organizzazione e regolazione della vita e della cooperazione sociale (dando luogo a contraddittorie e inedite sperimentazioni “istituzionali” che si collocano oltre la grande divisione tra pubblico e privato) sia esperienze e figure del lavoro diverse da quello salariato classico, a partire dal protagonismo delle donne, dei “disoccupati” e dei migranti. Queste esperienze e figure del lavoro, lungi dal presentarsi come “residui” destinati a essere riassorbiti dalle politiche di “sviluppo”, si sono moltiplicate e trasformate negli ultimi anni, e costringono a ripensare tanto il concetto stesso di lavoro quanto quello di sfruttamento.
Inedite sperimentazioni “istituzionali” (che hanno spesso messo in gioco e ancora una volta radicalmente trasformato preesistenti strutture “comunitarie”) e una necessaria estensione del concetto di lavoro emergono nitidamente come assi fondamentali delle dinamiche politiche latinoamericane nel momento in cui si assume angolo visuale quello che abbiamo definito il punto di congiunzione tra le lotte e le “economie popolari”. È opportuno ripeterlo: le grandi questioni che ruotano attorno a questi due assi rimangono sostanzialmente esterne al campo di visibilità politica organizzato dagli stessi governi “progressisti”, e al tempo stesso alludono a forme nuove, spesso estremamente violente, di conflittualità sociale che si sviluppano secondo logiche diverse da quelle familiari ai “movimenti” intesi tradizionalmente. È su queste questioni e all’interno di questa conflittualità sociale, tuttavia, che si giocano sia la possibilità di riqualificare una prospettiva rivoluzionaria, di rottura, sia – e non sembri un paradosso – la stessa efficacia di politiche riformiste radicali ed espansive.
Laboratori della soggettività
Abbiamo fin qui indicato alcune caratteristiche dei movimenti latinoamericani degli ultimi anni che ci sembrano eccedere il linguaggio concettuale e le tassonomie elaborate dagli studi sui movimenti sociali. Sono caratteristiche che possiamo riassumere e definire dal punto di vista delle coordinate temporali dell’azione dei movimenti. Da una parte abbiamo sottolineato il rilievo di una dinamica insurrezionale di tipo nuovo, che si è tradotta in un “potere di veto” la cui azione si è prolungata ben oltre la specifica temporalità degli eventi che la hanno scandita. Dall’altra parte ci è sembrato importante richiamare l’attenzione sul radicamento dei movimenti latinoamericani all’interno di un denso ed eterogeneo tessuto di pratiche sociali quotidiane, la cui temporalità si presenta come del tutto diversa rispetto a quella di singole campagne e dell’elaborazione di specifiche piattaforme rivendicative: è all’interno di questo tessuto di pratiche quotidiane, piuttosto, che prendono contraddittoriamente forma quelli che Raquel Gutiérrez Aguilar ha definito nuovi “principi operativi” di organizzazione comune della cooperazione sociale. Queste temporalità eterogenee, la cui coniugazione dà luogo a un vero e proprio peculiare ritmo politico, riorganizzano le stesse coordinate spaziali all’interno delle quali si coopera, si lotta e si sperimentano nuove forme di organizzazione sociale. Tradizionali quartieri operai, ad esempio, ne sono usciti radicalmente trasformati, riorganizzati attraverso l’azione di comitati e assemblee popolari che ha accompagnato l’occupazione, la reinvenzione e la destinazione ad attività produttive di tipo nuovo di fabbriche o miniere chiuse e abbandonate dalla proprietà.
Considerate congiuntamente, queste caratteristiche dell’azione e della composizione dei movimenti rinviano a processi e a esperienze che pongono sfide radicali alle modalità consolidate con cui in America Latina è stata pensata e organizzata la soggettività politica – per quel che riguarda non solo il partito e il sindacato nelle tradizioni della sinistra, ma anche le diverse combinazioni di nazionalismo, “sviluppo” e populismo che hanno preso forma nella seconda metà del Novecento in vari Paesi. Il caso della Bolivia è da questo punto di vista per molti versi esemplare. A partire dalla fine degli anni Novanta, il ritmo e la continuità della rivolta indigena quechua-aymara hanno qui assunto caratteri letteralmente incontenibili, poggiando sulla riattivazione di strutture comunitarie e di una lunga storia di resistenza anti-coloniale e riproponendo, come ha ad esempio mostrato Sinclair Thomson, una problematica antica: quella dell’autogoverno indigeno.
La rivolta indigena – che anche in altri Paesi latinoamericani ha determinato materialmente la riapertura degli archivi coloniali – non ha soltanto giocato un ruolo fondamentale nel decretare la fine del progetto neoliberale in Bolivia. Ha anche investito e travolto con violenza gerarchie, strutture economiche, politiche e sociali sedimentate all’interno di una storia secolare segnata da colonialismo e razzismo. Così facendo, al tempo stesso, ha modificato in profondità quelle che Luis Tapia ha chiamato le “strutture della ribellione”, facendo irruzione in quel “campo nazional-popolare” che si era definito a partire dalla Rivoluzione del 1952 e inaugurando un momento che è stato definito attraverso la formula “orizzonte popolare-comunitario”. L’uso che si è fatto in questi anni in Bolivia del concetto di potenza o rivolta plebea, spesso combinato con un riferimento del tutto peculiare al termine moltitudine, intende sottolineare la forza e la produttività politica di questa irruzione – ovvero dell’irruzione nel campo della politica di esperienze, linguaggi, soggettività che ne erano stati storicamente esclusi.
Si può certo ritenere che, sotto il profilo formale, l’accento posto dalla nuova Costituzione boliviana sulla molteplicità di “nazioni” e “popoli” che “congiuntamente costituiscono il popolo boliviano” (art. 3) esprima un riconoscimento della potenza e della produttività politica della rivolta “plebea”. Non va tuttavia sottovalutato il rischio che questo riferimento si riduca a un piano meramente simbolico ed “emblematico”. Silvia Rivera Cusicanqui sottolinea del resto il carattere problematico della stessa definizione di popoli “originari”, che finisce per assegnare gli indigeni o direttamente ai territori “rurali” o comunque a un prototipo chiaramente “identificabile”, e immediatamente “disponibile” per essere recuperato all’interno di un progetto di taglio eminentemente statalista. Al tempo stesso, occorre riconoscere che il problema così posto deve essere svolto nella continuità di un processo costituente capace di assumere quella rivolta come principio espansivo di apertura e innovazione tanto sul terreno delle istituzioni e del governo quanto sul terreno della formazione e dell’espressione della soggettività politica. È proprio sotto questo profilo che negli ultimi anni, non solo in Bolivia ma anche in altre esperienze latinoamericane, si sono determinati una serie di blocchi, fino a mettere in discussione la produttività politica del ciclo dei nuovi governi “progressisti”.
È d’altro canto importante mettere in evidenza il fatto che l’uso del termine “plebeo” non è qui in alcun modo collegato a un’apologia di condizioni di “marginalità” o di “esteriorità” rispetto alla modernità: al contrario si fonda sulla consapevolezza che quella che già negli anni Ottanta del Novecento il sociologo boliviano René Zavaleta Mercado definiva con la formula sociedad abigarrada (ovvero una società caratterizzata da radicale eterogeneità) è stata violentemente investita dai processi di valorizzazione e accumulazione del capitale nell’età neoliberale e si presenta oggi come essenziale forza produttiva. La categoria di sociedad abigarrada mette oggi in tensione l’“orizzonte popolare-comunitario” con il ritorno di un immaginario “neo-sviluppista” e pone in discussione la possibilità stessa di una chiusura dell’intero processo di trasformazione attorno al momento della decisione statuale e alla retorica della sovranità nazionale. Ci sembra che questo sia un punto chiave per l’intera regione latinoamericana.
In ogni caso, è all’interno di questo campo di tensioni che il “comunitario” si flessibilizza e si articola in una serie di tecnologie popolari, si manifesta in una molteplicità di istanze organizzative e si declina come spazio trasversale di cooperazione, capace di combinare temporalità e spazi profondamente eterogenei. Parlando di una “estensione” dei movimenti sociali, di una incorporazione delle loro premesse all’interno del tessuto delle “economie popolari”, intendiamo riferirci alla materialità di un insieme di dispositivi di gestione urbana, di costruzione di criteri di autorità sui territori, di coordinamento di reti produttive e commerciali transnazionali “dal basso”, che sono tuttavia ben lungi dal porsi come spazi immediatamente “alternativi”, “solidali”, o – in modo ancor più complesso – “autonomi”. Si tratta precisamente di “economie barocche”, nel senso che articolano, all’interno delle metropoli latinoamericane profondamente eterogenee, un insieme di “modalità del fare”, di forme di negoziazione, di lavoro, di processi di conquista di spazio e potere che non sono esenti – e da qui deriva la loro forza espansiva – da una ambivalenza costitutiva: una molteplicità di “micro-economie proletarie” e “illegalismi popolari” si presenta qui intrecciata con nuovi processi di articolazione con le istituzioni e di gestione delle stesse risorse statali.
Campi di lotta: l’autonomia in movimento
Crediamo che appaiano a questo punto più chiare le ragioni per cui abbiamo sottolineato la necessità di andare oltre l’alternativa tra “conflitto” e “cooptazione” per definire i rapporti tra movimenti e governi “progressisti” in America Latina. Ci pare che questa alternativa corrisponda a una “ragione governamentale” molto tradizionale, rispetto a cui i “movimenti sociali” si identificano con specifici attori, in qualche modo già costituiti, e rispetto a cui sono già date le modalità possibili di rapporto: il conflitto o la cooptazione, appunto. Totalmente impensata, in questa alternativa, rimane la questione (a cui hanno ad esempio alluso potentemente tanto il movimento del giugno 2013 in Brasile quanto il lungo ciclo di rivolte studentesche in Cile tra il 2011 e il 2013) di una politicizzazione radicale delle condizioni prodotte dall’azione degli stessi governi “progressisti” – in grado di tagliare trasversalmente la distribuzione delle parti tra governi e movimenti. E il “governo”, in particolare, continua a essere pensato più come una “cosa” che come un processo, come un insieme di rapporti in cui la politica dell’autonomia, nella sua capacità di dotarsi di momenti istituzionali radicati conflittualmente nella cooperazione sociale, funzioni come momento costitutivo di una rinnovata potenza della stessa azione di governo.
La stessa teoria di Ernesto Laclau della “ragione populista” e la sua riformulazione del concetto di egemonia (avviata all’inizio degli anni Ottanta non casualmente dall’interno del dibattito sui “nuovi movimenti sociali”) possono essere considerate come espressioni teoriche molto sofisticate della riduzione dei movimenti sociali a categoria “governamentale”, nel senso appena indicato. Nella prospettiva di Laclau, che ci interessa qui discutere in primo luogo per l’influenza che ha esercitato all’interno di alcuni settori dei governi “progressisti” latinoamericani, i movimenti risultano certo valorizzati per le “domande sociali” che esprimono: ma il momento propriamente politico dell’“articolazione” di queste domande eterogenee, attraverso la produzione di “catene equivalenziali”, è riaffermato (e congelato) nella sua autonomia, di pertinenza di soggetti come il partito e lo Stato. Anche nell’esperienza spagnola di Podemos, pur così ricca e importante, il riferimento alla teoria di Laclau è del resto spesso associato a un’enfasi sull’“autonomia del politico” che finisce per riproporre la centralità di un’immagine del tutto tradizionale dello Stato, del popolo e della “patria”. Quel che ci domandiamo, molto semplicemente e “realisticamente”, è se quest’immagine sia adeguata alle sfide politiche di fronte a cui oggi ci troviamo.
In America Latina lo Stato è oggi certamente divenuto, per riprendere il titolo di un libro curato nel 2010 da Álvaro García Linera, un “campo di lotta”. A noi pare tuttavia che proprio per via dei processi che hanno contribuito all’emergere di questo campo di lotta, lo Stato si presenti oggi in una veste piuttosto diversa da quella celebrata dalle tradizionali teorie moderne dello Stato. È attraversato e lacerato da processi globali che ne pongono in discussione la stessa figura unitaria, è posto sotto pressione da un regime di accumulazione capitalistica basato sulla finanziarizzazione e sulla rendita, ed è al tempo stesso conteso da movimenti popolari che in circostanze specifiche sono riusciti a cristallizzare al suo interno contraddizioni e momenti di contropotere. La conquista del governo, inteso nel senso tradizionale del termine, può certo rappresentare un momento di grande importanza nella costruzione di una strategia contro-egemonica e dallo stesso punto di vista di una nuova politica dell’autonomia. Nella misura in cui lo Stato viene immaginato secondo forme che sono distanti da quello che lo Stato è effettivamente divenuto, la stessa azione dei governi “progressisti” rischia tuttavia di essere svuotata di efficacia. Puntando semplicemente al rafforzamento dello Stato, a ri-centrare attorno ad esso l’intero processo politico, si può ottenere qualche provvisorio vantaggio sul terreno della retorica politica e magari della stessa competizione elettorale. Ma è questione di realismo riconoscere che non si contribuisce a costruire quel potere che è necessario per sostenere nel medio periodo un processo di trasformazione: è quel che si comincia a vedere chiaramente in diversi Paesi latinoamericani.
La fenomenologia dell’estrazione che abbiamo sinteticamente presentato all’inizio di questo articolo (a partire da un ampliamento della nozione di “estrattivismo”) punta a mettere in evidenza la complessità del capitalismo contemporaneo in America Latina e, contemporaneamente, il riconoscimento (in particolare dal punto di vista dei processi di finanziarizzazione) della potenza produttiva di quella trama determinata dall’incrocio di “economie popolari” e dinamiche politiche di lotta su cui ci siamo successivamente soffermati. Questa trama, è bene sottolinearlo ancora una volta, pone delle sfide radicali alla stessa nozione di autonomia. Indica tuttavia un terreno fondamentale su cui si giocano le resistenze ai modi in cui il neoliberalismo si riproduce come comando politico e norma estrattiva, e su cui si misura anche l’efficacia dei “principi operativi del comune” che alimentano la cooperazione sociale. Parlare di un “realismo della potenza” e di “istituzioni del comune” impone di assumere questo nuovo piano di complessità, a cui ci ha condotti una dinamica di valorizzazione prodotta dall’interno delle lotte stesse. In questo senso, il rinnovamento dell’attualità della “rivolta plebea”, così produttiva dal punto di vista del linguaggio e degli immaginari della trasformazione sociale negli ultimi anni in America Latina, richiede di tornare a discutere di un orizzonte programmatico e della formazione di coalizioni capaci di attuarlo in un contesto che si annuncia sempre più marcatamente caratterizzato da una nuova conflittualità sociale.
La critica che abbiamo qui proposto della categoria di movimenti sociali, per dirla in modo molto semplice, è motivata in primo luogo dall’esigenza di evitare ogni ripiegamento “nostalgico”, che congeli in qualche modo le immagini dei soggetti collettivi in un’istantanea scattata in un’epoca ormai trascorsa. Ma altrettanto importante ci sembrava dar conto di un insieme di dinamiche che riprendono e sviluppano buona parte delle premesse, delle modalità di azione e organizzazione messe in campo dai movimenti sociali dall’interno di un processo di continuo sconfinamento delle loro pratiche e delle loro lotte. Cruciale ci appare qui quello che abbiamo definito come punto di incrocio tra dinamiche politiche di lotta ed “economie popolari”, per indicare un nuovo terreno, più complesso ma al tempo stesso più realistico, a partire dal quale pensare le sfide politiche del presente. È all’interno di questo tessuto eterogeneo e ambivalente che, come abbiamo sottolineato, si affermano modi di fare, costruire e lavorare che entrano in tensione tanto con gli immaginari e i linguaggi dei “movimenti sociali” quanto con le politiche di “sviluppo” e “inclusione sociale” dei governi “progressisti”. È però qui che la questione di una democratizzazione della produzione, dell’efficacia della cooperazione sociale a partire dall’emergere di nuovi criteri di organizzazione, di una nuova definizione del benessere e della “felicità”, viene messa alla prova e quotidianamente sperimentata, spesso scontrandosi con problemi che costringono a formidabili esercizi di immaginazione politica. Su questo terreno evidentemente più complesso occorre oggi riqualificare in America Latina la sintesi tra l’autonomia, il suo radicamento e la sua traduzione istituzionale, e le forme emergenti di lotta contro lo sfruttamento.
Riferimenti bibliografici
Barker, Colin – Laurence Cox – John Krinsky – Alf Gunvald Nilsen (eds), Marxism and Social Movements, Leiden, Brill, 2013.
Coraggio, José Luis, Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2011.
Della Porta, Donatella – Mario Diani, Social Movements: An Introduction. 2d ed. Malden, MA, Blackwell, 2006.
Gago, Verónica – Sandro Mezzadra – Sebastián Scolnik – Diego Sztulwark, ¿Hay una nueva forma-Estado? Apuntes latinoamericanos, in “Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social”, XIX (2014), 66, pp. 177-184.
Gago, Verónica – Sandro Mezzadra, Para una crítica de las operaciones extractivas del capital. Patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización, in “Nueva sociedad”, 255 (enero-febrero 2015), pp. 38-52.
Gago, Verónica, La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.
García Linera, Álvaro, La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia, Beunos Aires, Prometeo Libros, 2008.
García Linera, Álvaro (coord.), Sociología de los movimientos sociales en Bolivia. Estructuras de movilización, repertorios culturales y acción política, La Paz, Diakonia-Oxfam, 2004.
García Linera, Álvaro – Raúl Prada – Luis Tapia – Oscar Vega Camacho, El Estado. Campo de lucha, La Paz, Muela del Diablo Editores, 2010.
Gutiérrez Aguilar, Raquel, Los Ritmos del Pachakuti. Movilización y levantamiento indigena popular en Bolivia, Buenos Aires, Tinta Limón, 2008.
Gutiérrez Aguilar, Raquel, Horizonte comunitario-popular. Antagonismo y producción de lo común en América Latina, Puebla, ICSY-BUAP, 2015.
Gutiérrez Aguilar, Raquel – Luis Tapia – Raúl Prada – Álvaro García Linera, Democratizaciones plebeyas, Comuna, La Paz-Bolivia, 2002.
Hardt, Michael – Toni Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, Milano, Rizzoli, 2010.
Lacalu, Ernesto, La ragione populista, Roma, Laterza, 2008.
Mezzadra, Sandro – Diego Sztulwark, Anatomía política de la coyuntura sudamericana, Imagenes del desarrollo, ciclo político y nuevo conflicto social, novembre 2014, http://anarquiacoronada.blogspot.it/2014/11/anatomia-politica-de-la-coyuntura.html
Mezzadra, Sandro – Brett Neilson, Operations of Capital, in “South Atlantic Quarterly”, 114 (2015), 1, pp. 1-9.
Obarrio, Juan Manuel – Valeria Procupez, Los nuevos movimientos sociales en América Latina, “Explora / Ciencias Sociales”, 2013, http://es.slideshare.net/EscuelaBicentenario/los-nuevos-movimientos-sociales-en-amrica-latina
Prevost, Gary – Carlos Oliva Campos – Harry E. Vanden (eds), Social Movements and Leftist Governments in Latin America: Confrontation or Co-optation?, London – New York, Zed Books, 2012.
Rivera Cusicanqui, Silvia, Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS, La Paz, Piedra Rota/Plural, 2014.
Stefanoni, Pablo – Maristella Svampa (coord.), Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales, Buenos Aires, El Colectivo – Clacso, 2007.
Thomson, Sinclair, Cuando sólo reinasen los indios, La Paz, La mirada salvaje, 2006.
Tilly, Charles – Sydney Tarrow, La politica del conflitto, Milano, Bruno Mondadori, 2008.
Valenzuela, Esteban (coord.), Aproximaciones a una nueva Constitución. Principios y artículos para un Chile justo, libre y fraterno, Santiago de Chile, El Desconcierto, 2014.