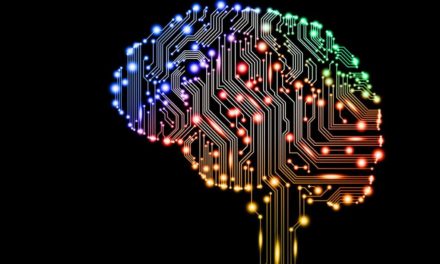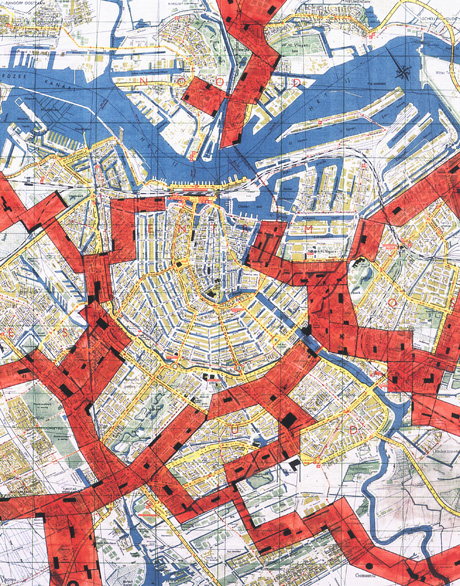Riprendiamo qui due testi di Benedetto Vecchi sull’opinione pubblica in rapporto con la rete e i social e sulla possibile costruzione di contropoteri. La prima parte del secondo articolo, a firma di Benedetto Vecchi, apre il Quaderno di EuroNomade sul Contropotere – progettato, immaginato e strutturato insieme a lui. Il Quaderno può essere scaricato cliccando qui.
Gli apprendisti stregoni dell’opinione pubblica sono in rete – 9 settembre 2015
di BENEDETTO VECCHI
Va preliminarmente sgomberato il campo da una rappresentazione della produzione dell’opinione pubblica che vede una polarità tra vecchi e nuovi media. Da una parte, viene sostenuto, attingendo e al lessico di Marshall McLuhan, ci sono la carta stampata, la radio e la tv, che sono medium freddi o caldi dove si esprime l’egemonia dello stile enunciativo televisivo, data la rilevanza del visuale – le immagini rivelano una immediatezza comunicativa che manca invece alla parola orale o scritta -; dall’altra c’è la Rete, regno indiscusso del caos comunicativo e dall’assenza di una gerarchia che seleziona i fatti e i punti di vista. Da una parte un ordine del discorso facile da decrittare e mettere a critica; dall’altra una trasparenza radicale della comunicazione che produce un rumore di fondo che distoglie l’attenzione e favorisce una colonizzazione della discussione pubblica da parte dei governi e delle imprese. Speculare a queste, c’è l’altra rappresentazione, dove i “vecchi media” sono una sofistica tecnologia del controllo sociale, mentre il web sarebbe uno spazio comunicativo difficile da manipolare e ribelle a qualsiasi eterodirezione palese o nascosta.
Entrambe le rappresentazioni inducono all’equivoco che la Rete sarebbe, di volta in volta, una tecnologia della liberazione dal potere performativo e autoritario di televisione, carta stampata e radio; o uno strumento di manipolazione dell’opinione pubblica, possibilità preclusa ai vecchi media visti gli elementi di autogoverno che regolano il loro funzionamento, a partire dalle regole deontologiche dei giornalisti che consentono proprio ai giornalisti di vigliare sull’operato degli editori e dei direttori.
La critica a tali rappresentazioni non può limitarsi – anche se è un terreno che non va abbandonato – alle contraddizioni e le aporie che manifestano, ma deve investire il fatto che sono ordini del discorso che precludono la strada a una prassi teorica critica del contemporaneo modo di produzione dell’opinione pubblica. E allo stesso tempo pregiudicano le possibilità di prassi comunicative che rompano il monopolio nella produzione di consenso. Per quanto riguarda i movimenti sociali, questo non significa imitare stili e modalità comunicative dei vecchi e nuovi media, ma usarle per forzare i confini e l’alveo costruito per governare i flussi di informazione e di contenuti. In altri termini, vanno destrutturate le polarità costruite al fine di rendere complementari i punti di vista che si manifestano nella discussione pubblica. L’esempio più evidente sono i talk show, formula e format logori – sono in caduta libera nell’economia dell’attenzione dei media – dove le tonalità comunicative tendono sempre alla conferma del già noto.
Il confronto vis-à-vis che li caratterizza assume sempre un andamento che vede i partecipanti entrare in un’arena dove il pubblico già conosce il punto di vista che esprimeranno. E superata la prima fase di contrapposizione, la discussione si conclude con la conferma delle posizioni e delle opinioni di partenza. Una riappropriazione del format alla base del talk show più che a confermare il punto di vista, seppur radicale, del conduttore o dei partecipanti dovrebbe produrre un’”opera aperta”, cioè un manufatto culturale che eccede la rappresentazione del reale dominante, ma che non si chiude in consolanti ripetizioni del già noto, anche se il noto è espressione di una critica del presente. E se questo è un campo di sperimentazione inusuale dei movimenti sociali, dato che la televisione è stata fin qui l’esempio di un media precluso a pratiche di autogestione e autoproduzione perché è un media che richiede ingenti investimenti di capitale, più chiaro è l’esempio che viene dalla Rete.
Le “vecchie” mailing list, i “nuovi” blog o i social network sono stati un tentativo di tradurre il talk show in una situazione dove l’interattività in tempo reale rendeva superflua la figura del conduttore. Ma anche in questo caso, i flame, i troll più che operare uno scardinamento del flusso comunicativo confermano semmai il campo tematico iniziale, senza mai trasformarlo o arricchirlo. Una prassi comunicativa che rompa gli argini della discussione pubblica non può che appropriarsi delle regole produttive per però aprirsi all’imprevisto, all’inusuale, cioè all’eccedenza della cooperazione sociale e comunicativa. I movimenti sociali vanno quindi immaginati anche come un’”opera aperta”. Per questo va riconfigurata anche le dialettiche, care ai teorici dell’ecologia della comunicazione come il tedesco di origine coreana Byung-Chul Han, tra comunicazione veloce e approfondimento, tra lentezza e diffusione virale dei contenuti. Il problema non sono gli sciami che si formano e si dissolvono nella circolazione dell’informazione, inseguendo la disconnessione della Rete come un antidoto alla figura alienata dell’homo digitalis, ma di alternare guerriglia mediatica – le mail bombing, i tweetstorm, i ddos – che i mediattivisti praticano in Rete a sperimentazione nel campo televisivo e della radiofonia. In sintesi, i movimenti sociali hanno la possibilità di assumere l’avvenuta convergenza tecnologica tra vecchi e nuovi media come il contesto di una guerriglia mediatica che costruisce consenso perché pratica il conflitto. E’ questa l’”opera aperta” che i movimenti sociali possono produrre.
Sia però chiaro che la critica alle rappresentazioni dominanti non può essere abbandonata.
La prima confutazione viene dalla cosiddetta convergenza tecnologica tra old e new media, tema sul quale hanno già scritto Tiziana Terranova e Roberta Pompili. E tuttavia va fatto tesoro di una suggestione del media theorist Lev Manovich, quando scrive che il computer – il suo saggio The Language of New Media è del 2001, quando cioè la Rete cominciava solo allora ad avere quel ruolo pervasivo e globale nella circolazione dell’informazione – ha tutte le caratteristiche tecnologiche per diventare un medium universale, visto che può essere programmato per scrivere, elaborare immagini, video e suoni. Da qui la convinzione di Manovich che la Rete avrebbe fagocitato i vecchi media.
La sua tesi è tuttavia espressione di un venale determinismo tecnologico che mette in secondo piano la frammentazione del pubblico e il parallelo proliferare di una differenziazione dei format nella produzione e nella circolazione dei contenuti informativi e dell’entertainment. Per Manovich infatti lo sviluppo dei media è stato scandito dall’evoluzione della tecnologia che ha avuto come fattore terminale il microprocessore e il computer, i quali possono facilmente programmati per elaborare testi, immagini e suoni. Da qui la sua superiorità rispetto alla televisione, destinata ad essere messa i margini dalla rete come medium ormai universale. Quel che il media theorist e performer di origine russa metteva in conto è la crisi del modello gerarchico di trasmissione dell’informazione dove una moltitudine di utenti passivamente consumavano news, video e suoni trasmessi da pochi centri di produzione e trasmissione.
L’implosione del modello dall’”uno ai molti” che ha caratterizzato i media ha visto una radicale trasformazione dei “vecchi media” a causa anche dalla messa a critica della presunta autorialità inerente la produzione di informazione e un “esodo” dal medium televisivo ritenuto ormai inadeguato alla costruzione di menù personalizzati che potevano essere attivati dal telecomando e dai riproduttori di immagini (videocassette prima, dvd successivamente e attuale accesso ai canali di YouTube o alle attuali piattaforme di streaming on line). La televisione perdeva così la sua “natura generalista” per privilegiare lo sviluppo di canali tematici, propedeutici per la raccolta pubblicitaria attraverso le pay tv e per lo sviluppo di nuovi programmi, fiction, produzioni di contenuti (un processo analogo ha riguardato anche le radio). La Rete, dal canto suo, ha da sempre avuto come condizione normale l’esistenza di una molteplicità di pubblici che potevano sempre diventare al tempo stesso produttori di informazione e intrattenimento. Da qui la necessità di rappresentare la produzione di informazione, e dell’intrattenimento, come un flusso alimentato da una potenziale crescita esponenziale di canali tematici e di piattaforme comunicative. Più che parlare di egemonia dei nuovi media, sarebbe dunque necessario mettere a critica la produzione e circolazione di contenuti che ha nell’interdipendenza e la complementarietà tra format televisivi, radiofonici e la Rete, ormai immaginata come un medium al pari degli altri.
Non siamo tuttavia di fronte a un moloch che manipola le coscienze in base a un processo pianificato e centralizzato di controllo dei contenuti, bensì a dispositivi tesi a deviare il flusso informativo quando questo rischia di violare i confini delle compatibilità dell’ordine costituito. .Per usare un’immagine: il controllo avviene a valle o, più frequentemente, nella messa in tensione e relazione conflittuale di punti di vista, operando sempre un detournment del punto di vista altero, eccentrico rispetto il canone dominante. Le forme più cogenti al synopticon, cioè di tecnologie del controllodiffuse e pervasive, sono il talk show o l’interattività modellata sulle piattaforme tecnologiche della blogsfera, dove opinioni diverse possono scontrarsi all’interno di un ordine dominante del discorso che, se messo in discussione, va ripristinato. In altri termini il controllo è affidato agli stessi partecipanti della discussione. E’ questa la modalità dominante nella discussione pubblica e nella produzione di informazione, dove i media devono tuttavia avere una libertà di azione per catturare l’attenzione dei singoli, rafforzando così la proliferazione e la valorizzazione economica dei diversi pubblici.
Per quanto riguarda la Rete, molto è stato detto alla tendenza dei social media e dei social network a favorire la scomposizione del pubblico in una molteplicità di tribù di simili, impermeabili a stili di vita e punti di vista diversi. Anche in questo caso, più che di governo dei media, si può parlare di governance dei flussi informativi, assumendo nuovamente l’integrazione e la complementarietà dei diversi media come un punto qualificante della produzione di opinione pubblica. A questo proposito la migrazione di stili della comunicazione da un media all’altro affrontata da Tiziana Terranova e Roberta Pompili come uno degli elementi emergenti nel fare televisione e nel fare Rete o radio, è dunque da considerare come la manifestazione di una “transmedialità” dove ogni media non perde la sua specificità: semmai la consolida, rinviando continuamente a quanto producono gli altri media. Da questo punto di vista l’uso spregiudicato e in tempo reale di Twitter nei talk show politici è simmetrico ai tweet della rete che commentano quanto accade dentro il tubo catodico.
L’ordine del discorso dominante deve essere necessariamente performativo, ma all’interno di un regime dove la libertà di espressione è propedeutica alla produzione di una comunicazione finalmente “libera” però di essere catturata dal processo di valorizzazione economica.
La libertà di espressione è dunque propedeutica all’alimentazione del flusso informativo, delegando alle piattaforme tecnologiche il compito di “fideilizzare” il consumatore e produttore di contenuti. Manuel Castells ha parlato a lungo di “autocomunicazione di massa” per segnalare il doppio statuto di produttore e consumatore di contenuti che caratterizza l’infosfera, quasi che questa condizione al confine di due momenti distinti e separati del modo di produzione dell’opinione pubblica sia la condizione necessaria per processi di emancipazione dal potere delle corporation globali della comunicazione. Nulla però viene detto come destrutturare le gabbia dei format della comunicazione, sia quelli inerenti la televisione che quelli inerenti la Rete e la radio, consegnando la carta stampata a elemento ormai secondario nella produzione di opinione pubblica. E se l’informazione è stato il terreno privilegiato della prassi teorica dei movimenti sociali, rimane invece limitato ai visual studies e ai media theorists una messa a critica del ruolo svolto dalla fiction nella rappresentazione della realtà e nella costruzione di un ordine del discorso conseguente ai rapporti sociali di produzione capitalistici.
Non si tratta però di ripercorrere sentieri giù battuti – spesso rivelatisi vicoli ciechi – tra struttura e sovrastruttura, tra coscienza e falsa coscienza. I media svolgono la funzione di rispecchiamento della realtà, ma anche di produzione di realtà. Le fiction sono esemplari di questa duplice funzione di rappresentazione e manipolazione. Attingono a stili di vita, attitudini al consumo, a concezioni delle relazioni sociali e sentimentali che non coincidono o sono alteri ai canoni dominanti. La loro messa in scena le legittima, ma allo stesso tempo diventano il campo dentro il quale attivare strategie di normalizzazione che hanno nelle regole dettate dai format scelti uno strumento di efficace governance. Sono cioè ricondotte a un ordine del discorso flessibile e tuttavia invalicabile nel suo divenire.
Nel suo fondamentale saggio sul ruolo ricombinante della Rete, significativamente intitolato Cultura convergente (Apogeo), il media theorist Henry Jenkins analizza come dietro la parola d’ordine della interattività sia all’opera una complessa trama di relazioni tra gruppi di fan e produzione di fiction dove i primi svolgono una vera e propria operazione di lobbying al fine di modificare sceneggiature e di rompere la gabbia del conformismo statunitense, facendo irrompere stili di vita eterodossi come l’amore omosessuale, lesbico o gli stili di vita metropolitani degli adolescenti americani. E se per Jenkins questo è il sintomo del potere dei fan, emerge dalle sue analisi dei forum di discussione e delle risposte delle major dell’intrattenimento e hollywoodiane una rappresentazione di come nel flusso di contenuti convivano rottura dei codici dominanti e ripristino ex post dell’ordine del discorso dominante.
L’elemento conseguente di questo sistema integrato della comunicazione e dell’intrattenimento è la residualità dell’aspetto tecnologico. Sia ben chiaro la produzione di hardware e di software svolgono ancora un ruolo significativo, sia in termini di investimenti che di composizione organica del capitale. Ma nella produzione di opinione pubblica ciò che diventa rilevante è lo sviluppo di quella figura di “uomo mediatizzato” sulla quale hanno concentrato l’attenzione Toni Negri e Michael Hardt nel saggio Questo non è un manifesto (Feltrinelli) quando hanno stabilito la tassonomia dell’individuo proprietario e il ruolo svolto dai media nel garantire i rapporti di potere vigenti. L’”uomo mediatizzato” è quindi da considerare più che un prodotto finito, l’espressione dei limiti del potere pastorale delle imprese e dagli stati nazionali nel produrre l’”uomo nuovo” del capitalismo contemporaneo. Più che espressione di prototipo di una soggettività normalizzata, l’”uomo mediatizzato” è da considerare il prototipo di una egemonia culturale sempre in divenire. E sempre a rischio di dissolversi dentro le cloud di dati che scaturiscono dalla infosfera. “Vanno e vengono”, scriveva Fabrizio De Andrè: in questo caso, le nuvole di dati esprimono la centralità della comunicazione sociale nella produzione di contenuti, dove l’egemonia del dispositivo neoliberale si manifesta a posteriori, come un processo politico di instradamento dentro percorsi definiti del flusso informativo.
La centralità della produzione dei contenuti rinvia dunque alla tensione conflittuale tra opinione pubblica e movimenti sociali. Tra costruzione del consenso e pratiche politiche. Tra società civile e potere politico. Nell’ormai classico saggio Storia e critica dell’opinione pubblica (Laterza) Jurgen Habermas sottolineava l’originario intreccio tra i primi giornali e capitalismo mercantile, visto che la carta stampata forniva informazioni sui traffici, l’andamento dei prezzi, insomma le informazioni sugli scambi commerciali, relegando ai margini quel ruolo di controllo sull’operato del sovrano che l’opinione pubblica doveva esercitare una volta che i legami medievali erano venuti meno, ponendo al centro della sfera pubblica una borghesia refrattaria al potere assoluto del monarca. Habermas traccia una storia lineare del rapporto tra media, opinione pubblica e il Politico, omettendo o ridimensionando il ruolo politico della carta stampata durante la Rivoluzione francese o le rivoluzioni europee del 1848.
Le tesi del filosofo tedesco non vanno tuttavia criticate solo per le omissioni che manifestano, ma perché assegnano sempre ai media un ruolo ancillare del sistema politico, mentre l’opinione pubblica ha solo un ruolo di controllo dell’operato del sovrano. Fattore, questo, che entra in contraddizione con la parte meno indagata di Storia e critica dell’opinione pubblica, quella cioè relativa agli anni successivi la fine della seconda guerra mondiale. La platea, originariamente occupata dai letterati, il sovrano e un pubblico generico come è sempre quello dell’opinione pubblica si riempie di altri protagonisti. I giornalisti, ma anche i funzionari delle organizzazioni degli interessi – i sindacati per la classe operaia, i dirigenti delle associazioni imprenditoriali per il capitale, i politici di professione per lo Stato – e un arricchimento della produzione di contenuti con la diffusione della radio e della televisione. In questa proliferazione di soggetti sociali e di tecnologie, l’opinione pubblica diventa l’ambito prepolitico dove produrre un senso comune che non rompa il quadro di compatibilità necessario alla riproduzione della società e dei rapporti sociali di potere operanti in essa. E se Habermas il vincolo è la legittimazione e riformulazione di un patriottismo costituzionale che salvaguardia le società moderna da tentazioni autoritarie, per gli opinion makers questo significa che il loro compito è quello di essere i guardiani dell’ordine costituito. A loro il compito di decidere cosa può accedere nel campo della discussione pubblica. Sono cioè i gate-keeper che regolano la definizione dell’agenda che scandisce il ritmo della sfera pubblica. La loro autorità è data dalla conoscenza dei mezzi tecnologici e dei format che danno forma alla comunicazione.
Non è questa la sede per una critica puntuale dell’agire comunicativo teorizzato dal filosofo tedesco. Né per evidenziare i suoi salti mortali tesi a conciliare la crisi di legittimazione del capitalismo con l’irruenza e riluttanza del sociale a quel patriottismo costituzionale che preserva la democrazia rappresentativa da derive populiste. Quello che non poteva essere messo nel conto da Jurgen Habermas è l’irrilevanza politica dell’opinione pubblica, mentre i media sono diventati un’articolazione di quel potere che dovevano controllare. L’esercizio della critica va di conseguenza delegato agli intellettuali, legittimati dalla loro distanza e autonomia dal potere politico e economico. A loro il compito di illuminare nuovamente la caverna e dissolvere il potere performativo delle ombre dei conflitti sociali e di classe proiettati sulla scena pubblica. Non più organica a una classe, la figura dell’intellettuale è nuovamente ricondotta, dentro e dopo la crisi irreversibile della forma-partito in quanto intellettuale collettivo, alla sua disciplina e specializzazione formativa; e in base alla sua internità alla produzione di sapere può quindi svolgere un ruolo critico e favorire quella politicizzazione del reale che l’esistenza dell’opinione pubblica ostacola. Una prospettiva che assume la specializzazione del lavoro intellettuale come leva per scardinare il senso comune dominante, ma che ignora l’internità all’industria culturale e alle istituzioni del sapere dell’intellettuale specifico, fattore questo che pregiudica proprio quella politicizzazione delle relazioni sociali che i media impediscono. È questa l’amara eredità teorica di un intellettuale appassionato e militante come Edward Said, laddove analizza l’eclissi della figura gramsciana dell’intellettuale organico e le difficoltà di un’autonomia degli intellettuali dal potere economico e politico. La costruzione del consenso, e dunque la possibilità di scardinare il senso comune, è tuttavia prerogativa di ogni pratica politica che si rispetti (Dire la verità. Intellettuali e potere, Feltrinelli). Ed è fattore cogente se è una pratica politica espressa da un movimento sociale.
È nota la diffidenza, anzi l’ostilità dei movimenti sociali verso i media, considerati a ragione strumenti di manipolazione delle coscienze. Diffidenze e ostilità da superare a partire da un principio di realtà che è impossibile ignorare: il ruolo rilevante e pervasivo delle tecnologie della comunicazione conduce la critica ai media come strumenti di dominio a incorrere in veri e propri vicoli ciechi. Più che consegnarsi a un “primivitismo” fuori luogo e del tutto subalterno a quella “cattura” dell’intelligenza collettiva che i media operano, come le tesi del capitalismo “estrattivo” hanno avuto la capacità di mettere a fuoco, va registrato il fatto che si è consumata una discontinuità nello sviluppo della tecnologia, perché il computer consente una produzione di informazione e di contenuti senza un grande capitale. Si può chiamare “autoproduzione di massa” o in altra maniera, ma è un dato di fatto che il computer e la Rete consentono la traducibilità operativa di quell’indicazione politica che all’alba del nuovo millennio recitava di non odiare i media, bensì di diventare un media. Dunque produzione in proprio di contenuti, sia nella forma testuale che visuale, avendo a disposizione un potente canale di distribuzione (la Rete).
Non si tratta però di produrre un’opinione pubblica più radicale, bensì di svelare, eccedere la spoliticizzazione del reale che l’opinione pubblica produce. Non si tratta quindi di tenere separati la il consenso dal conflitto, come se il secondo negasse la possibilità del primo termine. Ma di tenerli insieme, come varianti di un unico movimento. Nei contributi apparsi sul sito di Euronomade – Exploit di Pisa e Social Media Lab di Napoli – si inviata ad occupare le reti sociali e di immaginare le “maschere” che hanno la capacità di tradurre le istanze dei movimenti sociali. Inviti da accogliere, sapendo che le maschere da indossare abbiano la capacità di svelare quel che gli opinon makers spacciano come unica realtà.
Questo articolo è stato pubblicato su EuroNomade il 9 settembre 2015.
Di BENEDETTO VECCHI, DANIELE GAMBETTA e CLARA MOGNO
Che cos’è il contropotere? E che cosa significa fare e organizzare contropotere nella rete, all’altezza della rivoluzione digitale? Per rispondere a queste domande conviene forse sciogliere il lemma e verificare che cosa s’intende con potere nella tradizione filosofico-politica moderna. È forse immergendosi nella concettualità e nella sua logica, aprendo le alternative della modernità, che si possono costruire strumenti per inventare linee di costruzioni future.
Lo Stato moderno si fonda sul meccanismo di delega, sulla rappresentanza, e sulla formalità astratta del soggetto. Nella modernità, lo si vede in Hobbes come in Rousseau, la logica del potere si sviluppa attorno alla figura del patto e ad un Uno che si da su più livelli: uno lo Stato, una la singolarità individuata nell’individuo, una la società. La concettualità alla base della statualità moderna individualizza le soggettività, intessendo legami sociali a partire da unità non riconosciute nel loro essere già molteplici. Riconoscere la relazionalità intrinseca delle soggettività significa, di contro, scardinare alla base la struttura logica e pratica della politica statale. Contro-potere quindi potrebbe essere questo: un attacco al potere moderno e alla sovranità, all’individualità e, allo stesso tempo, la creazione di istituzioni e organizzazioni in grado di deporre la figura del padre e la proprietà.
Liberarsi dalla sovranità permette l’esplorazione della dimensione transnazionale: in questo senso, l’oltre la nazione si formula sia da un punto di vista concettuale sia da un punto di vista pratico e politico, per la creazione di dispositivi concettuali e di alleanze relazionali (riconoscendone il loro già essere in atto). In questa direzione, come leggere la rete? Quali sono le connessioni relazionali che si stabiliscono nelle piattaforme e nei social network? Che cos’è un user? È quest’ultimo un soggetto moderno o il peso del nodo delle sue relazioni? Quali sono le potenzialità che il digitale offre nel ripensamento della soggettività, nella costruzione di contropotere e nella produzione di un altro modo di vita?
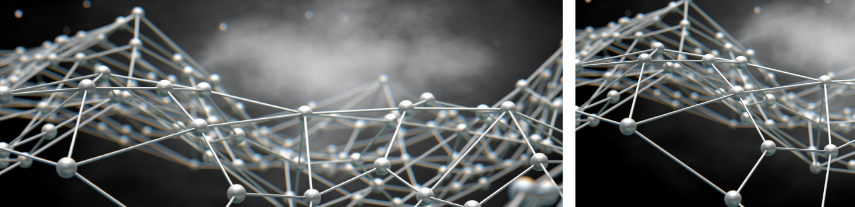
RETE E OPINIONE PUBBLICA – CONFLITTO E CONSENSO
Di BENEDETTO VECCHI
Il contropotere è, nella prospettiva dei movimenti sociali, un esito non scontato, molte le insidie che s’incontrano nel camminare insieme. Nel passato prossimo della loro storia, i movimenti sociali hanno infatti stabilito che, una volta appurato che il cammino non poteva che essere collettivo, era opportuno porsi domande nel proseguo del percorso. “Camminare domandando”, recitava quindi il mantra fuoriuscito da Selva Lacondona nel Chiapas agli inizi degli anni Novanta del Novecento per segnalare che i movimenti sociali devono produrre, oltre che una visione condivisa sul futuro possibile e dunque auspicabile, consenso attorno ai loro conflitti del presente. Devono cioè produrre opinione pubblica.
C’è nell’espressione opinione pubblica una prospettiva inedita nel lessico politico della modernità. Per la prima volta, agli albori dell’illuminismo, si staglia sulla scena pubblica una presenza impensabile e imbarazzante per i gestori del potere. Il sovrano non deve vedersela solo con la corte e le tensioni e i conflitti immanenti alle dinamiche nel sistema di potere. Il capitalismo commerciale, il progressivo inaridimento della funzione progressiva del lavoro artigianale, il diffondersi della produzione editoriale di libri e dell’uso dei dispacci – veri antesignani dei giornali – che informavano sull’andamento dei commerci e di ciò che accadeva al di fuori dell’universo circoscritto del mercato locale e del paese, fanno emergere la presenza di un aggregato sociale e culturale fino ad allora non contemplato. Lo si può chiamare borghesia, oppure terzo stato, ma sta di fatto che questa classe sociale che non si muove come tale ma solo come formazione culturale generica, ma l’opinione pubblica si colloca in una terra di nessuno dove le classi sociali non sono contemplate come tali, dove il sovrano continua ad esercitare il potere anche se sottoposto non al controllo ma allo sguardo pubblico di chi legge, si informa, comunica con i simili sull’andamento degli affari correnti dello Stato. L’opinione pubblica, in altri termini, si muove al confine tra lo Stato e gli affari privati. Ma in nome della rilevanza degli affari privati rivendica il diritto di potere valutare l’efficace e la pertinenza delle azioni del Sovrano. Non prevede, la presenza di una opinione pubblica, l’invasione di campo della politica, cioè del funzionamento della macchina statale e dei rapporti sociali, ma solo l’esercizio del diritto di guardare l’operato del Sovrano.
L’opinione pubblica agisce cioè uno spettatore attento di quanto accade in quella che ormai viene ormai considerata una scena appunto pubblica. Dovrà accadere l’assalto alla Bastiglia, il lento agglutinarsi, dopo la sua dissoluzione, dell’opinione pubblica in circoli, gruppi organizzati affinché l’opinione pubblica rompa l’incantesimo che nega l’agire politico e possano i vari gruppi e circoli diventare punti di vista partigiani, divisivi, inventare i lessici politici attinenti la vita delle classi sociali. E solo allora l’indeterminatezza tra vita corrente – gli affari privati – e gli affari dello Stato cessa di essere. Ma siamo appunto agli inizi della modernità capitalistica. L’opinione pubblica può mantenere tutte le ambivalenze che le sono proprie. Sta di fatto che una di queste ambivalenze – esercitare la critica del sovrano senza però prefigurare agire politico – torna come una costante, una ripetizione cioè senza differenza rispetto al passato. Un’ambivalenza che si trasforma in limite allo sviluppo dei movimenti sociali e in blocco della coppia consenso e conflitto che pure i contemporanei movimenti sociali hanno, correttamente, individuato come una scommessa politica da giocare senza remore alcune per innovare le forme dell’azione politica e come orizzonte ineludibile di un contropotere niente affatto effimero.
Ma è su questo crinale dell’innovazione organizzativa che c’è la prima insidia da affrontare. Incardinare infatti il consenso alla sola opinione pubblica significa negare ogni possibilità di contropotere, cioè di quell’esercizio di una potenza sociale e politica che può determinare non solo un mutamento dei rapporti di forza nella realtà ma anche la formazione di un immaginario che rende meno effimera la manifestazione dell’opinione pubblica lasciata orfana di ogni ordine del discorso sull’operato del sovrano, del potere che esercita sulla vita di uomini e donne e della costellazione sociale e di classe che definisce e legittima. Il tema dell’opinione pubblica è dunque un cortocircuito, un black out nell’azione politica di costruzione del contropotere se il consenso è ritenuto scisso, separato dal conflitto operato nella società.
Di questo rischio è stata costellata l’azione di molti movimenti che hanno punteggiato la storia perigliosa del neoliberismo globale. Gli zapatisti avevano certo colto nel segno, segnalando la necessità di coniugare conflitto e consenso, ma non potevano certo mettere in conto che uno dei termini del discorso occultasse il secondo, evidenziando ciò che era noto sin dal pionieristico studio sull’opinione pubblica di un giornalista statunitense con un passato radical alle spalle prima di approdare a pacificate e conservatrici spiagge. Walter Lippman scrive il suo testo sull’Opinione pubblica (Edizioni comunità, recentemente ripubblicato da Donzelli) agli inizi degli anni Venti del Novecento, convinto che i media svolgano un ruolo sofisticamente manipolativo nella costruzione di un consenso cieco e stupido nei confronti del potere. Lungi dal credere che radio, giornali e cinematografo costituiscano un potere di controllo non statale rispetto a quelli canonici del legislativo, esecutivo e giuridico, vede nella produzione dell’opinione pubblica un dispositivo di prevenzione nella formazione di istanze politiche altre e conflittuali rispetto a quelle dominanti – lo scrive in una prospettiva conservatrice, cioè moralistica del nesso politica, movimenti sociali. La prima è essenzialmente manipolazione, i movimenti sociali sono variabili dipendenti, una plastilina facilmente manipolabile dai media. Non c’è possibilità altra. Con buona pace di chi vede nei media un contropotere, meglio l’ambito dove esercitare un contropotere.

Lippman scrive molto nella sua vita. Vince anche prestigiosi premi letterari e giornalistici, a partire dalle prime edizioni del Pulitzer. È ritenuto cioè uno dei grandi pilastri nonché un grande vecchio del giornalismo investigativo e controcorrente americano. Ha dalla sua l’aura dell’analista spregiudicato, anticonformista con un passato radical alle spalle ma ormai disincanto e refrattario al canto delle sirene della rivoluzione o del populismo made in Usa. Il suo focus sull’opinione pubblica mette al centro i meccanismi di manipolazione messi in campo dal sistema politico con la inconsapevole e talvolta pavida complicità degli intellettuali pubblici. La sua è una critica romantica, con forti tratti reazioni della democrazia di massa a stelle e strisce. Non può certo immaginare che passerà la staffetta dell’analisi, quasi quarant’anni dopo, a un filosofo tedesco, Jürgen Habermas, anch’egli in odore di radicalismo. Allievo della Scuola di Francoforte, è ritenuto – siamo alla fine degli anni Cinquanta – l’erede di Theodor W. Adorno ed è considerato, a ragione, uno degli analisti più accreditati nella Storia dell’opinione pubblica (Laterza) per la sua capacità di stabilire linee di evoluzione e di definizione dell’opinione pubblica non solo in presenza dei media, ma anche di altre organizzazioni preposte alla sua formazione: i partiti, i sindacati, le “associazioni degli interessi”, le istituzione del welfare state. Per Habermas, l’opinione pubblica viene prodotta all’interno di una dinamica di negoziazione e di agire comunicativo dove la posta in gioco è appunto la definizione di un ambito dove ogni diversità sia accolta in un quadro di compatibilità definita come un apriori invalicabile. Da questo punto di vista il conflitto, che il filosofo tedesco contempla come elemento dinamico, a differenza del suo rigetto da parte di Lippman, è propedeutico alla stabilità del sistema politico perché ambito non di costruzione dell’azione politica ma di una sua riduzione a opinione. Habermas fa dunque sua, non si sa quanto inconsapevolmente, la griglia analitica che vede la successione democrazia/oligarchia non come possibilità ma come esito obbligato nella costruzione del consenso: c’è opinione pubblica perché opera il potere di una oligarchia sulla società. Non è un caso che Habermas vede la storia dell’opinione pubblica proprio come la successione di gruppi sociali, politici, sindacali che parassitariamente crescono all’ombra di un potere che può certo essere interrogato, ma non pienamente controllato.
Questa impossibilità di immaginare la formazione dell’opinione pubblica come l’ambito di un contropotere è tanto più evidente in una situazione di mass media capillari e pervasivi. Radio, Tv, giornali, cinema, industria culturale e dell’intrattenimento sono solo dispositivi preposti alla negoziazione degli ambiti di movimento e degli interessi economici e sociali delle classi sociali. Sono cioè antitetici alla costruzione di iniziativa politica. Va stabilito se questo vale in presenza anche della Rete, cioè di un’infrastruttura comunicativa che risponde a una logica certo non prevista né da Lippman né da Habermas. I media, così come la produzione di senso e di immaginario, aveva poche fonti, spesso limitati siti produttivi e una diffusione da “uno ai molti”. L’opinione pubblica, cioè, era veicolata, formata, prodotta come ogni altra merce nel mercato di massa. Da qui l’impossibilità di immaginare i media come l’ambito del contropotere. Di questa impossibilità i movimenti sociali hanno fatto esperienza. Di questa impossibilità hanno fatto però poco tesoro. Hanno spesso inseguito il sogno di un consenso costruito con il crescere delle manifestazioni di pazza, dell’eco sui media del punto di vista espresso da questa o quella figura di rilievo. Gli intellettuali pubblici tanto cari a Michel Foucault e messi in stridente contrasto con quelli organici alla classe e al partito sono diventati le chiavi di accesso ai misteri del consenso, sono cioè diventati i depositari del potere comunicativo dei movimenti sociali. Che errore prospettico, che gabbia dell’immaginazione e dell’azione politica era costruita sulle difficoltà di scardinare l’ordine costituito. Con il world wide web si intravide la possibilità di rompere la gabbia di una diffusione dell’informazione e della conoscenza dall’uno ai molti, sostituendola con il flusso cangiante e libero dei “molti ai molti”. Ogni uomo e donna diventa fonte e ricevente di informazione, diventava cioè un opinion maker che rispondeva solo a un pubblico indistinto perché non sottoposto a nessun controllo o “padrone”. Per questo, Internet è stata salutata come l’ormai compiuto ambito dove la produzione di informazione e di immaginario era possibile in quanto espressione di un contropotere esercitato non dai movimenti sociali ma di una opinione pubblica finalmente adeguatamente informata e non dipendente da nessun potere economico più o meno occultato.

C’è molto da indagare, c’è molta ingenuità nel ritenere che i flussi di informazione sfuggano a quella dimensione che è il potere reale nella società. Internet ha certo l’eccezionalità della comunicazione dei “molti ai molti” dove l’interattività, il continuo feed back dell’agire comunicativo costituiscono una sorta di seconda natura dello stare in società, ma questo non si apre, come già intuito da Lippman per quanto riguardava i media novecenteschi, all’azione politica radicale bensì a sofisticati meccanismi di manipolazione e colonizzazione della vita pubblica da parte del potere costituito. Quel che è certo è che anche in Rete il contropotere è un esito incerto, così come la combinazione adeguata tra conflitto e consenso.
Rimane sempre di sciogliere il nodo del rapporto tra produzione di opinione pubblica e azione politica. La prima espressione nega la possibilità di politica. Assegna agli uomini e alle donne il rassicurante ruolo di spettatore di una scena pubblica che si dispiega e si sviluppa secondo un copione definito da altri. Costruire cioè consenso senza conflitto e senza immaginare la costituzione di organizzazioni adeguate al conseguimento di obiettivi, programmi, obiettivi stabiliti dal “produrre movimento” in comune significa accettare quella condizione colonizzata dallo stato o dalle imprese dello stare in società.
Abbiamo iniziato a discutere con Benedetto di questo pezzo lo scorso autunno e ci eravamo divisi i compiti. Lui si sarebbe concentrato sulla prima parte della scaletta, sul nodo “opinione e rete”, noi ci saremmo concentrati sulla seconda parte, sugli esperimenti di organizzazione attraverso il web e le piattaforme. Insieme saremo poi tornati sulle domande iniziali, sulla definizione di contropotere e sulle specificità delle possibili declinazioni attraverso il digitale. Benedetto ci aveva inviato il suo pezzo già a metà dicembre, noi, invece, eravamo in ritardo. Ben è scomparso, sono passati i mesi ed è scoppiata la pandemia del Covid19. Riprendendo i lavori ci siamo accorti di quanto il testo di Benedetto sia più che mai attuale, anche in questa crisi dai contorni globali. E abbiamo provato a continuare a “camminare domandando”.
CONTROPOTERI IN RETE: PIATTAFORME E TERRITORI DA CONQUISTARE
Di DANIELE GAMBETTA e CLARA MOGNO
I Gilets jaunes hanno cominciato ad infiammare i rond-points e i boulevards francesi a partire da un post su Facebook e, passo dopo passo, si è passati da un’espressione di opinione pubblica a una serie di prese di posizione politica e di azioni collettive – la passività della prima ha lasciato il posto all’attività del politico. A Hong Kong il movimento si è organizzato principalmente attraverso Telegram – e allo stesso tempo Donald Trump e Javad Zarif comunicano attraverso Twitter prima di passare attraverso i canali tradizionali e ufficiali. La politica, il consenso e i conflitti assumono attraverso i social media e la rete forme inedite, interrogando chi li osserva attraverso tensioni e paradossi. “Camminare domandando” forse significa provare a cogliere da vicino queste trasformazioni, senza smettere di provare a coglierne limiti, tendenze e anche le possibilità dell’attuale. La rete e le piattaforme ci sembrano offrire una possibilità: rappresentano su uno schermo e riproducono digitalmente la molteplicità delle relazioni e delle connessioni che ci costituiscono come soggetti. Questo si dà certo in una dialettica e in una tensione con una certa idea di individuo, ma il campo è aperto forse anche per un’altra idea di singolarità, proprio a partire dalla rete. Il contropotere nella rete è un esito incerto – but it’s worth a go. Sull’opinione pubblica le indicazioni di Benedetto Vecchi sono preziose. Ora, come disarticolare gli schemi che sorreggono quest’ultima per passare all’azione politica?
Negli ultimi vent’anni si sono dati moltissimi modi di stare in rete collettivamente, più o meno diffusi, più o meno mainstream. Pensiamo per esempio all’esplosione dei forum online nei primi anni Duemila, inedito strumento di aggregazione e di organizzazione, ma anche alle mailing list, ai blog e alle prime chat. A partire poi da myspace hanno cominciato a nascere i profili di singoli utenti, pagine personali e contemporaneamente si è sviluppato Msn, forse il primo sistema di comunicazione digitale di massa insieme a Skype. WhatsApp, Telegram e Zoom, invece, quelli maggiormente utilizzati ora. Abbiamo attraversato, come generazione nata alla fine degli anni ‘80, una trasformazione velocissima sia degli hardware sia dei software, un’evoluzione che ancora continua con processori sempre più piccoli e strumenti sempre più potenti.
È con Facebook, lanciato nel 2004, che si afferma un template e un formato specifico che determina la tendenza e la struttura dei social network come li conosciamo oggi. Pinterest, Instagram, Twitter si presentano, anche nelle loro versioni decentralizzate (pensiamo per esempio a Diaspora per Facebook, ma anche a Pixelfed) come la ripetizione dell’identico nella forma di interfacce con elementi e strutture grafiche simili, se non addirittura uguali. Nessuna re-invenzione del formato quindi, ma una continua riproduzione dell’identico e molteplici proliferazioni di template non solo nelle applicazioni di una stessa compagnia (come Instagram, Whatsapp e Facebook) ma anche in piattaforme di altri gruppi con diverse funzioni, ma con la stessa: in Netflix, per esempio, ora le “anteprime” dei film e delle serie vengono visualizzati come delle stories.

È forse necessario provare a riflettere circa gli effetti che hanno le strutture dei social network che utilizziamo. Ci troviamo davanti solamente alla possibilità dell’espressione del narcisismo individuale che produce immagini esaltanti di sé in rete? O assistiamo anche alla visualizzazione in pixel della relazione come elemento fondante dei soggetti? E poi, quanto la forma dell’evento facebook influisce e ha influito sulla temporalità dell’azione politica negli ultimi dieci anni? Che cosa stiamo facendo quando “pubblichiamo” uno status su Facebook? Ha senso un esodo verso luoghi virtuali come Mastodon, una ricerca di un “fuori” (che non pensiamo ci sia) o nell’ottica di un’uscita dalla dimensione dell’opinione pubblica può essere invece strategico rimanere nelle piattaforme più utilizzate? E soprattutto, quali sono gli obiettivi che ci poniamo in questo momento da un punto di vista politico attraversando la rete? Come ripensare dei formati che siano all’altezza dei nostri fini e che ci permettano di creare contropoteri attraverso la rete, sempre più privatizzata? Come rispondere all’estrattivismo dei data prodotti in comune?
Sicuramente, e lo abbiamo sperimentato anche negli ultimi mesi, la rete è più che mai essenziale per tessere relazioni e costruire progetti, campagne di mutualismo e solidarietà, per progettare azioni politiche, siano queste online e offline. Negli ultimi due anni abbiamo visto come i Gilets jaunes si siano dotati di un sito e abbiano contrapposto al Grand Debat un “vrai debat” , a Hong Kong, fronte alla chiusura di internet, i manifestanti abbiano cominciato ad utilizzare il Bluetooth per chiamare la popolazione nelle strade e per decidere sul momento quale strategia utilizzare nelle piazze[1], a Barcellona attraverso l’app Tsunami D si sia utilizzata la geolocalizzazione per capire chi poteva mobilitarsi nelle vicinanze, come Decidim abbia posto il tema della decisione in comune. “Camminare domandando”: noi, ora, di che cosa abbiamo bisogno per determinare un passaggio dal network alla rete sociale e di movimento, per ri-appropriarci di spazi di agibilità politica, uscendo dall’impasse che la stessa concettualità dell’opinione pubblica imprime all’espressione in rete? I Gilets jaunes sono riusciti a riappropriarsi del tempo ritrovandosi tutti i sabati in una serie di atti, una serie capace di essere al di fuori della fugacità dell’evento in cui Facebook segna sempre di più la determinazione spazio-temporale. Come riuscire a riappropriarci anche noi della continuità frammentata dell’azione politica?
In questi giorni di quarantena prendere parola sulle cose è stato estremamente difficile. Il virus ha comportato e conseguenze in ogni ambito sociale ed economico. La scuola, gli affetti, il lavoro, le relazioni sociali, la casa. In questo contesto il mezzo Rete ha svolto un ruolo chiaramente cruciale. Dal punto di vista dei movimenti, ci è sembrato chiaro a tutte/i fin dall’inizio che una grande difficoltà nell’immaginare la militanza era rappresentato dall’isolamento imposto e auto-imposto, e ancora di più nell’isolamento come forma di cura e tutela verso noi stesse/i. Una politica fondata sulla condivisione, sull’aggregazione, sulla socialità, si è trovata davanti a una situazione del tutto inedita. Aggregazione che, inevitabilmente, ha avuto riproduzione su canali virtuali, dalle assemblee alle conversazioni private[2].
Zoom è passato da essere una piattaforma relativamente poco conosciuta ad avere più di 300 milioni di utenti, sollevando critiche sull’inadeguatezza di saper gestire una crescita così rapida dal punto di vista della privacy. Il mezzo, tuttavia, non è mai neutrale. Così come non si può pensare di sostituire la didattica scolastica con una lezione su schermo, così è urgente interrogarsi su cosa si può e non si può, e su come si può fare per organizzarsi “in Rete”. Già dalle prime settimane della quarantena hanno circolato analisi e articoli sulla nausea da schermo, sui disturbi dell’attenzione correlati all’uso smodato di dispositivi elettronici, oltre che ai problemi legati a un’iperconnettività che rischia di trasformare la favola dello smart working in una costante reperibilità cronofaga[3].
Capire che fare della Rete, allora, potrebbe diventare cruciale nei prossimi mesi, in modi che dipendono chiaramente dalle forme di mobilità concesse, continuando a domandarci come articolare il passaggio da opinione pubblica ad azione politica per il comune, uscendo dalle bolle informazionali che ci avvolgono. C’è poi un’altra questione, che da molte discussioni pare emergere, che è proprio il come fare politica in fase emergenziale. Se da un lato abbiamo necessità di fare analisi, decostruire le interpretazioni tossiche sempre più radicate in un senso comune sempre più a destra, le mancanze dimostrate dai servizi e dal welfare spingono sempre più verso una ri-organizzazione anche del mutualismo e della solidarietà attiva.

Come attuare allora un contropotere, in fase emergenziale? Pensiamo al caso del digital divide. Parlarne e analizzare il problema è fondamentale per far emergere la situazione di tante persone, e per smascherare il classismo nascosto nell’ipotesi dello “smart per tutti”. É chiaro che l’accesso non basta, non si tratta di rincorrere la digitalizzazione a tutti i costi, si tratta di contestualizzare sempre e costantemente, di inventare forme di autoformazione digitale, sensibilizzare sui temi della privacy, dell’uso consapevole di tecnologie anche in merito all’attenzione alla nostra salute mentale – e, allo stesso tempo, è necessario garantire che un accesso vi sia e che non si un privilegio. Questa pandemia ci ha fatto vedere quanto sia importante avere una connessione internet, uno smartphone e competenze digitali minime – l’accesso alla rete, ai dispositivi e al saperli usare – punti, questi, che forse dovranno far parte della prossima agenda politica militante. Se il mancato accesso alla rete amplifica le fratture delle disuguaglianze, il semplice averne accesso certo non le cancella – ci permette però di organizzarci. C’è sicuramente una tendenza a considerare la tecnologia come soluzione, lo vediamo nel caso della scuola ma anche per quanto riguarda le app di tracking e tracing[4], che mette in luce anche un’interpretazione individualizzata della gestione sanitaria di una società malata. La rete è terreno di conquista, il suo uso ed il suo accesso una contesa politica che dobbiamo attraversare.
Per essere politico, di contropotere, un discorso sulla Rete deve considerare più che mai il contatto con il fuori-del-virtuale, interrogandosi ad esempio con le situazioni di mutualismo su quali strumenti possono essere utili, immaginando mappature o forme di comunicazione a supporto delle comunità, provando a immaginare una militanza dell’emergenza capace di intersecare la strada e la rete, il virtuale e il reale, fuori dalla depressione dell’isolamento ma riconoscendo la distanza come forma di cura reciproca[5]. Una sfida, questa, che è necessario affrontare con immaginazione e con la voglia di costruire mondi per tutte/i, continuando a “camminare domandando”.
Note:
[1] https://www.euronomade.info/?p=12401
[3] https://not.neroeditions.com/selfie-dalla-quarantena/
[4] http://effimera.org/covid-19-e-human-tracking-di-giorgio-griziotti-1/
[5] https://data-activism.net/blog-covid-19-from-the-margins/
Questo articolo è stato pubblicato su EuroNomade nel Quaderno sul Contropotere l’1 giugno 2020.