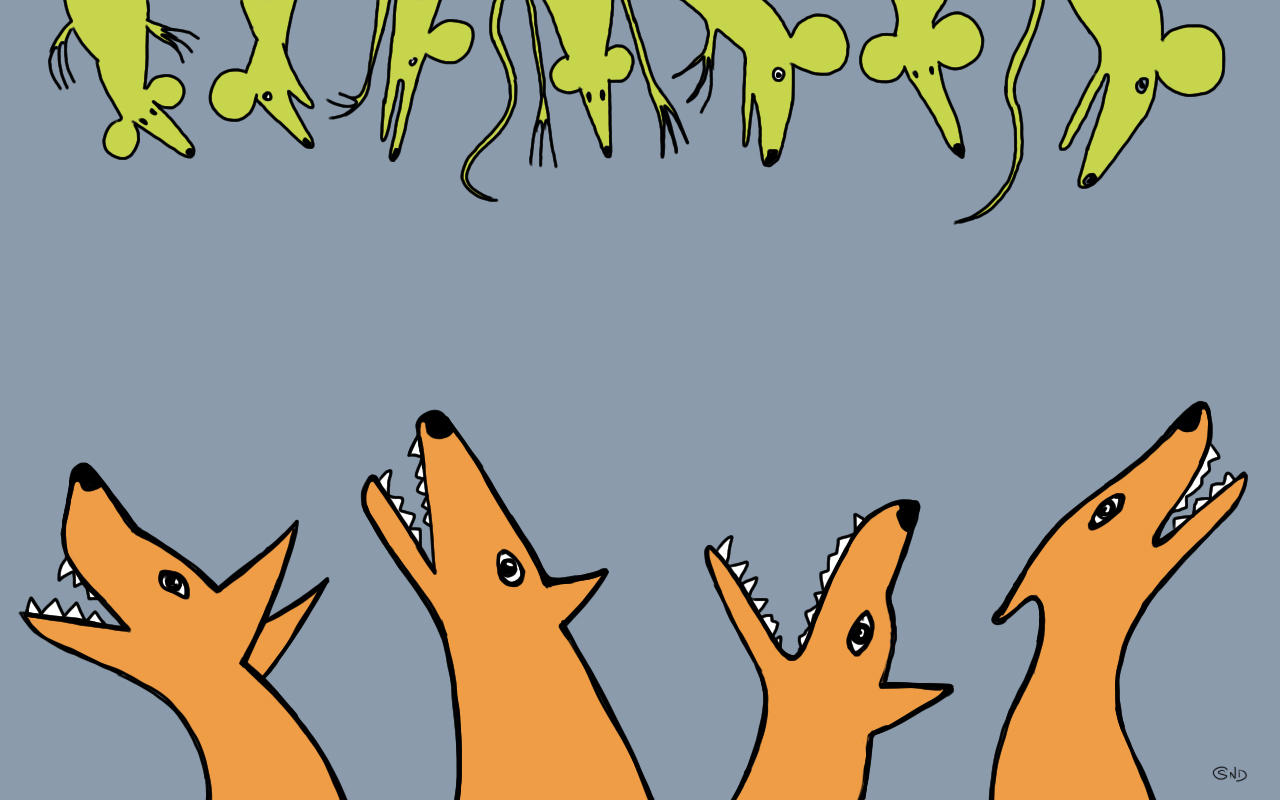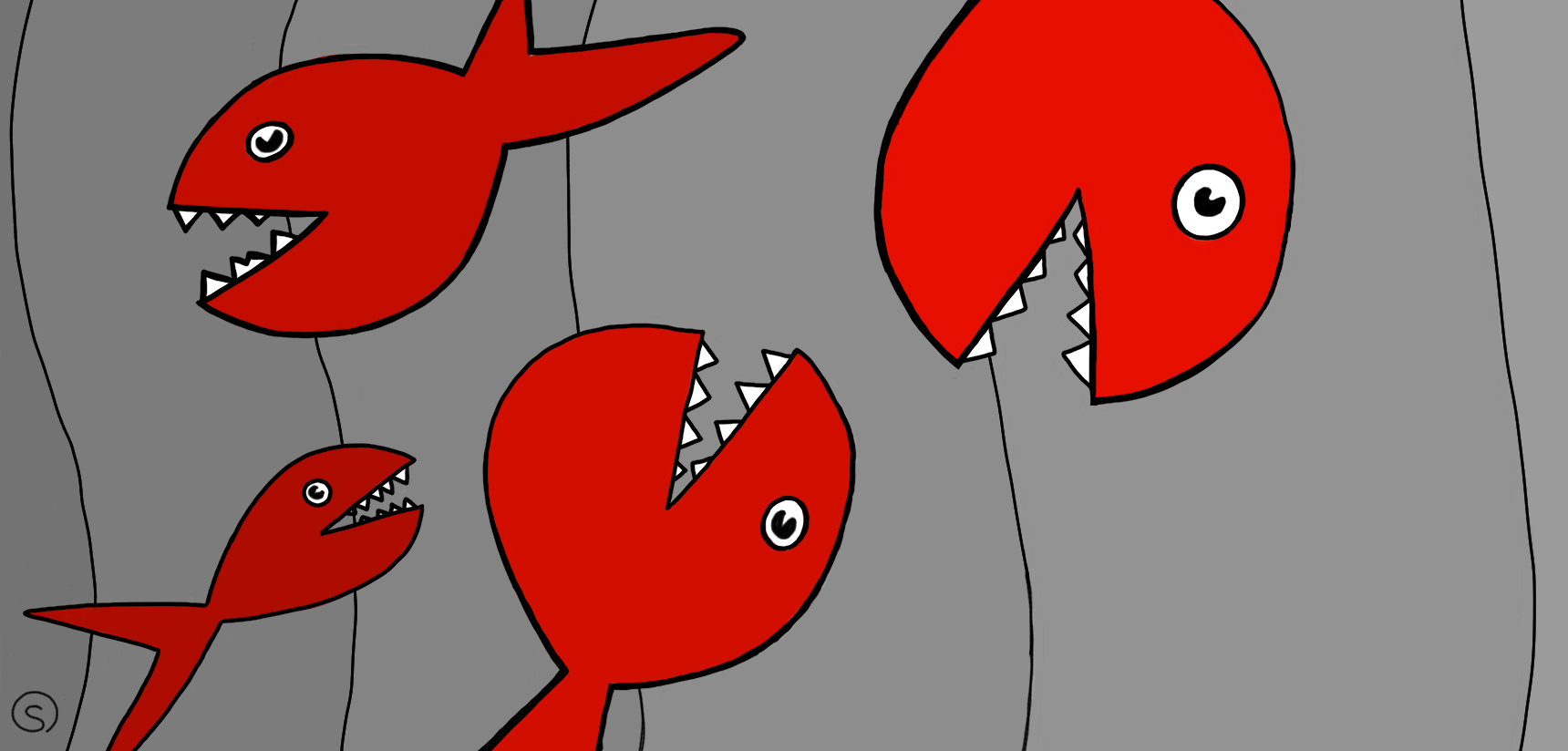di FRANCESCO FESTA e TONI NEGRI.
In tempi di «crisi infinita» ci si interroga ancora sulla compatibilità fra capitalismo e democrazia. All’incirca quarant’anni fa la destra capì che andava riequilibrato il rapporto fra governabilità e democrazia: doveva essere superata la democrazia rappresentativa. Per governare società complesse andavano aumentate le risorse materiali e l’autorità politica dei governi (oggi, il decisionismo alla Renzi o l’autoritarismo della Merkel), e indebolito il controllo parlamentare e giudiziario. Ne seguì l’introduzione di misure per la ripresa di una rapida accumulazione, dopo la parentesi imposta dalle lotte sul salario dell’operaio-massa. Era urgente la riconfigurazione della lotta di classe a livello mondiale. La destra capì che nuove ricette economiche andavano introdotte. L’implosione della forma-salario doveva essere usata per reprimere le lotte operaie ed eliminare via via il conflitto sociale. Nel frattempo, una nuova soggettività doveva essere prodotta, quella dell’“individuo imprenditore di se stesso” per poter corrispondere alla nuove modalità di accumulazione, cioè all’estrazione di profitto dalla cooperazione sociale. La ricetta neoliberista venne poi ripetuta come un mantra, fino a divenire senso comune. Una volta esplosa la crisi, nella forma d’indebitamento delle classi lavoratrici, questa è stata narrata come il prodotto di condotte indisciplinate, non austere, e di stili di vita al di sopra delle proprie possibilità. In realtà, la crisi attuale è piuttosto la rivelazione dell’incontenibile misura dello sfruttamento della cooperazione sociale, e la cronicizzazione della difficoltà dell’”accumulazione bioeconomica”.
Sembra che la linea del progresso umano stia effettivamente percorrendo quel «tempo omogeneo e vuoto» che il liberalismo prescrive. La “terza via” adottata dalla socialdemocrazia europea in risposta all’iniziativa liberale è fallita. E dopo l’esercizio della violenza finanziaria contro la Grecia, sembra che non ci siano altre strade. Eppure occorre ripetere che tertium non datur. In quella microfisica delle lotte, che resistono al destino che il liberalismo esige, abbiamo fra le mani innumerevoli aperture rivoluzionarie. «Riconoscere il segno di un arresto messianico», avrebbe detto Benjamin; o altrimenti, cogliere il succedersi di momenti, di eventi, ossia di esperimenti e di progetti per «far saltare un’epoca determinata dal corso omogeneo della storia»: ecco cosa impone con forza l’ottimismo della ragione. «Un po’ di possibile, sennò soffoco», chiedeva Deleuze. Credere a ciò che può essere pensato e inventato, quand’anche appaia impossibile. Credere a ciò che spinge la trasformazione sociale nella direzione definita dalle aspirazioni di una moltitudine consapevole. Infatti, esiste una fetta di società che non si è abituata alla crisi, che non ha fatto il callo alla povertà e alla precarietà: essa osserva una classe redditiera che non risente gli effetti della crisi, e con la crisi ci sguazza.
Di contro c’è la nostra parte, che rifiuta il mito dello stato e del mercato, non s’illude del mito della società civile, e sta con i piedi ben piantati. Una parte che, col cronicizzarsi della crisi, va via via mettendo in discussione i privilegi, l’idea stessa della proprietà privata, mentre difende le idee di bene pubblico e di bene collettivo, quale passaggio alla costruzione del comune. Cos’è il vaso scoperchiato sui privilegi, la “casta”, le spese pazze, per la “gente”, se non un latente desiderio di comune. La pervasività della corruzione e del clientelismo nelle metropoli, l’incalzare della fiscalità per i reietti e l’azione violenta dello stato per recuperare presunti crediti assumono in molte reti territoriali i contorni di una lotta per la democrazia diretta contro la corruzione e il «comune nocivo». Riecheggia sullo sfondo l’idea zapatista: Para todos todo, nada para nosotros.
Dopotutto le tribolazioni europee hanno dimostrato l’esistenza di un contrasto fra la cornice istituzionale vigente e i bisogni della moltitudine. Le stesse istituzioni comunitarie sono riconosciute come modelli inutilizzabili; la governance europea ne ha superato i limiti, ed ha reso innocue le scelte elettorali, i bisogni partecipativi e gli stessi organi parlamentari. Ciò che teme la classe capitalista è la partecipazione. Quanto più essa è “diretta”, tanto più i padroni sentono sul collo il fiato delle classi subalterne.
Il “luogo comune” europeo sembra sovrastato da un dominio sempre più coercitivo e violento. Quanto ai discorsi pubblici delle classi dirigenti di tutta Europa, questi danno l’impressione di un ipocrita esercizio di persuasione sulla ripresa economica; mentre in realtà l’ordine del discorso consiste nel tentativo di sedare possibili sommovimenti sociali, di anestetizzare il conflitto. Un mantra ossessivamente ripetuto, come nel film La Haine: «Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene». La famosa scena, però, prosegue: «Il problema non è la caduta, ma l’atterraggio».
È giunta l’ora per i movimenti di organizzare l’atterraggio, dal terreno della protesta a quello dell’organizzazione. Ciò significa domandarsi in che modo il desiderio attraversi le lotte e come i dispositivi di traduzione delle passioni in lotte possano concatenare, nelle mutevoli dinamiche dei rapporti di classe, domande di partecipazione e di intervento. Al netto degli afasici episodi elettorali, ciò che è invece palpabile è un ribollire di partecipazione e di attenzione, che non si colloca più nella forma del «soggetto rappresentato». La crisi del capitalismo è tanto più cronicizzata quanto crescente è la domanda di partecipazione.
Atterrare significa paradossalmente dare verticalità all’azione dei movimenti. Conosciamo molte proposte. Vogliamo sottolineare qui che i processi di verticalizzazione non conoscono un unico campo di sperimentazione; e che sarebbe un errore pensare che i modelli possano valere, mutatis mutandis, applicandosi a diverse geografie. Occorre piuttosto che le verticalizzazioni riflettano le asimmetrie dei poteri e dei rapporti di classe nei territori. Molteplici sono le esperienze nelle città europee in cui, dal basso, si costruiscono spazi di contropotere, reti di solidarietà, gruppi e associazioni mutualistiche, coalizioni sociali che contrastano l’impoverimento, la precarietà e la crisi. Sono esperienze di occupazione e di cooperazione su spazi abbandonati, parchi, immobili; esperienze di assemblee di quartiere e di partecipazione diretta, che pongono all’ordine del giorno il tema della decisione da parte dei cittadini. Vi sono poi lotte locali che assumono dimensioni europee e diventano proposte di differenti modelli di sviluppo, che attaccano direttamente i dispositivi di governo, e che, in nome di una ripresa agognata, vogliono appropriarsi il potere degli organi di governo periferici per mettere in movimento la volontà delle popolazioni locali. Sono questi contesti che assumono figura di fabbrica di soggettività antagonista alle politiche neoliberiste. In molti contesti si sente riecheggiare il Que se vayan todos argentino: lo si sente in assemblee di quartiere, agorà cittadine, manifestazioni pubbliche, dove non solo si segnalano i problemi ma si propongono soluzioni di governo e di amministrazione, nel tentativo di attuare nuove forme di contratto sociale e di realizzare un paradigma di democrazia diretta. Questi spazi di dibattito e d’iniziativa hanno credibilità poiché non provengono dalle classi politiche che hanno abbracciato il neoliberismo e che sono state complici della crisi. Spesso sono “situazioni minime” ma che, rispetto ai loro contesti territoriali, assumono grande importanza e costruiscono un senso comune “maggioritario”. Ciò avviene – in forme di resistenza quanto in forma di coalizione – in varie città e quartieri metropolitani, sulla questione della casa, della scuola e dell’università, dell’ecologia dei territori, della gestione dei beni collettivi, ecc.
Ripetiamo il paradosso da cui siamo partiti: per atterrare, cioè per divenire maggioritari in maniera viepiù egemonica, per operare ottenendo risultati concreti, i movimenti (soprattutto “minimi”) necessitano di collegarsi e di portare il loro discorso, in verticale, contro il potere neoliberale. Integrare la verticalità al movimento significa atterrare. Quanto abbiamo bisogno di una nuova opzione politica dei movimenti, di un espresso desiderio di potere! Una volta atterrato, un aereo dovrà pure prepararsi a ripartire, ad andare in alto – e cosi faremo anche noi. Questo movimento dal basso verso l’alto è quello che c’interessa, e sappiamo che per farlo abbiamo bisogno di integrare l’esperienza dell’atterraggio – come stile del nostro lavoro.
Anche in Euronomade, a noi sembra che si presenti il compito di narrare le lotte, incluse quelle “minime”: insomma di ricomporre modelli di narrazione di lotte presenti che prefigurino la potenza di quelle future.