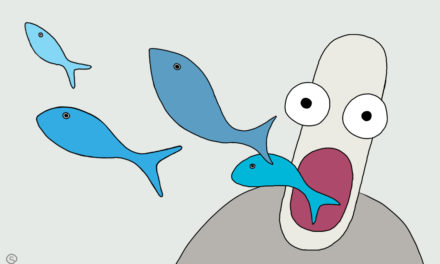Di ROSELLA SIMONE
Ciao Emilio, nipote caro
non ricordo esattamente quando siamo diventati parenti, è stato un po’ per gioco, e un po’ per mettere in chiaro che i legami, quelli che contano, ce li sceglievamo noi, che non ci legava la grettezza di chi conta sull’eredità, né quella cosa ambigua che è la consanguineità. Ci univa la direzione dove volevamo andare, compagni di viaggio per un’avventura lunga la vita, per provare a cambiare, dal basso, il corso della Storia e vedere, finalmente, vincere Spartaco invece delle aquile di Roma, la sua gloria e i suoi massacri.
A vent’anni te ne andavi per Genova spavaldo e indifferente, riccioli neri e una faccia da schiaffi da far girare la testa, in jeans stretti, camicia bianca aperta sul petto e un foulard azzurro cielo annodato al collo, praticamente un’arma di seduzione di massa. Ci si conosceva, ma “parenti” lo siamo diventati a Marassi nel 1976, prima del diluvio. Io ero in cella con la tua coimputata Enza Siccardi, tu al transito e Giuliano Naria, allora il mio compagno, in isolamento. Ce lo hanno tenuto tre mesi e tu con tanti “bravi ragazzi” avevate provato a liberarlo. Deve essere stato allora che siamo diventati parenti. E lo siamo rimasti, sempre.
Poi sono arrivati gli anni ottanta. Un disastro, per coloro che avevano sognato insieme, non so dire se la rivoluzione o qualcosa di ancora più radicale, come il rifiuto di ogni conformismo, della rassegnazione, della umiliazione della servitù volontaria; che avevano avuto il coraggio di provare una idea di libertà, di credere in un’etica delle relazioni e di combattere per le proprie visioni.
Gli anni settanta se n’erano andati lasciando tradimenti ed eroina. Non sei mai stato uno che si arrende e hai fatto del tuo corpo “la tua casa e la tua corazza”. Il body building è stata una scelta di rigore, e anche un altro luogo di incontri non convenzionali, impreviste aree di resistenza.
Allora cavalcavi una Yamaha XT, dietro, allacciata con gli elastici, la sacca da ginnastica. Ogni tanto passavi da Garlenda, in sella portavi una bella ragazza, un amico e poi te ne andavi, lasciando scie di allegria.
A un certo punto, non so come, mi sei diventato un intellettuale raffinato e molto leninista. Un po’ troppo per me che ti amavo più lieve. Mi hai spiegato, o almeno è questo che ho voluto capire, che, nei tuoi libri (ne hai scritti tanti) ponevi, a chi si assume la responsabilità dell’azione, un quesito radicale: puoi farlo solo se hai un progetto, un’etica e tanto rigore. Era, insomma, una provocazione e una consegna al futuro. Passavi, insomma, a chi sarebbe venuto “dopo” quelli che per te erano i “fondamentali”.
“Andare ai resti” dei tuoi libri è il mio preferito, racconta gli anni settanta, come nessuno mai è stato capace di fare e una geografia che non esiste più. Racconta Genova e i suoi quartieri e i figli irrequieti di una classe operaia garantita con la tessera del Pci in tasca. Figli con il guizzo di guardare oltre l’orizzonte, che volevano pane, companatico e anche le rose, tante, rosse, sempre fresche. Una generazione che “per l’avventura aveva il passaporto”.
Più giovani della generazione che occupava le università nel ’68, quella di Gianfranco Faina, quella di Clara, di Enza, di Giuliano o quella di Daniele Joff e Paolo Broggi (a Emilio piaceva Lotta continua) ma simili nel rifiuto all’autoritarismo, naturalmente antifascisti, con la voglia di un sapere nuovo, svecchiato, visionario, di relazioni non opportunistiche fondate sulla fiducia e sull’amicizia.
Ad assistere Emilio – un Emilio pallido, gonfio che riprova a credere che la guarigione fosse possibile, sofferente senza un lamento, cazzeggiando con ironia un po’ di politica, un po’ della Sampdoria, un po’ dei suoi libri che sarebbero usciti postumi -, a dormire con lui, a preparare i pasti perché la moglie Eugenia potesse prendersi qualche giorno di riposo, c’erano due mitici avanzi di galera, Claudio e Bruno, duri con i cattivi, con Emilio badanti teneri e presenti come mamme. Con una intimità rispettosa e pudica del corpo dolente dell’altro che mi ha sorpreso e commosso. E c’era la Betta, capace di farlo sorridere anche nei momenti più delicati, quelli in cui il corpo malato è costretto a esporsi indifeso, in tutte le sue miserie.
Emilio ne era estasiato, mi mandava le foto di lui con Bruno, arrivato sorridente dopo 50 anni esatti di galere e latitanza, e scriveva: “Ciao Zietta, le foto che ti ho mandato dimostrano quanto imprevedibile sia la vita ma anche come ci sia un nocciolo duro nelle cose, decisamente inossidabile. 50 anni sono più di una vita, eppure ti ritrovi come fosse ieri, in maniera assolutamente normale come se invece di essere a casa mia fossimo al Transito di Marassi”.
Gli anni settanta hanno costruito anche questa “comunità del Fronte”. Aver vissuto quel tempo è stato un privilegio che il disgusto del presente non ci toglierà. Forse degli illusi, miserabili mai.
Pubblicato anche per Effimera.