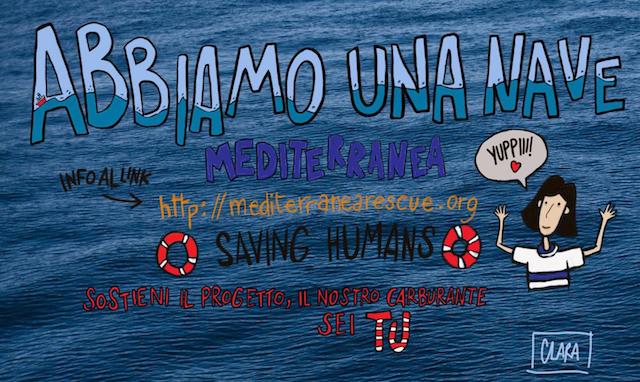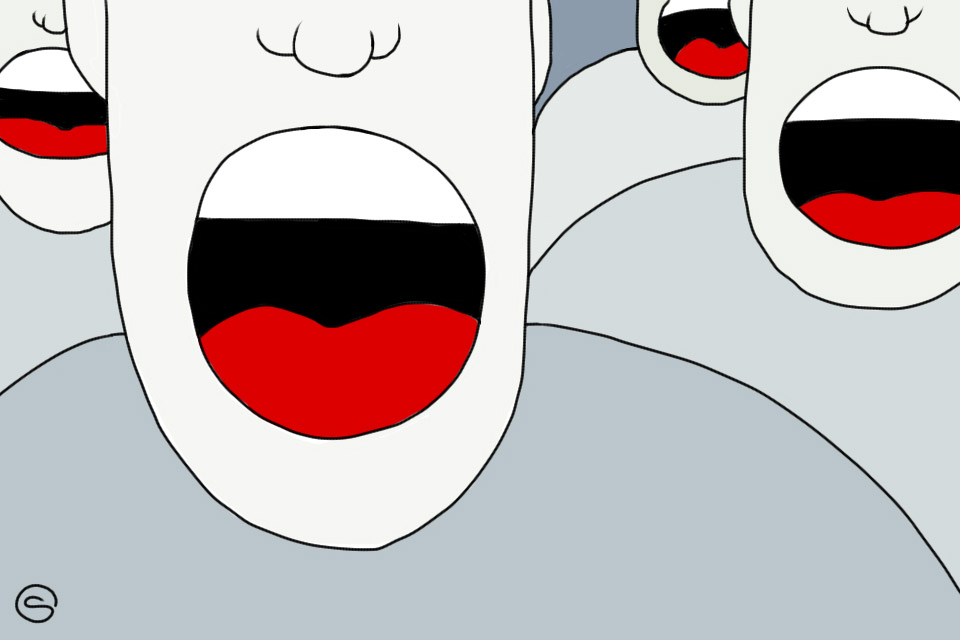di ENRICA RIGO e ALBERTO DI MARTINO.
Il diritto di migrare (anche fuggendo) – ovvero, «il diritto di lasciare qualunque paese, incluso il proprio», come recita la Dichiarazione del 1948 – è stato la formula di garanzia che il diritto internazionale post-bellico aveva trovato come antidoto agli orrori che avevano portato alla seconda guerra mondiale e ai suoi lasciti. Anche attorno a quel diritto, (…) l’Occidente ha costruito la differenza tra i regimi liberticidi e le democrazie baciate dai lumi del diritto e della libertà.
Quell’assetto è evidentemente saltato. Non solo perché l’immigrazione irregolare è criminalizzata (fatto che si considera ormai dato per scontato e casomai soltanto da ‘governare’ con gli strumenti dello stato di diritto); ma – proprio in questi giorni – perché sul mare sono state messe in atto condotte che potremmo dire di ‘polizia bellica’. È di ieri la notizia che la marina militare del Marocco ha aperto il fuoco su una barca di migranti, ferendo un ragazzo di 16 anni, mentre solo pochi giorni fa, in un episodio analogo, era morta una ragazza e altri tre migranti erano rimasti feriti. Meno eco ha avuto, nei giorni della Diciotti, la notizia di un violento scontro, il 17 agosto, tra la guardia costiera tunisina e un gruppo di migranti che tentava di prendere il mare verso l’Italia. Nei giorni successivi, solo qualche sito specializzato ha chiarito la dinamica dei fatti, riferendo che il numero delle vittime tra i migranti era salito a 8. La nave Mare Jonio, dell’operazione Mediterranea, ha riacceso i riflettori in questi giorni sulle intercettazioni dei migranti da parte delle motovedette fornite dall’Italia alla guardia costiera libica; dotazioni che ci rendono complici, se non di fatti violenti in sé, certamente del fatto di impedire, anche in questo caso, la fuga verso l’Europa. Gli esiti hanno comunque una frontale evidenza: questo stesso giornale ha pubblicato un impressionante ‘supplemento’ riempito solo dalla lista dei 34.361 morti documentati in relazione all’attraversamento di frontiera a causa delle politiche di chiusura dei confini.
(…) Che cosa accomuna queste vicende? L’assetto del diritto si è evidentemente trasformato senza che si sentisse il bisogno di modificare le grandi dichiarazioni di principio: un processo di svuotamento strisciante e insidioso del diritto di fuggire. Esso consiste nell’etichettare come illeciti gli attraversamenti dei confini, in ingresso, e conseguentemente aver la libertà di combatterli in uscita dagli Stati: polizia bellica in supporto preventivo della polizia criminale. Una prospettiva inedita, questa, che è stata di recente riaffermata dall’Assemblea dell’Onu con la New York Declaration for Refugees and Migrants, del settembre 2016, dove l’agenda di una governance globale dei “movimenti di massa” riconcettualizza le migrazioni come prevalentemente involontarie, sancendo la complementarietà delle politiche di asilo, migrazione e controllo dei confini.
Da un lato si riconosce un livello senza precedenti di movimenti degli esseri umani, costretti da ragioni di povertà, instabilità, marginalizzazione, esclusione, spoliazione, dall’altro si riconosce agli Stati il diritto di prevenire ingressi irregolari. Atteggiamento contraddittorio perché questi “large movements” non possono che essere ‘irregolari’, se si adotta la logica del controllo del confine.
Difficile dire se, in questo processo, l’enfasi sulla repressione del traffico di esseri umani e della tratta (in inglese rispettivamente smuggling e trafficking) sia un esito o sia servita (e serva) da apparato discorsivo di giustificazione. Difficile dire, in altri termini, se sia il traffico degli esseri umani a dover essere fermato, o se, dietro il tentativo di fermarlo, non vi sia una indebita compressione del diritto di fuga, giustificata dalla presunzione che ogni movimento transfrontaliero sia illecito e come tale non possa che avvenire grazie a una regia illecita.
La logica del diritto penale finisce con l’essere una calotta interpretativa della realtà; ma ci si dovrebbe chiedere più spesso e più a fondo se proprio questo atteggiamento, ad esempio, non sia paradossalmente esso stesso tra le cause del radicarsi di fenomeni illeciti che suppliscono la mancanza di servizi leciti (taluno parla di human rights externalities, di danni collaterali al rispetto dei diritti umani, derivanti da ipercriminalizzazione). Anzi, almeno quando il traffico si risolve nella corretta prestazione di un servizio di ‘passaggio’ (e serissime indagini empiriche lo dimostrano: si vedano i lavori del criminologo di Oxford Federico Varese), la criminalizzazione non punisce ma produce illegalità, e anzi proprio lo svolgersi nell’ombra finisce con il favorire il transito verso situazioni di rischio per il migrante, come il divenire vittima di tratta e, spesso, di sfruttamento lavorativo o per prostituzione. Qui l’uso del diritto penale rischia di diventare il velo ipocrita che nasconde i veri obblighi dello Stato: non di mero salvataggio di vittime, ma di attore primario della regolazione che deve stabilire politiche efficaci, soprattutto quanto ad allocazione di risorse, sull’ingresso, sull’inserimento, sulla formazione, sulle condizioni di lavoro, sulle pratiche di impresa.
Il meno che si possa fare è dire che ci vuole meno diritto penale e comunque, sin d’ora, maneggiare con circospezione e self-restraint gli arnesi della repressione. Ad esempio, quando la fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina venne introdotta in Italia, non furono in pochi a denunciare il rischio di criminalizzazione delle reti di solidarietà e sostegno, in primo luogo di quelle tra i migranti stessi, dal momento che la condotta di favoreggiamento dell’ingresso sul territorio, per essere integrata, non necessita neppure dello scopo di lucro.
È vero che, nel nostro ordinamento, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria; ma anche in questo caso il terreno di discussione rischia di farsi sdrucciolevole.
Di fronte a una repressione del diritto di migrare che arriva a mettere a rischio la vita, o addirittura a uccidere, dove si collocano, per mare e per terra, i confini del soccorso e dell’assistenza umanitaria? Resta l’applicazione del soccorso di necessità come causa generale di giustificazione per la commissione di reati: la si valorizzi il più possibile. Questo vuol dire che anche chi realizza formalmente una fattispecie di trasporto di migranti illegali, per sfuggire a condizioni di prigionia e di tortura in attesa di imbarcarsi, è quantomeno giustificato.
Su queste basi sono estremamente apprezzabili le decisioni dei giudici palermitani, riportate dalla stampa, che hanno pronunciato sentenze di assoluzione proprio applicando la logica dello stato di necessità. E si potrebbe essere ancora più radicali e dire che in casi come questi non si compie affatto un reato; ma, appunto, una condotta di salvataggio: perché chi trasporta persone che fuggono da prigionia e tortura compie un fatto lecito e non illecito (anche se ‘giustificato’).
E ancora: se le dimensioni del fenomeno sono quelle, sconcertanti e disperanti e vergognose, di decine di migliaia di morti, ci si può attrezzare almeno, e davvero in piccolo, per una restrittiva ma serissimamente argomentabile interpretazione delle condotte di favoreggiamento. Prendiamo il diritto italiano: vero che è punito anche soltanto il compiere atti «diretti a procurare illegalmente l’ingresso» nel territorio di stranieri; ma questo solo se quegli atti sono commessi «in violazione delle disposizioni» in materia di immigrazione. Violare ‘altre’ regole a quello stesso fine non può e non deve costituire favoreggiamento.
Interpretazioni capziose, pretestuose come spesso erano le sfide a duello, si dirà; le lanciamo tuttavia, e le riceviamo volentieri: ne va della causa di trentamila morti.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 14 novembre 2018.