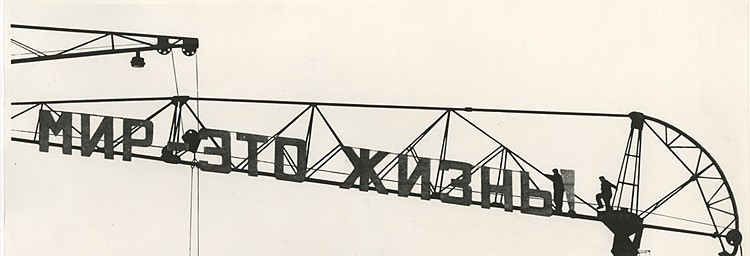Intervista di UGO ROSSI con CLAUDIO MORRISON
In questa intervista dialoghiamo con Claudio Morrison, studioso di sociologia del lavoro, migrazioni e conflitti sociali con specializzazione nell’area post-socialista. Dopo essersi laureato in Politica Comparata con Rita Di Leo all’Istituto Universitario Orientale (ora Università L’Orientale) di Napoli, Claudio ha lavorato in Russia, per poi trasferirsi in Gran Bretagna dove ha conseguito un PhD in Sociologia all’università di Warwick, seguito da un post-dottorato dell’Accademia Britannica, specializzandosi nello studio di sistemi d’impresa, relazioni industriali e rapporti di classe nelle repubbliche post-sovietiche. Oggi è ricercatore presso la scuola di economia e commercio della Middlesex University, a Londra. Claudio ha svolto numerose ricerche sul campo nell’ex-URSS, studiando migrazioni, ristrutturazioni industriali e conflitti sindacali, privilegiando il punto di vista operaio. Tra le molte pubblicazioni di cui è autore ricordiamo il libro A Russian Factory Enters the MarketEconomy (Routledge, 2012). Utilizzando il metodo etnografico, il libro ricostruisce la privatizzazione di un’impresa tessile russa dagli anni Novanta, mostrando l’ambivalente natura della ristrutturazione capitalistica. La meticolosa ricognizione tanto dell’organizzazione del lavoro e d’impresa quanto degli spazi economici e sociali esterni, restituisce un quadro in cui i nuovi indirizzi neoliberisti si intrecciano con pratiche ereditate dal periodo sovietico, in maniera solo apparentemente contraddittoria.
L’ambivalente transizione all’economia di mercato che tu hai studiato dal punto di vista dell’organizzazione d’impresa e delle relazioni industriali può essere estesa anche alla complessa integrazione della Russia nell’economia globalizzata e alle relazioni internazionali conseguenti di cui è stata protagonista?
Certamente, “transizione al mercato” significa a una scala micro estensione dei rapporti capitalistici di produzione. A livello statuale la transizione al capitalismo include la trasformazione dell’ex compagine sovietica in Stati nazionali e la loro integrazione separata nelle reti globali. Si tratta di un processo complesso, contestato e necessariamente di lunga durata che solo una visione unitaria attenta alle contraddizioni può comprendere. Le discipline e il pensiero dominante di matrice liberale, la cosiddetta transitologia, assumendo il “mercato” e lo Stato nazione come entità naturali non è capace di problematizzare questi processi. In che cosa consiste l’ambivalenza? Per molti è una confusa mescolanza di passato sovietico e di un nuovo non ben definito: mercato ma anche oligarchi, informalità e corruzione, nuovo Stato ma anche “totalitarismo”, insomma un passato che non passa, una “democrazia di mercato” sempre a rischio di due passi indietro. I rapporti sociali di produzione restituiscono una visione chiara di cosa cambia e perché: il potere contrattuale del lavoro è crollato, l’informalità socialista fondata sul controllo operaio ora è strumento di intensificazione manageriale; si è passati da una politica di incentivi premiale a un sistema punitivo. I dati statistici che ho preso in esame nelle mie ricerche provano il crollo dei salari e della motivazione sul lavoro, altri studi attestano il passaggio dal paternalismo socialista all’autoritarismo manageriale dell’impresa oligarchica. Le multinazionali dell’automobile lamentano conflittualità operaia e bassa produttività. L’osservazione delle relazioni industriali dimostra che i conflitti industriali cancellati dallo statuto del lavoro sono cresciuti costantemente nell’ultimo decennio malgrado la cooptazione e repressione dei sindacati. A livello macro, queste pratiche riflettono e riproducono mancanza di investimenti e di politica industriale e ripiegamento sull’export di materie prime e beni intermedi. Semplificando al massimo, la forma politica dominante del capitalismo oligarchico post-socialista è l’etno-nazionalismo, con una destra reazionaria e revanscista, che permette un trasferimento delle contraddizioni economiche e conflitti irrisolti in tensioni aggressive verso “l’altro”, uno schema già visto nella conflagrazione della ex-Jugoslavia.
Cerchiamo di capire più a fondo la transizione economica della fase successiva alla fine dell’URSS e le spinte disgregative da essa generate. Un momento fondamentale della transizione post-sovietica è lo scioglimento nel 1991 del Comecon – l’organismo che rappresentava i paesi dell’ex Patto di Varsavia – cui è seguito un progressivo indebolimento dei rapporti economici della Russia con i paesi dell’Europa orientale. Da parte sua, la CSI (Comunità di Stati Indipendenti), che oggi include nove paesi, nel corso del tempo ha ridimensionato il proprio ruolo, perdendo due importanti stati membri: la Georgia dopo la guerra con la Russia del 2008 e l’Ucraina dopo la crisi del 2014. Infine vi sono le spinte centrifughe all’interno della stessa Federazione Russa, con nuove tensioni regionali derivanti dalla richiesta di maggior potere da parte dei distretti autonomi più periferici, come il circondario della Čukotka, nell’estremo Oriente russo, ricco di riserve di gas e minerali (governato fino al 2008 dall’oligarca Roman Abramovič), che nel ’91 si separò dall’oblast di Magadan. Su queste dinamiche disgregative si sono innestati prepotentemente i fattori identitari – etno-nazionali e religiosi – venuti alla luce a partire dagli anni Novanta, negli anni della transizione.
Una risposta sui processi di disgregazione e riaggregazione su nuove basi capitalistiche, ossia tramite catene del valore, imprese multinazionali e istituzioni di supporto eccede le mie competenze e sicuramente richiede una ricerca impegnativa. Posso rispondere su due piani. Sociologicamente, le spinte centrifughe sono la chiave di volta della “transizione”; chi l’ha vissuta la chiama razval (lo sfascio). In Occidente non si ha comprensione di quanto sia stata profonda e destabilizzante. Il principio guida era di abbandonare ogni relazione a favore della mera convenienza economica di breve periodo. Già nel 1990 questa scelta generò la paralisi immediata dell’economia sovietica. Il mio studio su un’economia regionale, il distretto tessile di Ivanovo a cavallo del secolo (1997- 2013), mostra come gli oligarchi e le autorità di Mosca ne abbiano approfittato. Le imprese di beni finali e intermedi sognavano l’accesso a un mitico mercato, si trovarono invece senza sbocchi, finanziamenti o fornitori sicuri. La crisi finanziaria del 1998 [la crisi finanziaria russa che portò alla svalutazione del rublo e al default del debito nazionale, NDR] permise a chi controllava risorse liquide – banche, guadagni illeciti, materie prime – di assumere il controllo della distribuzione e poi delle aziende in crisi. La normalizzazione ha poi proceduto su due gambe: Mosca concedeva a gruppi locali il controllo illimitato del business in cambio di sostegno politico (anche con il ricorso a brogli elettorali) e pace sociale (alta occupazione e repressione dei conflitti sociali). L’uso politico degli oligarchi anche nei paesi vicini – Moldavia, Ucraina, Armenia, repubbliche post-sovietiche dell’Asia Centrale – ne è la prova, ma dimostra anche i limiti di questa strategia rispetto a quanto fanno “Occidentali” e Cinesi, mancando le pratiche inclusive dei primi o il volume di investimenti dei secondi.
Consideriamo il fattore linguistico nel processo di disgregazione dell’area. Ad esempio, in Ucraina la strategia delle élites nazionali è stata di espandere la diffusione della lingua nazionale, ottenendo tassi di crescita annua piuttosto sostenuti. A questa strategia di nazionalizzazione della popolazione, la Russia ha risposto scoraggiando il ritorno in patria dei “piedi rossi”, cioè dei russofoni residenti nelle regioni orientali del paese come il Donbass, ricco di risorse minerarie, al centro del conflitto russo-ucraino.
Lo studio dei processi migratori all’interno dell’ex Unione Sovietica verso la Russia mostra una dinamica complessa. Il mercato del lavoro russo, come del resto quello di paesi europei come l’Italia, è diventato dipendente dalla migrazione in settori e segmenti occupazionali soggetti ad alto sfruttamento di manodopera. La politica si è dovuta adeguare malgrado le spinte razziste. Per compensare il crollo demografico, si è poi passati dal favorire migrazioni circolari alla stabilizzazione dei migranti di origine slavo-europea ma in aree periferiche. Alcuni sostengono che la circolazione dei migranti russofoni sia stata pressoché la sola forma di integrazione dello spazio post-sovietico. La crisi in corso certamente la mette in discussione, avendo come esito inevitabile la riaffermazione dei confini nazionali come spazi etno-nazionali esclusivi piuttosto che il loro superamento. Da parte russa, la proiezione dei confini è estesa a quelli che l’ideologia euroasiatica chiama “spazi di civiltà” contrapposti. L’Ucraina in alcuni testi russi era da tempo vista come uno spazio perduto.
Il crollo dell’URSS fece esplodere immediatamente la polveriera caucasica: nel 1992 il conflitto tra Ossezia Settentrionale e Inguscezia (entrambe repubbliche della Federazione Russa), poi la Cecenia, il conflitto tra Daghestan e Cecenia, la guerra russo-georgiana del 2008 sull’Ossezia meridionale, il conflitto tra Armenia e Azerbaigian per il controllo del Nagorno Karabakh ancora in corso oggi.
Poi si parla poco dell’instabilità interna alla Russia. La costituzione del 1993, che soppresse il sistema istituzionale sovietico, disegnò una maglia amministrativa molto intricata. Secondo molti analisti, questo impianto avrebbe poco a vedere con un assetto genuinamente federalista. Piuttosto, ha alimentato una tendenza alla “localizzazione del potere”, per cui le élites locali e regionali contrattano continuamente con il potere centrale i propri spazi di manovra. All’interno della Federazione però i fattori etnici sembrano giocare un ruolo secondario, mentre più rilevanti appaiono gli interessi economici regionali e localistici.
I conflitti nell’area del Caucaso, sia all’interno della Federazione Russa che nei territori confinanti, hanno certamente radici culturali e storiche specifiche ma politici ed analisti mainstream come spiegato prima ne ignorano le basi materiali e quindi rischiano di appiattirsi sulle narrazioni etno-centriche e nazionaliste delle tensioni in gioco. La promozione di interessi di gruppi locali e la reinvenzione di nazioni ed etnie come strumento di mobilitazione politica e subordinazione economica sono sempre alla base di questi conflitti, il che spiega perché dove un centro forte è riuscito a intervenire e non ha cercato lo scontro, l’interesse è soddisfatto senza radicalizzazione. Un caso che ho riscontrato nella mia ricerca esemplifica il processo. Gli operai moldavi mi spiegarono come i separatisti della Transnistria [la regione russofona che a seguito della guerra del 1992 si è staccata dalla Moldavia, autoproclamandosi indipendente, NDR] imponessero alle fabbriche di rimuovere i non-slavi da posizioni di rilievo, a cui loro contrapponevano il diritto e i vantaggi della mobilità operaia nello spazio sovietico. Curiosamente poi alcuni finivano per lavorare per imprese occidentali in Russia o Moldavia. La restaurazione di relazioni di potere classiste ovviamente non può essere l’unica chiave interpretativa della “etnicizzazione” del potere nell’esercizio del comando economico e politico, ma ne è certamente un motore fondamentale. L’analisi dell’operato delle potenze storicamente susseguitesi in queste aree quindi non può prescindere dall’analisi del modo di produzione e dell’ordine sociale corrispondente. Lo sviluppismo del socialismo sovietico, con tutti i suoi limiti, aveva generato integrazione. Lo sguardo sulla odierna frammentazione va quindi ribaltato considerandolo come sottoprodotto della politica neo-coloniale di “sottosviluppo” operata dagli attuali centri capitalistici, presunti stabilizzatori, che siano russi, turchi o occidentali.
In che misura, questo complesso quadro che abbiamo fin qui delineato ha influenzato i rapporti della Russia con le altre potenze che si fronteggiano a livello internazionale: in primo luogo con gli Stati Uniti e la Nato, di cui la Russia dai tempi del dissolvimento dell’URSS teme l’espansione a est, e con la Cina, che diventa sempre più centrale sul versante asiatico.
Il rapporto tra Russia post-sovietica come rinascente stato capitalistico e le altre potenze è tanto complesso quanto in rapida evoluzione dopo un’apparente stasi nella fase di consolidamento interno sotto la leadership putiniana. Come sociologo e antropologo comunista, non esploro il terreno specifico delle dinamiche politico-partitiche e i relativi risvolti diplomatici. Dal mio punto di vista, il problema di fondo è stato, ed è, la globalizzazione di impronta occidentale come neo-colonialismo “a macchia di leopardo”, che persegue l’integrazione separata e differenziata di territori, settori economici e gruppi sociali senza una visione d’insieme, con l’effetto di esacerbare i processi disgregativi precedentemente accennati. Osservandola dall’ex-URSS, e dal basso, posso offrire alcune osservazioni e ipotesi di lavoro. L’integrazione della Russia nella comunità delle “nazioni civilizzate”, ossia nello spazio privilegiato delle potenze capitalistiche, è stata certamente un’aspirazione condivisa nell’URSS al principio della transizione, ma si è dimostrata quasi subito illusoria. Di fronte alle sfide della competizione economica e gestionale, i quadri post-sovietici hanno capito quasi subito, nei tragici anni Novanta, che l’Occidente non voleva sostenerne la modernizzazione. Si trattava di fare solo affari con l’Occidente e per di più a condizioni sfavorevoli. Per gli oligarchi che li hanno rimpiazzati, e non solo in Russia, questo non sarebbe stato un problema se non per il cortocircuito con il potere politico. Infatti, laddove nazionalisti e le componenti più sfacciatamente predatorie delle élites economiche hanno “agganciato” l’espansione neo-coloniale occidentale, l’integrazione è proceduta. Gli economisti istituzionalisti, che radicali non sono, non a caso classificano i paesi dell’Est Europa come “economie dipendenti”. D’altro canto, il deficit democratico o gestionale non è un problema per i colonialisti, vedi paesi satelliti balcanici come Bosnia-Erzegovina o Kosovo ma anche Ungheria o Polonia. Il riorientamento russo verso la Cina, la preoccupazione per uno “spazio vitale” nel cosiddetto “vicino estero” degli ex paesi socialisti, riflettono l’interiorizzazione di questo “transnazionalismo competitivo” promosso dall’occidente neo-liberale. L’ideologia revanscista e fascistoide della civiltà eurasiatica assunta dalle élites russe ne è solo la veste ideologica locale.
Secondo alcuni analisti, dopo il dissolvimento dell’URSS l’Occidente aveva tre opzioni di interazione con la Russia post-sovietica: la politica di “neo-contenimento”, privilegiata da settori dell’intelligence statunitense che sono diventati via via sempre più influenti, volta ad alimentare la disgregazione dello spazio post-sovietico; una politica di “integrazione”, volta a integrare la Russia nello spazio europeo; una politica di “integrazione controllata”, volta sì alla cooperazione con la Russia ma relegando quest’ultima in una funzione ridimensionata di junior partner. Quale di queste opzioni ha prevalso e come si sono confrontate tra loro?
L’idea delle opzioni mi sembra abbastanza illusoria rispetto all’effetto cumulativo delle scelte reali, quelle sulla globalizzazione, sul funzionamento del capitalismo e sul perseguimento della Guerra fredda secondo il modello delineatosi durante i regimi di Thatcher e Reagan. Si tratta dell’abbattimento del welfare state, dell’espansione deregolata del capitale, della ricostruzione della politica come conflitto su basi identitarie e, più da vicino, il rilancio su queste nuove basi del neocolonialismo. L’integrazione della Russia così come il tentativo di subordinazione e l’esigenza del contenimento non si escludono a vicenda, oggettivamente si integrano e si susseguono via via che le contraddittorie dinamiche della globalizzazione competitiva interagiscono con i rapporti orizzontali tra stati-mercato, da una parte, e le tensioni tra soggetti disposti verticalmente sulla scala sociale interna, dall’altra. La natura contraddittoria e oggettiva di questi processi possono forse spiegare perché la razionalità soggettiva e mercantile assunta dagli analisti borghesi a metro di giudizio di tutti i fenomeni è qui uno strumento analitico spuntato. Perché i Russi hanno lasciato andare il Baltico, facilmente controllabile, ma si sono impuntati sull’Ucraina fuori tempo massimo e oltre i limiti della decenza umana? Perché l’Occidente capitalistico ha accolto a braccia aperte gli oligarchi neo-zaristi perseguendo contemporaneamente la colonizzazione neoliberale dell’Ucraina? Come l’Occidente ha potuto apprezzare il comune orientamento consumista, e anticomunista, delle élites post-socialiste senza notare la rotta di collisione delle rispettive compagini statali nazionaliste? E ancora, perché l’Unione Europea che pure ha cognizione dei problemi di coesione inter-statale al suo interno non si è posta il problema degli squilibri e delle tensioni nell’area post-sovietica?
Quanto alle sinistre europee, verrebbe da osservare che sembrano intrappolate tra narrazioni borghesi che riciclano l’arsenale della guerra fredda in salsa umanitaria e i satrapi dell’Est che rimescolano passato socialista ed etno-nazionalismo per distogliere lo sguardo dal loro capitalismo di stile sudamericano. La condanna dell’espansionismo di segno NATO/UE pur valida è superficiale se ignora i processi a livello regionale che ho evidenziato in precedenza e quindi le responsabilità del capitalismo neoliberale e lo snaturamento dei processi di democratizzazione dello spazio europeo che se pur contraddittoriamente erano proceduti fino al 1989.