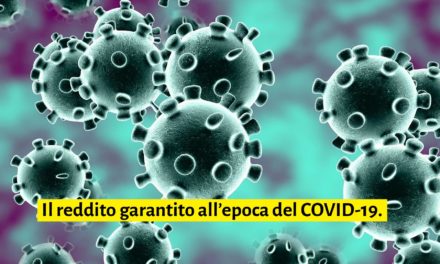di VERONICA GAGO e DIEGO SZTULWARK.1
13/11/2012
Toni Negri è un visitatore frequente e appassionato dell’Argentina e dell’America latina. Dopo una conferenza a Buenos Aires (Universidad de Avellaneda), ha partecipato al IX Coloquio Internacional Spinoza (Universidad Nacional de Córdoba, per proseguire il suo cammino in Ecuador e Colombia. Nell’ultimo decennio, infatti, questo continente gli sembra uno spazio di sperimentazione politica che merita essere seguito da vicino. Dai movimenti sociali ai governi che seguirono i momenti di crisi nella regione, Negri dispiega un’interpretazione di una relazione che è stata virtuosa e che si trova oggi messa alla prova da una sorta di stabilizzazione. Possiamo sintetizzare in questi termini la domanda che avverte come fondamentale: come fare in modo che i servizi del benessere sociale – o welfare (dai sussidi ai servizi sociali) non siano meramente concepiti dall’alto, ma piuttosto sostenuti e valorizzati come retribuzione di un valore sociale di cooperazione dopo essere stati conquistati dalle mobilitazioni popolari? Nella concezione negriana, neoestrattivismo, moltitudini e moneta del comune s’intrecciano per pensare le nuove forme della produzione e lo scontro determinato dal comando del capitale finanziario.
Alcuni anni fa proponevi un’ipotesi per comprendere la situazione politica in Sudamerica: dicevi che c’era un attraversamento dello Stato da parte dei movimenti sociali. In questo modo, il potere costituente dei movimenti poteva svilupparsi, seppure in modo conflittuale, all’interno del potere costituito. Oggi parli di stare “dentro e contro” lo Stato. Come leggi attualmente questa relazione tra potenza popolare e Stato?
Credo che quando si dice “dentro e contro” si fa una affermazione metodologica che deve essere sempre confrontata con le determinazioni concrete. Non è che “dentro e contro” significhi sempre la stessa cosa, si tratta piuttosto di adottare una prospettiva da cui guardare le cose. Ho l’impressione che, sia dal punto di vista della gestione economica sia di quella politica, si è assistito, negli ultimi anni, a un relativo deterioramento della situazione iniziale che aveva preso forma dopo il 2001 e che era una situazione effettivamente rivoluzionaria. Dal punto di vista economico, c’è stato un mutamento con il primo governo di Néstor Kirchner: si ha una ripresa produttiva che assume come base la produzione sociale nel suo significato ampio e si produce uno scontro con i diktat dei mercati che si sostiene grazie all’esperienza di resistenza del periodo precedente. Questo primo momento è effettivamente molto importante nella misura in cui prende la forza dei movimenti piqueteros, delle occupazioni delle fabbriche, delle organizzazioni di quartiere come base dello stesso ampliamento del terreno della produzione sociale, senza rinchiudere quelle esperienze in un’interpretazione puramente ideologica. Questo elemento nuovo della produttività sociale insorgente è la forza che riesce a rappresentarsi in un processo istituzionale effettivo che ha come spazio definito la nazione. In questo senso, il potere politico nazionale concretizza l’effettiva necessità di avere un punto di riferimento centrale per far fronte ai mercati e alle loro manovre monetarie. Da questo punto di vista, per esempio, la rinegoziazione del debito e le trattative con il Club di Parigi sono state un momento di riqualificazione della trama istituzionale della democrazia argentina rispetto agli schemi ereditati dal peronismo tradizionale, tenendo in conto le mutazioni nel tessuto sociale.
E che impressione hai di quello che è successo dopo?
Dal punto di vista economico sembra che ci sia stata un’accelerazione verso l’estrattivismo che ha trovato impulso nell’affare della soia, consolidando la struttura del rapporto con le grandi imprese multinazionali. Sicuramente lo scontro con il “campo” ha avuto a che vedere con tutto questo. Da questo punto di vista, mi sembra che ci sia stata una stagnazione e un forte tentativo di centralizzare il potere da parte del governo. L’estrattivismo non è solo un fatto economico. Non si tratta solo di discutere se può essere utile concentrare la produzione su certi prodotti, ma anche di tenere presente che esso funziona come una negazione effettiva di una democratizzazione economica, nel senso che nega una produttività sociale generalizzata. Quindi la domanda è come fa il modello attuale a garantire un effettivo regime di welfare (benessere) in Argentina. Ho l’impressione che le politiche sociali – come succede per esempio in Venezuela – adottino sempre più le sembianze di concessioni date al popolo, anziché essere proposte come prodotto di una mobilitazione generale produttiva alla quale corrisponde un welfare effettivo.
Come funziona, dunque, il “dentro e contro” allo Stato in questo contesto?
Consiste nell’uso dello Stato, per dirla così, all’interno dello spazio globale dei mercati, ponendo al centro il problema fondamentale della democrazia che non è tanto il problema della libertà, ma quello della produzione. Intendo dire che è al livello delle condizioni materiali della produzione che, essenzialmente, si gioca la realizzazione della democrazia e la conquista di nuove libertà.
Come credi che altri paesi dell’America latina maneggino questa relazione tra neoestrattivismo e welfare? Pensiamo a esperienze tanto importanti come il Venezuela e il Brasile.
Abbiamo già accennato a ciò che succede in Venezuela. Non so se si può chiamarlo welfare, però troviamo lì, senza dubbio, una diffusione di servizi alle comunità con un significativo salto politico e tecnologico che si è prodotto grazie all’appoggio cubano (medici, maestri, ecc.). È stato qualcosa di molto importante, nella misura in cui si è prodotta una crescita delle aspettative di vita. Tuttavia una vera democratizzazione della società deve far fronte a molte difficoltà. Per esempio, i problemi che si sono avuti con le misiones, al tempo stesso in cui si andava formando una nuova borghesia tanto attiva come rapace. Ho un giudizio più positivo sul processo brasiliano, che fa i conti però con condizioni eccezionali dal punto di vista delle risorse naturali e sociali. C’è in effetti una situazione decisamente fortunata, ma non ci sono dubbi che la politica di Lula è stata effettivamente capace di far partecipare tutti allo sviluppo, configurando una società aperta, in termini democratici e produttivi. Lula ha dispiegato una lotta di classe continua, contro una borghesia e un settore capitalistico forti e di grandi capacità, e ciò comporta problemi enormi.
Il Brasile ti sembra un modello?
Non so se queste lotte possano darsi allo stesso modo in altri luoghi. Non credo che la sua politica sia un modello. Però in questi giorni m’interrogavo sull’enfasi del discorso ufficiale del governo argentino sulla battaglia con il gruppo Clarín. Lula ha dovuto fronteggiare l’enorme portata della televisione brasiliana e non ha fondato un solo giornale, appoggiandosi piuttosto sulla capacità di intervenire sugli altri settori, vale a dire su una politicizzazione di base prodotta da grandi movimenti, come MST e i movimenti delle favelas che sono stati estremamente importanti.
La situazione argentina non sembra mostrare oggi la capacità di ricreare movimenti sociali di tale magnitudine, anche se conservo molti dubbi al rispetto. In ogni caso mi pare che il problema della democrazia si ponga oggi con estrema chiarezza in America latina, che pertanto non può più essere pensata come un territorio periferico ma che al contrario costituisce, per molti aspetti, uno scenario centrale per tutti noi.
In gran parte dell’America latina l’estrattivismo convive con una retorica contraria al neoliberalismo, anche se ci sono una serie di pratiche sociali che funzionano secondo logiche di appropriazione neoliberali. Come valuti queste sfasature?
Credo che quando lo Stato si pronuncia contro il neoliberalismo dice una menzogna. Esistono tutta una serie di accordi specifici con le multinazionali. È un po’ quello che è successo qui dopo il conflitto con il campo. Nel quadro che sorge da questi accordi agiscono le imprese multinazionali e le imprese cooperative che sono immerse in una logica capitalistica. Questi governi sono contro il neoliberalismo? Forse sarebbe meglio dire: sono contro le estreme conseguenze del neoliberalismo, che sono quelle di annullare il welfare. Però queste sono estreme conseguenze.
Si può pensare che sia il capitalismo finanziario come tale a funzionare in modo estrattivo rispetto alla riproduzione di valore della società nel suo complesso?
Mi sembra che la relazione tra capitale finanziario e estrattivismo sia di completa identità. Anche se i governi progressisti del Sudamerica hanno fissato nuovi rapporti di forza riguardo ai mercati finanziari, è certo che questi capitali continuano a funzionare sulla base dell’espropriazione del valore prodotto dalla cooperazione sociale. Il capitale finanziario continua a essere l’elemento che unifica l’insieme sociale, in modo certamente astratto ma effettivo. E non si tratta di un intervento che viene da fuori, in modo imperialistico, ma di un intervento che condiziona l’intera macchina sociale e cerca di prefigurarla. Per questo è insufficiente ogni tentativo di opporgli semplicemente una struttura di regolazione verticale. Il problema politico che abbiamo davanti oggi è, al contrario, come articolare le pluralità produttive nella protesta. Non vedo una proposta differente.
Non ti sembra che costituisca un problema anche il modo in cui si fissa una certa immagine del movimento sociale, incapace di dar conto dei nuovi modi di organizzazione più diffusa?
Credo che questo sia effettivamente un vero problema. Vedo che in questi giorni si parla dei cacerolazos. Al di là del senso politico che ha avuto il movimento – per quello che sento qui è un movimento fondamentalmente di destra – si tratta di fenomeni che non si esprimono a livello istituzionale, ma a livello delle moltitudini. Si pone la questione: come si può dire se una moltitudine è “buona” o “cattiva”? Credo di avere una risposta, però astratta: ciò che distingue la buona moltitudine dalla cattiva è ciò che chiamo il comune. Si tratta di un’ipotesi teorica che comprende anche una nozione di democrazia sostanziale, non come qualcosa di meramente formale. Mi riferisco alla democrazia come capacità di organizzare un insieme di relazioni e di estrarre da esse una coscienza politica. Il comunismo non è qualcosa che può uscire dal comune in modo diretto. Per questo bisogna creare forme politiche capaci di porre le singolarità in relazione e dare una forma istituzionale al processo.
Come pensi questa forma istituzionale senza che si produca una chiusura nello Stato nazionale?
Credo che dopo la grande polemica contro lo Stato nazionale e di fronte al potere d’innovazione capitalistica dobbiamo riflettere sulle forme in cui si considera oggi la questione da parte della sinistra. In Europa il fallimento della sinistra consiste nel non essere riuscita ad andare oltre lo Stato nazione e non aver immaginato una gestione del potere al di fuori e oltre lo Stato nazione. Il difetto della sinistra in Europa è di aver identificato l’idea stessa del governo con un’istanza unica. Nel fissare l’idea di governo intorno allo Stato nazionale si è arrestata la capacità di immaginare forme di governo dei mercati, che chiaramente eccedono i confini nazionali. E quindi accade che sono i mercati a creare per se stessi le loro istanze di governo. In questo modo la Banca Centrale può agire come rappresentante della rete europea: di questo si tratta, del comunismo del capitale. In America latina le cose si danno in altro modo, anche se bisogna superare anche qui le visioni che si chiudono nei termini dei progetti nazion-estrattivi. Mi sembra che la possibilità di articolare una spazialità più ampia passa attraverso la comprensione del ruolo che gioca il Brasile.
In che senso?
Perché il Brasile produce più di quello che producono gli altri paesi dell’America latina e ha u’enorme capacità di attrazione a livello internazionale che lo colloca necessariamente in una posizione egemonica. Questo problema resta al di fuori del concetto di egemonia che formula Laclau e che si riferisce esclusivamente al livello nazionale, escludendo la necessità di assumere seriamente il livello regionale. Credo che si dovrebbe pensare a un equilibrio nella relazione tra spazi nazionali e regionali a partire da una collaborazione reale. Perché se i paesi si chiudono sull’esportazione delle loro risorse naturali è molto probabile che competano l’uno contro l’altro, in uno stile mediorientale ma senza sceicchi.
Parli di una serie di paradossi intorno a quello che chiami biocapitalismo e al soggetto attuale “uomo-macchina” come parte di una dinamica di valorizzazione. Di cosa si tratta?
Sarebbe importante tornare a lavorare su nozioni di Marx come il capitale costante e il capitale variabile, il capitale fisso e il capitale circolante per vedere come quelle categorie si modificano con l’egemonia del capitale finanziario. Il paradosso è che mentre le finanze attualmente costituiscono il comando stesso del capitale, la forza lavoro è determinata da nuove forme di esistenza in virtù della sua mobilità, dell’incorporazione della conoscenza e dell’autonomizzazione della sua cooperazione. In questo senso, si può dire che il lavoro vivo ha vissuto un cambiamento antropologico: l’uomo macchina – per riprendere l’immagine di Deleuze e Guattari – si è appropriato degli elementi di ciò che tradizionalmente Marx chiamava il capitale fisso, vale a dire le macchine. Questo mutamento suppone che il capitale ora non dirige più il lavoro in forma diretta, ma a distanza, catturando il lavoro a partire dai dispositivi finanziari. Si tratta di un capitale che capta il risultato del lavoro in rete. Questa è una grande differenza che implica una serie di conseguenze politiche.
Per esempio?
Per esempio rispetto alla questione della proprietà che riguarda sempre meno il possesso immediato di un bene e sempre più l’appropriazione di tutta una serie di servizi. La proprietà dipende sempre più dal lavoro complessivo che ruota attorno al mero fatto del possesso. La composizione di questo lavoro si da come una realtà interamente biopolitica e ciò implica un movimento di soggettivazione fondamentale. Credo che su questo terreno si debba sviluppare la ricostruzione di un pensiero rivoluzionario, nel senso di legare l’analisi di queste trasformazioni con l’utopia: a questo riguardo Machiavelli, Lenin e Gramsci continuano a essere per noi molto attuali.
A cosa ti riferisci quando parli di moneta del comune?
Credo che si ponga oggi la questione della riappropriazione della ricchezza comune, che può darsi solo attraverso la moneta del comune, per renderla il più estesa possibile, a condizione di accettare l’astrazione della relazione, una volta assunto che su questo non è possibile tornare indietro. E dunque, su questo terreno, è solo una lotta comune a livello globale a risolvere il problema. Non vedo altre soluzioni. Si possono dare soluzioni particolari di rottura, cacciare una multinazionale, ripetere operazioni come quella del 2001, non pagare, dichiarare l’insolvenza: sono momenti di lotta però non di soluzione. Sono tutti problemi che si pongono politicamente in maniera molto forte, per questo ci troviamo in un momento machiavellico puro.
* Traduzione di Maura Brighenti.