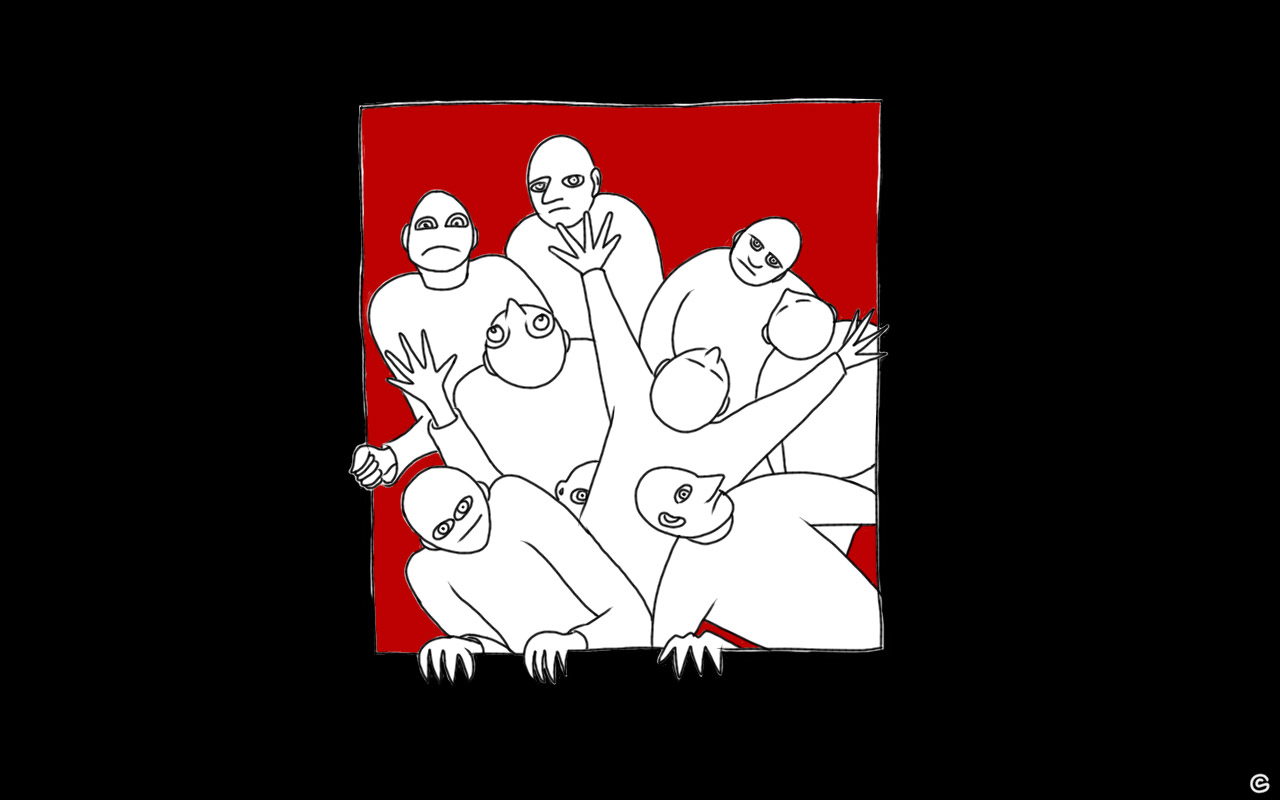di GISO AMENDOLA.
1. Una trasformazione complessiva
Un buon modo per disarmarsi di fronte all’avversario, e continuare a farlo vincere, è leggere troppo letteralmente la sua azione, sottovalutarla, rinunciare ad inquadrarla nei processi storici più ampi che interpreta. Con la riforma costituzionale messa in opera dal governo Renzi, e dal nascente Partito della Nazione, si è particolarmente esposti a questo rischio, poiché l’intervento riformatore non si segnala certo per arditezza del disegno ispiratore, né per particolare coerenza o ambizione. Gli stessi proponenti si sono spesso attestati su una interpretazione piuttosto minimalista: si sarebbe trattato soltanto di adeguare la seconda parte della Costituzione, modernizzandone gli aspetti più frequentemente segnalati come antiquati e farraginosi. Inoltre, si sarebbe colta l’occasione per porre rimedio a interventi riformatori più recenti, improvvidi o, in ogni caso, piuttosto concordemente ritenuti fallimentari alla prova dell’applicazione di fatto.
Gli obiettivi sarebbero, perciò, limitati e sostenuti da un consenso quasi unanime maturato nel tempo: in primo luogo il bicameralismo perfetto, indifendibile per la sua lentezza e per il suo effetto di moltiplicatore di conflitti poco nobili, di strategie dilatorie o di ricatti reciproci tra gli attori del processo legislativo; subito dopo, il titolo V sulle autonomie, prodotto di una riforma poco lungimirante e produttore di incertezza costante e di un inutile e strabordante contenzioso costituzionale; inoltre, qualche altro intervento sporadico, sempre nel segno di un rigoroso mantenersi nel campo della manutenzione costituzionale.Il rischio evidente è di ridursi ad inseguire questa strategia di understatement riformatore sul suo stesso piano, concentrandosi per esempio sulla composizione del senato, sui procedimenti di “nomina” dei nuovi senatori, sulla difficile individuazione delle sue nuove funzioni.Per fortuna, non sono mancate le voci autorevoli che hanno invece lavorato a cogliere il disegno complessivo della vicenda: producendo per esempio quell’ottima sintesi costituita dal documento/appello dei giuristi pubblicato da “il manifesto”[1].
La posta in gioco generale, in realtà, non è difficile da cogliersi. La riforma costituzionale non coincide ovviamente con il solo progetto di riforma del testo costituzionale, ma risponde a un disegno complessivo che tiene insieme questo intervento e la nuova legge elettorale, il (giustamente) famigerato italicum. A leggerle unitariamente, le due iniziative formano un complessivo ridisegno degli equilibri costituzionali che tocca in profondità la forma di governo. Ben oltre il tanto e troppo ridiscusso ridisegno del Senato, con l’abbandono dell’elezione diretta dei suoi membri e il superamento del bicameralismo perfetto, il nodo centrale è l’introduzione di una forma di premierato particolarmente incisiva, caratterizzata dall’archiviazione sostanziale del nesso fiduciario e dall’adozione di un sistema elettorale con un robustissimo premio di maggioranza alla lista che superi il quaranta per cento dei voti al primo turno, o che risulti vincitrice all’eventuale turno di ballottaggio. Di fronte a questa forma di premierato, anche l’abolizione del vecchio senato elettivo acquista un senso del tutto diverso: più che un intervento razionalizzatore sui meccanismi di produzione legislativa, in questo specifico contesto finisce per produrre un’ulteriore alterazione del sistema dei contrappesi. Complessivamente, quindi, diventa plausibile supporre che si finisca per incidere, oltre che sulla forma di governo, sulla stessa forma di Stato, se almeno si intende il richiamo alla forma repubblicana nel suo senso complessivo di sistema bilanciato, quale prefigurato dal complessivo equilibrio dei poteri disegnato in Costituzione.
Si comprende perciò come l’intervento costituzionale possa essere stato rivendicato, dai suoi sostenitori più chiari ed espliciti, come un intervento complessivo. Un progetto che va ben oltre la manutenzione, per accettare la sfida di due crisi radicali: una doppia risposta, com’è stato detto, alla crisi di governabilità e alla crisi di rappresentanza, incentrata appunto sul rafforzamento deciso dei poteri del capo del governo, e, insieme, sulla riscrittura complessiva del sistema dei partiti e della rappresentanza[2].
Questa lettura coglie indubbiamente il punto centrale di questo passaggio, e ci evita di disperdere energie intellettuali e politiche all’inseguimento di falsi problemi: non si tratta, evidentemente, di impegnarsi in un’astratta discussione sulla difendibilità o meno dell’assetto integrale della Costituzione repubblicana. La riforma appare, considerata complessivamente, un aspetto di un processo più ampio, che trascende la stessa dimensione nazionale, e che si iscrive in un riassetto profondo degli equilibri ereditati dal costituzionalismo. La “riforma Renzi” è il prodotto di una più generale “esecutivizzazione” (il termine è decisamente inelegante, ma descrittivamente preciso) degli assetti costituzionali, che è una tendenza di lunga durata degli ordinamenti costituzionali e dei sistemi politici.In questo senso, è davvero quello che i suoi sostenitori più decisi proclamano: una risposta a una crisi profonda del costituzionalismo liberale classico. La direzione e i contenuti di questa risposta sono tutti da indagare: ma è evidente che è a questo livello che si muove la sfida costituzionale, ed è a questo livello che occorre attrezzarsi, teoricamente e politicamente, a rispondere.
 Non bisogna, perciò, ridurre una simile riforma al semplice effetto di criticabili scelte politiche più o meno occasionali di una pessima maggioranza di governo, magari attraversata da malcelate pulsioni accentratrici e autoritarie: è, per l’appunto, l’espressione di una tendenza complessiva dei sistemi di governo, e come tale occorre prenderla sul serio. Ma, al tempo stesso, non bisogna farle l’eccessivo onore di elevarla a causa motrice di quelle tendenze, delle quali è appunto solo l’effetto. E’ questo il rischio insito, invece,nelle letture che privilegiano la natura di svolta “autoritaria” che questa riforma comporterebbe. Non si tratta di negare, ovviamente, che più di un elemento autoritario, in questa concentrazione di potere, ci sia. Il problema, però, è che le interpretazioni in termini di “svolta autoritaria” rischiano di rappresentare questi interventi come la ragione stessa della crisi del costituzionalismo classico, come se la rottura delle forme costituzionali fosse prodotta semplicemente dall’attacco di questi riformatori. L’attenzione va invece tenuta ferma su un’indagine spietata della crisi del costituzionalismo, della quale questo nuovo riformismo costituzionale semmai approfitta, ma che certamente non ha generato. In altre parole: siamo di certo davanti a processi, inquietanti, di accentramento autoritario, e anche, come è stato sostenuto con ottime ragioni, di autentico “populismo costituzionale”[3]. Ma un’analisi condotta esclusivamente in chiave di autoritarismo o di populismo, rischia di rappresentare la crisi complessiva del costituzionalismo liberale come una crisi prodotta dall’alto, o, comunque, dall’esterno del costituzionalismo stesso. L’ascesa di una nozione estremamente semplificata e accentratrice di governabilità giungerebbe a rompere oggi gli equilibri del costituzionalismo, che vacillerebbero sotto questa sorta di calata degli Hyksos di costituzionalisti e politici autoritari, accentratori e populisti. Ma, in questo modo, si finisce per trascurare gli elementi di crisi interna del costituzionalismo: la cittadella del costituzionalismo liberale, che oggi sarebbe attaccata così brutalmente dai riformatori, in realtà è già stata abbandonata, e non è da oggi che risulta oramai indifendibile. La conseguenza della sopravvalutazione del ruolo dei “cattivi” riformatori – e della parallela reticenza ad analizzare le ragioni più profonde di una crisi del costituzionalismo già conclamata ben prima che i riformatori decidessero di accelerare la propria azione – è quella di produrre un’attitudine esclusivamente difensiva rispetto a queste trasformazioni, che finisce per rendere politicamente molto poco efficace la risposta. Già Luciano Ferrari Bravo, in una serie di lavori in cui agli inizi degli anni Novanta indagava la trasformazione in senso maggioritario e bipolare del sistema italiano, mostrava, con indagini ancora oggi attualissime già a partire dal metodo, come la ritrosia a prendere sul serio i presupposti sociali e politici della crisi della rappresentanza finiva per spostare la sinistra tradizionale su posizioni asfittiche e difficilmente mantenibili, fondate sulla “centralità della mediazione partiticacome canale esclusivo di integrazione ideologica, di formazione di ceto politico, di determinazione delle scelte politiche cruciali” e, in sintesi, sull’impossibile mantenimento della “costituzione materiale preesistente”. L’unico modo per criticare le posizioni ipermaggioritarie senza cadere in queste nostalgie da “difesa della Costituzione”, secondo Ferrari Bravo, era immergersi in una genealogia della crisi della mediazione costituzionale, per coglierne le discontinuità e i punti di resistenza, l’emergere, proprio all’interno di quella crisi, delle forze nuove e delle nuove energie dei movimenti sociali[4].
Non bisogna, perciò, ridurre una simile riforma al semplice effetto di criticabili scelte politiche più o meno occasionali di una pessima maggioranza di governo, magari attraversata da malcelate pulsioni accentratrici e autoritarie: è, per l’appunto, l’espressione di una tendenza complessiva dei sistemi di governo, e come tale occorre prenderla sul serio. Ma, al tempo stesso, non bisogna farle l’eccessivo onore di elevarla a causa motrice di quelle tendenze, delle quali è appunto solo l’effetto. E’ questo il rischio insito, invece,nelle letture che privilegiano la natura di svolta “autoritaria” che questa riforma comporterebbe. Non si tratta di negare, ovviamente, che più di un elemento autoritario, in questa concentrazione di potere, ci sia. Il problema, però, è che le interpretazioni in termini di “svolta autoritaria” rischiano di rappresentare questi interventi come la ragione stessa della crisi del costituzionalismo classico, come se la rottura delle forme costituzionali fosse prodotta semplicemente dall’attacco di questi riformatori. L’attenzione va invece tenuta ferma su un’indagine spietata della crisi del costituzionalismo, della quale questo nuovo riformismo costituzionale semmai approfitta, ma che certamente non ha generato. In altre parole: siamo di certo davanti a processi, inquietanti, di accentramento autoritario, e anche, come è stato sostenuto con ottime ragioni, di autentico “populismo costituzionale”[3]. Ma un’analisi condotta esclusivamente in chiave di autoritarismo o di populismo, rischia di rappresentare la crisi complessiva del costituzionalismo liberale come una crisi prodotta dall’alto, o, comunque, dall’esterno del costituzionalismo stesso. L’ascesa di una nozione estremamente semplificata e accentratrice di governabilità giungerebbe a rompere oggi gli equilibri del costituzionalismo, che vacillerebbero sotto questa sorta di calata degli Hyksos di costituzionalisti e politici autoritari, accentratori e populisti. Ma, in questo modo, si finisce per trascurare gli elementi di crisi interna del costituzionalismo: la cittadella del costituzionalismo liberale, che oggi sarebbe attaccata così brutalmente dai riformatori, in realtà è già stata abbandonata, e non è da oggi che risulta oramai indifendibile. La conseguenza della sopravvalutazione del ruolo dei “cattivi” riformatori – e della parallela reticenza ad analizzare le ragioni più profonde di una crisi del costituzionalismo già conclamata ben prima che i riformatori decidessero di accelerare la propria azione – è quella di produrre un’attitudine esclusivamente difensiva rispetto a queste trasformazioni, che finisce per rendere politicamente molto poco efficace la risposta. Già Luciano Ferrari Bravo, in una serie di lavori in cui agli inizi degli anni Novanta indagava la trasformazione in senso maggioritario e bipolare del sistema italiano, mostrava, con indagini ancora oggi attualissime già a partire dal metodo, come la ritrosia a prendere sul serio i presupposti sociali e politici della crisi della rappresentanza finiva per spostare la sinistra tradizionale su posizioni asfittiche e difficilmente mantenibili, fondate sulla “centralità della mediazione partiticacome canale esclusivo di integrazione ideologica, di formazione di ceto politico, di determinazione delle scelte politiche cruciali” e, in sintesi, sull’impossibile mantenimento della “costituzione materiale preesistente”. L’unico modo per criticare le posizioni ipermaggioritarie senza cadere in queste nostalgie da “difesa della Costituzione”, secondo Ferrari Bravo, era immergersi in una genealogia della crisi della mediazione costituzionale, per coglierne le discontinuità e i punti di resistenza, l’emergere, proprio all’interno di quella crisi, delle forze nuove e delle nuove energie dei movimenti sociali[4].
La nostra ipotesi segue queste tracce, leggendo i processi di accentramento sull’esecutivo, di cui la “riforma Renzi” è espressione, come la risposta a una crisi di lunga durata del costituzionalismo liberale, una crisi radicale che rende impraticabile una sua semplice difesa. Allo stesso modo, la risposta in termini di leggi elettorali ipermaggioritarie alla crisi di rappresentanza non produce la crisi di rappresentanza: semmai la presuppone, e nessuna azione politicamente efficace su questo terreno può prescindere dal confrontarsi con grande radicalità su questo terreno decisivo.
2. Una costituzione decostituzionalizzante
Letta in questo modo, la nostra vicenda costituzionale appare un episodio, senz’altro molto significativo, ma comunque iscritto in un arco di trasformazioni molto più ampio, del processo di decostituzionalizzazione. Si tratta, né più né meno, di portarsi all’altezza della sfida aperta dall’esaurirsi della mediazione costituzionale prodotta dalle costituzioni del Novecento[5]. La forza normativa della forma costituzionale risiedeva appunto nella capacità mostrata di tenere insieme, anche se in un campo di tensione e di conflitto, in un equilibrio dinamico e “amministrato” in vari modi, il lato delle figure soggettive emergenti dalla produzione con il lato dell’ordine giuridico, la socializzazione dei processi lavorativi con il welfare e i diritti sociali, i meccanismi disciplinari di produzione dell’obbedienza con la sovranità.La forza normativa delle costituzioni risiedeva insomma, per dirla con la teoria generale à la Kelsen, nel riuscire a tenere produttivamente insieme il lato normativo della validità con quello fattuale dell’effettività. Le grandi “costituzioni del lavoro” del Novecento riuscirono appunto a produrre questa forza normativa, questa capacità di includere, sotto una Grundnorm unitaria, l’insieme dei poteri pubblici e delle figure sociali[6]. Ma questa difficile sintesi, già al suo interno estremamente movimentata e contradditoria, si era edificata su presupposti storicamente e socialmente ben determinati. Quel compromesso costituzionale avveniva dentro una concezione spaziale molto precisa, costituita dai confini degli Stati nazionali; allo stesso tempo, si reggeva sulla presenza di forti soggettività collettive, a loro volta emergenti all’interno del progressivo sviluppo e dell’ampio processo di socializzazione del capitalismo industriale. Quel disegno costituzionale si nutriva della capacità di costruire mediazione dei grandi soggetti politico-sindacali: ma, a loro volta, queste costruzioni erano rese possibili dalla tendenziale omogeneità delle figure soggettive che nascevano e si muovevano dentro il sistema di produzione industriale-fordista. Nessuna sintesi definitiva, ovviamente, si dava neppure all’interno di quelle grandi forme costituzionali statali. Anzi la loro forza normativa si è sempre misurata, in ultima analisi, proprio sulla capacità di rendere produttivo lo stesso conflitto costituzionale, di provare a integrare la stessa lotta di classe nello sviluppo del progetto costituzionale democratico, nella costruzione di un ambizioso modello di stato sociale di diritto. Appunto, però, proprio all’interno di questo processo, come ci ha insegnato il grande dibattito sulla crisi dello stato sociale che ha attraversato già tutti gli anni Settanta, si sono riaperte continuamente nuove tensioni: il progetto di produzione normativa di unità politica ha sempre incontrato forme non integrabili di antagonismo, la pressione dell’efficacia non ha mai smesso di riaprire le geometrie formali della validità normativa. La grande stagione “progressista” della scienza giuridica si è appunto costruita nel fronteggiamento continuo di queste tensioni: in Italia, in particolare, ha prodotto, negli anni Sessanta e Settanta, uno straordinario approfondimento del disegno costituzionale.
Ma il processo di decostituzionalizzazione, cioè la progressiva perdita di capacità formativa di quella sintesi, in ogni caso, si apre già all’interno di quella esperienza, già all’interno della stessa fase di espansione dello stato sociale, coinvolgendo entrambi i lati della mediazione: sia quello normativo, della struttura e del funzionamento del sistema giuridico, sia quello dell’efficacia, delle trasformazioni radicali dei soggetti sociali sui quali quell’impianto era chiamato ad “ingranare”. Da un lato, la produzione normativa si trasforma, abbandona ogni pretesa di unità gerarchica e piramidale, si disloca in una pluralità di centri di decisione e di amministrazione, assume la struttura complessa e reticolare che impareremo ad indagare dalla stagione degli studi sulla governance:la perdita della capacità di produrre forma unitaria della sovranità statutale si traduce, allo stesso tempo, in un complesso di progressive rinegoziazioni della sovranità. Dall’altro lato, i soggetti collettivi si scompongono, emergono soggettività nuove, non più collocabili all’interno degli schemi della mediazione.
E’ un processo di disarticolazione delle geometrie costituzionali classiche che procede senza alcuna linearità, e, soprattutto, che tiene insieme la crisi dell’ordine normativo, quello che avviene “ai piani alti” dei sistemi giuridici, con trasformazioni sociali e spinte emergenti “dal basso”, appunto nelle trasformazioni dei soggetti e delle relazioni sociali, all’interno di una metamorfosi complessiva della produzione, e, insieme, del sistema giuridico. Il transito dalla fine degli anni Sessanta ai Settanta, con la rottura del Sessantotto, il presentarsi di una crisi che pone fine alle concezioni lineari dello sviluppo coltivate negli anni dell’espansione, la trasformazione radicale degli equilibri monetari seguita alla rottura del sistema di Bretton Woods, avevano già costituito lo sfondo di questa metamorfosi.
Nessun discorso serio e non formalisticamente incantato sulla crisi della forma giuridica costituzionale può prescindere dalla centralità di questo passaggio d’epoca.E’, infatti,precisamente in questo contesto che comincia a emergere una lettura radicalmente differente del tema della governabilità. Non si tratta più di radicare il governo all’interno dei processi sociali e dei soggetti che li esprimono, come nella grande lezione dei giuristi della mediazione costituzionale classica: al contrario,si proclama la necessità e l’urgenza di accentuare in senso verticale la rottura tra il lato dell’ordine normativo e quello delle soggettività e dei movimenti sociali, per riconquistare una funzione di comando in grado di semplificare e neutralizzare la pressione crescente delle aspettative nei confronti del sistema giuridico. Un testo chiave di questo salto decisivo nel modo stesso di porre la questione della governabilità, è, notoriamente, il volume sulla Crisi della democrazia, curato per la Trilateral Commission da Crozier, Huntington e Watanuki[7], che è stato definito, icasticamente ma con precisione, “un vero e proprio manuale che impone il verbo della governabilità dinanzi ai sommovimenti anche violenti di quelle porzioni di società che chiedono maggiore giustizia sociale, diritti e redistribuzione economica”[8]. La trasformazione del senso della governabilità è qui compiuta: è l’emergere in modo esplicito della linea di accentramento esecutivo, tendenziale riduzione dello scontro sociale a problema di ordine pubblico, semplificazione autoritaria dei meccanismi rappresentativi ed esaltazione unilaterale del momento decisionistico.
Questa linea, che pure influirà in modo molto evidente sul ritorno della discussione sulle riforme costituzionali dagli anni Ottanta in poi, non è però incontrastata. Soprattutto nello spazio sovranazionale europeo, in alternativa alla linea di accentramento sull’esecutivo e di mera intensificazione del comando, si cercherà di aprire strade diverse, nel segno dello sviluppo di un multilevelconstitutionalism postnazionale. Si tratterebbe, piuttosto che riproporre in termini rudemente verticali e semplificatori il tema della decisione politica, di assumere pienamente il tramonto della mediazione statuale, e di sperimentare forme costituzionali non legate alle architetture dello Stato-nazione, forme costituite dall’intersecarsi dell’azione delle Corti europee e della produzione normativa sovranazionale, e sostenute dalla pressione dei movimenti sociali. Questo costituzionalismo multilivello mostra di sapersi muovere dentro il processo di decostituzionalizzazione in modo non semplicemente reattivo, senza coltivare illusioni di una possibile restaurazione degli equilibri del costituzionalismo classico, e cercando di piegare le maglie reticolari della governance ad un nuovo discorso sui diritti, e alla costruzione di garanzie civili e sociali non più agganciate alle tradizionali figure soggettive delle “costituzioni del lavoro”[9]. Sono gli approcci in termini di nuovo costituzionalismo europeo e di nuova cittadinanza che conoscono il punto più alto, probabilmente, con l’approvazione della Carta di Nizza e che incrociano in modo conflittuale ma produttivo i nuovi movimenti globali che animano la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni 2000.
Il fallimento del processo costituente europeo del 2005, con la bocciatura referendaria francese e olandese, mostra come quel processo di integrazione attraverso il diritto portava con sé qualche illusione di troppo sulla linearità e sulla continuità dell’avanzamento verso la costruzione di una sorta di governance “progressiva”, capace di far giocare in modo produttivo la costruzione a rete dei nuovi luoghi di decisione con l’azione dal basso dei movimenti. D’altro verso, non aiuteranno per nulla le nostalgiche convinzioni di una parte delle sinistre europee sulla capacità di riaffermare la mediazione politica-costituzionale negli spazi nazionali, convinzioni che porteranno all’appoggio al No al referendum europeo francese da parte di settori di sinistra “neosovranisti”: i quali inaugureranno così quell’atteggiamento semplicemente reattivo davanti alla crisi del costituzionalismo nazionale che ancora oggi pesa sulla possibilità di elaborare risposte efficaci e non meramente difensive a quella crisi.
E’ in questo scenario che i processi di “esecutivizzazione” degli ordinamenti costituzionali avanzano. Ma il punto da conquistare all’analisi e sul quale non retrocedere è che la decostituzionalizzazione non costituisce un processo per nulla lineare di crisi della mediazione costituzionale, ma produce, insieme, fuoriuscite verso la verticalizzazione estrema e l’unificazione del comando, e, allo stesso tempo, una diffusione inedita di forme reticolari post-sovrane e post-rappresentative. Questo processo non è identificabile in nessun modo come una semplice “rivoluzione dall’alto”, tantomeno come un semplice attacco autoritario esterno al patrimonio costituzionale del Novecento. Semmai, è il prodotto della crisi della grammatica classica costituzionale, sottoposta ad un duplice processo di trazione. Un movimento che deforma le costituzioni “dall’alto”, per effetto della trasformazione transnazionale dei confini politici e dello spiazzamento dei centri nazionali e “sovrani”di decisione; e che al tempo stesso le sottopone a una notevole trazione “dal basso”, per le trasformazioni delle modalità produttive, dei soggetti sociali e politici protagonisti della mediazione classica, e, insieme, per l’irruzione di nuove soggettività che eccedono le figure tradizionali del soggetto giuridico-politico moderno, sia individuale che collettivo. Infine, è un processo non lineare in quanto, se da un lato apre sicuramente lo spazio a un enorme riaccentramento dei poteri come risposta alla crisi di governabilità, a una risposta ipermaggioritaria alla crisi della rappresentanza, a una verticalizzazione del comando giocata contro il sempieterno incubo dell’ “ingovernabilità” prodotta dal salto quantitativo e qualitativo delle aspettative sociali, dall’altro lato prefigura riarticolazioni inedite delle reti decisionali, dell’uso dei diritti, del rapporto tra spazi politici sovranazionali e capacità d’agire dei movimenti sociali. La nuova centralità degli esecutivi non riesce a nascondere la nascita di processi di “costituzionalizzazione” parziali e autonomi.Dai diritti umani alle reti, dai diritti ambientali all’accesso e alla circolazione dell’informazione, il campo della decostituzionalizzazione è continuamente attraversato da esperimenti di “costituzionalismo societario”, per dirla con Gunther Teubner, di autoproduzione giuridica sganciata dalle logiche sovrane: processi che, almeno potenzialmente, annunciano la possibilità di un nuovo diritto costituzionale “senza Stato”[10].
3. Costituzione finanziaria e esperimenti costituenti
Questa cartografia complessa ha subito evidentemente, con la crisi economico-finanziaria iniziata alla fine degli anni Zero, una nuova evidente accelerazione e un approfondimento qualitativo del processo di decostituzionalizzazione. Alla prospettiva di integrazione attraverso il diritto, propria degli esperimenti di multilevelconstitutionalism che abbiamo ricordato, si è sostituita in Europa una prospettiva di gestione della crisi che ha dato vita piuttosto a una sorta di tentativo di integrazione attraverso la moneta. E’ il controllo della moneta a trasformarsi nell’autentica Grundnorm che si cerca di imporre allo spazio europeo: producendo un effetto di trasformazione costituzionale, questo sì decisamente “dall’alto”, che gli osservatori hanno variamente riportato a un “diritto di eccezione” europeo, o a una “dittatura finanziaria”. Espressioni, queste ultime, che sicuramente colgono i tratti di discontinuità, di rottura della (presunta) linearità dell’integrazione giuridica, di verticalizzazione decisa del comando: rischiano però – con il riferimento allo schema dittatoriale –di mettere un po’ in ombra il tratto più precisamente costituente, di riscrittura complessiva della “costituzione” dello spazio europeo che si sta producendo. Attraverso le modifiche al Trattato di Lisbona che hanno prodotto la coppia decisiva Meccanismo Europeo di Stabilità – Fiscal Compact, non solo si è riorganizzata la governance europea, facendola girare intorno ai dispositivi di governo della moneta, ma si è anche riscritto il rapporto tra livello costituzionale sovranazionale e costituzioni nazionali, sino a procedere a una trasformazione obbligatoria e guidata delle stesse costituzioni nazionali. L’inserimento dell’obbligo di pareggio di bilancio nelle costituzioni formali è in realtà una codificazione di una trasformazione già avvenuta nella costituzione materiale europea: il divieto di deficit spending èparte costitutiva della costituzione neoliberale che si afferma in Europa come nuova costituzione finanziaria.
La “riforma Renzi” si inserisce esattamente in questo punto: si tratta di riannodare finalmente costituzione materiale e costituzione formale, per ricomporre un assetto neoliberale incentrato sull’integrazione attraverso il controllo monetario. Ma questa ricomposizione, questa chiusura dei dualismi aperti dalla crisi della mediazione, non può che avvenire attraverso l’imposizione di soluzioni decisionistiche, proprio perché i fondamenti sostanziali della mediazione sono oramai esaurite. Pertanto, il riassetto dei poteri attorno all’esecutivo attraverso il premierato, il taglio decisionistico impresso alla crisi di rappresentanza è precisamente l’espressione della rottura della relazione tra dispositivi di governo della crisi, da un lato, e aspettative, conflitti ed eccedenze sociali, dall’altro. Nessuna contraddizione si apre, invece, tra accentramento della decisione, da un lato, e aspirazione neoliberale allo “stato minimo”, dall’altro. Come insegnava Foucault, il neoliberalismo non è per nulla assenza di governo: anzi, è esercizio di potere continuo, proprio al fine di produrre continuamente quelle condizioni per cui il mercato possa funzionare come “verità” e limite dell’esercizio delle stesse funzioni di governo. L’emergere della finanziarizzazione richiede appunto che alla rottura della relazione tra capitale e forza-lavoro, e sul piano giuridico, alla rottura della mediazione tra ordine normativo e soggetti, tra validità ed efficacia, si risponda in termini di intensificazione del comando. L’estensione a tutta la società dei dispositivi di estrazione di valore rende impossibile – ancor prima che inutile – la mediazione lavoristica che fondava la forma costituzionale novecentesca classica: la società salariale girava attorno a conflitti anche durissimi, ma pur sempre articolabili attorno ad un valore misurabile in termini di lavoro impiegato, e a uno sfruttamento altrettanto misurabile. Ma ora l’estrazione finanziaria letteralmente non conosce misura: non perché spariscano valore e sfruttamento, ma precisamente perché l’estrazione di valore non è più misurabile. Nel tempo in cui tutta la vita viene messa al lavoro, nel tempo della marxiana sussunzione reale, quella linea di risposta già prefigurata proprio all’inizio degli anni Settanta, significativamente proprio nel momento in cui la finanza cominciava ad affermarsi come nuovo modello di accumulazione globale, oggi emerge definitivamente come fondamento della costituzione finanziaria europea: la governabilità deve separarsi da ogni illusione di integrare la nuova densità della cooperazione sociale, proponendosi piuttosto come comando verticale su di essa. La forma del premierato non fa che tradurre questa esigenza.
Dal canto suo, la rappresentanza, non più articolabile attraverso quella “soggettivazione attraverso il lavoro”[11] che fondava la funzione di mediazione della rappresentanza classica e delle figure collettive del partito di massa e del sindacato, gira a vuoto e viene appunto reinventata attraverso soluzioni ipermaggioritarie. Ma ancora una volta, è vietato qui scambiare causa ed effetto: non è l’adozione di sistemi elettorali ultramaggioritari a produrre la crisi della forma partito e della rappresentanza, ma è l’esaurirsi dei presupposti sociali e soggettivi del costituzionalismo ad aprire la strada a un uso dei sistemi elettorali tutto piegato alla produzione di governabilità “verticale”. Infine, il ritorno di tendenze centralizzanti nel rapporto con le autonomie regionali non prova neppure a ricreare la salda unità del riferimento sovrano e statuale. In realtà è perfettamente funzionale ad estendere il comando finanziario sulle articolazioni locali: più che di correggere le tendenze federaliste, si tratta di rinsaldare non il comando “sovrano” del centro sulle periferie, bensì il comando finanziario che si esprime nei vincoli dei patti di stabilità.
Se questo quadro ha un senso, ne discende allora che è perfettamente impossibile già da un punto di vista teorico, e deleterio da un punto di vista politico, pensare di poter reagire al neoriformismo costituzionale europeo, di cui il complesso della “riforma Renzi” non è che un’espressione, attraverso una difesa della “costituzione vigente”: per il semplice fatto che il processo di decostituzionalizzazione ha già da lungo tempo trasformato radicalmente il senso complessivo di quella costituzione, e per la verità ne ha modificato persino la lettera (difficile difendere come tale una costituzione che contiene – già prima che questa maggioranza ci mettesse mano – l’obbligo di pareggio di bilancio!). Rispondere a questo processo di ultrasemplificazione decisionistica è possibile invece solo agendo nella consapevolezza della radicalità dei processi decostituzionalizzanti, e abbandonando ogni pretesa di resuscitare un modello di mediazione costituzionale e una concezione della rappresentanza che sono risultati spiazzati non dalle riforme, ma ben prima dalle trasformazioni della produzione e dei suoi soggetti. Si tratta, al contrario, di mettere in moto processi costituenti transnazionali che producano nuovi momenti di riappropriazione della decisione politica, e soprattutto, un legame nuovo tra forme e modi della decisione politica e le nuove forme della soggettività e della cooperazione sociale, che emergono continuamente all’interno della società “interamente messa a valore” dalla finanziarizzazione. Sia chiaro: non stiamo evocando l’immagine tradizionale del potere costituente, appartenente, in fondo, nella sua figura classica, compatta e unitaria, alla stessa epoca del costituzionalismo moderno messo in crisi da processi di costituzionalizzazione. Piuttosto, si tratta di immaginare la produzione di un nuovo spazio politico costituzionale europeo, attraverso campagne mirate a reinventare la dimensione collettiva della decisione, a sperimentare spazi di autogoverno e di autonomia, a reinventare la relazione tra istituzioni e soggetti, piegandola alla trasformazione radicale delle soggettività che stiamo attraversando.
Immaginare scenari costituenti significa, per esempio, rileggere i diritti fondamentali alla luce di un soggetto che non sia identificato più con la centralità del cittadino lavoratore (maschio, eterosessuale etc.), ma sia assunto nella singolare e irriducibile complessità delle sue situazioni esistenziali e delle sue scelte di vita. Così come assumere la centralità della cooperazione sociale significa assumere nell’interpretazione dei diritti fondamentali il tema del welfare non come intervento pur sempre, in fondo,sussidiario rispetto alla centralità della produzione, ma come cuore della produzione stessa, come motore dello sviluppo delle potenzialità della società. Sulla stessa linea, occorre riconoscere la portata costituzionale dei beni comuni, proprio come espressione della ricchezza e della forza della cooperazione sociale e delle nuove soggettività: e non solo come “integrazione” alla lettura e all’interpretazione dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, ma anche come superamento – costituente – della geografia pubblico/privato.
Di fronte alla radicalità delle trasformazioni costituzionali, ma soprattutto di fronte alle metamorfosi sociali che hanno prodotto quelle trasformazioni, non c’è semplice difesa che tenga, non c’è restaurazione possibile di un buon equilibrio dei poteri, di una corretta misura dell’azione di governo, di una nuova “buona” e non corrotta rappresentanza: si tratta di opporre alle riforme che si susseguono nel segno della governabilità “dall’alto”, la sperimentazione di nuovi spazi di riappropriazione di decisione politica e di potere dal basso, l’apertura al protagonismo di una nuova produzione di soggettività. Niente di astratto o che non abbia del resto già gambe solide su cui camminare. Si tratta di far risuonare, nell’opposizione al neoriformismo costituzionale, non la difesa di assetti oramai non recuperabili, ma quella dimensione costituente che ha caratterizzato i movimenti del 2011: onde di trasformazione radicale che, dalla Spagna alla Grecia alla Turchia, continuano a risuonare oggi nelle forze politiche innovative che si affacciano in Europa oltre le rovine dei fallimenti socialdemocratici e i deserti delle politiche dell’austerity.
[1] Il documento-appello, a prime firme Azzariti, Carlassare, Ferrara, Pace, Rodotà, Villone, è stato pubblicato da “il manifesto” del 13/10/2015 (ilmanifesto.info/la-peggiore-riforma).
[2] In questi termini, per esempio, il senso complessivo della riforma è illustrato da Tommaso Edoardo Frosini, nella sua audizione sulla legge elettorale presso la Commissione Affari costituzionali della Camera del 12 aprile 2015 (http://www.confronticostituzionali.eu/?p=1434).
[3] Cfr. l’analisi approfondita della riforma in M. Revelli, Dentro e contro, Laterza, Roma, 2015. Per condivisibili osservazioni sui limiti di queste interpretazioni in chiave di “populismo dall’alto”, cfr. la recensione di M. Bascetta. Un frammento del politico, in “il manifesto” del 11/11/2015, anche in Euronomade: in https://www.euronomade.info/?p=6062)
[4] Cfr. L. Ferrari Bravo, Costituzione e movimenti sociali, in Id., Dal fordismo alla globalizzazione. Cristalli di tempo politico, manifestolibri, Roma, 2001, pp. 243-260.
[5]Sul concetto di decostituzionalizzazione come crisi della costituzione come produzione di unità politica, cfr. A. Brandalise, Democrazia e decostituzionalizzazione, in “Filosofia poltica”, 3, 2006, pp. 403-414; S. Chignola, In the Shadow of the State. Governance, governamentalità, governo, in G. Fiaschi (a cura di), Governance: oltre lo Stato?,Rubettino, Soveria Mannelli, 2008, pp. 117-141.
[6] Cfr. per una interpretazione complessiva del nesso tra progressiva “socializzazione” del capitale e Costituzione, A. Negri, Il lavoro nella costituzione, nuova edizione Ombre corte, Verona 2009.
[7]Cfr. M.J. Crozier, S.P. Huntington, J. Watanuki, La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale, tr. it. Franco Angeli, Milano, 1977.
[8] G. Allegri, Costituzione e movimenti sociali tra passato e futuro, in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), Il tempo delle costituzioni. Dall’Italia all’Europa, manifestolibri, Roma 2014, p. 16.
[9]Cfr. S. Chignola, S. Mezzadra, Gli spazi d’Europa. Aporie del processo di costituzionalizzazione e pratiche di libertà, in “Rassegna di diritto pubblico europeo” VII (2008), I, pp. 129-148.
[10] Cfr. G. Teubner, La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, a cura di R. Prandini, Armando, Roma 2005.
[11] Così Maria Rosaria Marella, Pratiche del comune. Per una nuova idea di cittadinanza, in “Lettera internazionale”, 116, 2, 2013, pp. 40-44 (anche in Euronomade: www.euronomade.info/?p=70).