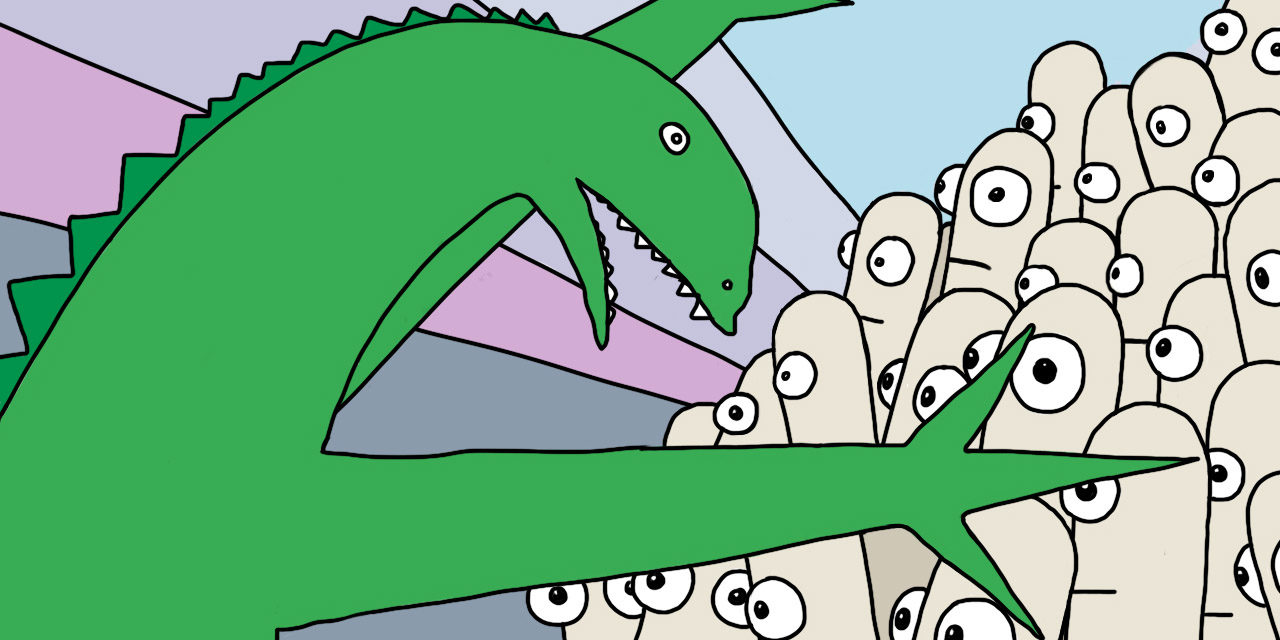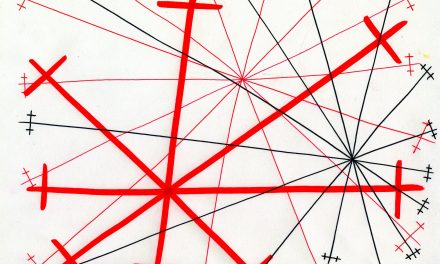di TONI NEGRI.
Il testo qui pubblicato è quello detto da Toni Negri al festival di DeriveApprodi, a Roma il 25 novembre scorso. Questo testo riprende parzialmente un paio di paragrafi di un nuovo libro, Assembly, di Michael Hardt e Toni Negri, che sarà presto pubblicato da Oxford University Press.
Dunque, se non fosse stato montato e detto da uno solo, dovrebbe esser firmato da tutti e due.
Comincerò dalla critica dell’autonomia del politico (nazionale) sotto la cui bandiera si muovono varie posizioni, tutte nostalgiche della sovranità.
“L’autonomia del politico” è infatti oggi da molti concepita come una forza di redenzione per la sinistra – di fatto la ritengo una maledizione dalla quale rifuggire. Uso la frase “autonomia del politico” per designare argomenti che pretendono che il processo decisionale in politica possa e debba essere tenuto al riparo dalle pressioni della vita economica e sociale, dalla realtà dei bisogni sociali
Alcune delle figure contemporanee più intelligenti che propongono l’autonomia del politico lo concepiscono come un mezzo per restaurare il pensiero politico liberal (di sinistra) strappandolo al dominio ideologico del neoliberismo, come antidoto non solo e non tanto alle politiche economiche distruttive del neoliberalismo, ivi comprese privatizzazione e deregulation, ma piuttosto ai modi nei quali il neoliberalismo trasforma e domina il discorso pubblico e politico: il modo nel quale esso impone una razionalità economica sopra il discorso politico e mina ogni ragionamento politico che non obbedisca alla logica di mercato. Laddove la “democrazia liberal” – ci spiega Wendy Brown – mantiene “una modesta separazione etica fra economia e politica”, la razionalità politica neoliberale chiude questa separazione e “sottomette ogni aspetto della vita sociale e politica al calcolo economico”. Secondo questo punto di vista, il neoliberalismo è la faccia discorsiva ed ideologica della “sussunzione reale” della società sotto il capitale ovvero, come si esprime Wendy Brown, “la saturazione delle realtà politiche e sociali da parte del capitale”.
Va notato che il progetto ideologico di subordinare ogni ragionamento politico alla logica di mercato, sebbene si presenti oggi con accenti forse più intensi, non è certo nato con il neoliberalismo. L’ “individualismo metodologico” e i modelli di ricerca “social choice”, che sono stati componenti chiave dell’ideologia della guerra fredda nelle scelte sociali (particolarmente negli USA e nell’opera di autori come Kenneth Arrow) insistevano egualmente sul fatto che per essere scientifica la ricerca deve basare la razionalità politica sulla logica economica della scelta individuale – di mercato e di impresa. Sostenere l’autonomia del politico in questo contesto è dunque un modo per rifiutare il dominio della logica di mercato e per restaurare un discorso politico che non sia quello del liberalismo economico del libero mercato ma quello della tradizione liberal del pensiero politico, dei diritti, della libertà e dell’eguaglianza – dell’égaliberté , come la chiama Etienne Balibar – che ha forti risonanze nell’opera di Hannah Arendt e che va indietro almeno fino a Jonh Stuart Mill.
Si può riconoscere che queste critiche liberal del neoliberalismo sono oneste ma si deve aggiungere che sono inadeguate ad un progetto democratico. Da un lato, nozioni politiche di libertà ed eguaglianza che non attacchino direttamente le basi economiche e sociali dell’ineguaglianza e della mancanza di libertà, in particolare le leggi della proprietà e del comando sopra la nostra vita produttiva e riproduttiva, fan da sempre prova della loro inadeguatezza. D’altro lato, la potenzialità ovvero l’esistente capacità della gente di governarsi collettivamente, sarà in questa luce sempre oscurata e, quindi, quella vera democrazia che è costituita da una moltitudine capace di determinare decisioni politiche, apparirà sempre e solo una nobile idea per qualche momento di un futuro indefinito. “I teorici liberal che guidano il treno dell’autonomia del politico non arriveranno mai a destinazione”: sottolinea con enfasi un mio amico.
Un secondo gruppo di argomenti viene da sinistra, da autori egualmente ben intenzionati ma egualmente inefficaci, ed è diretto a contrastare la faccia economica del neoliberalismo, i suoi progetti di privatizzazione e di deregulation. Per questo gruppo l’autonomia del politico significa, in primo luogo, ritorno a qualche forma di controllo pubblico e statale. In risposta alla globalizzazione neoliberale che ha eroso i poteri della sovranità nazionale, questi autori pensano ad un ritorno ai meccanismi keynesiani e/o socialisti per riaffermare i poteri dello Stato sull’economia e quindi per contenere i mostruosi poteri della finanza e delle corporations. Si possono riconoscere appelli sia impliciti che espliciti ad un “ritorno dello Stato” come ad una forza che blocchi il neoliberalismo, nell’opera di alcuni intellettuali nordamericani e europei: Paul Krugman, Alvaro Garcia Linera e Thomas Piketty. Noi guardiamo agli autori di questa versione dell’autonomia del politico come alleati e i loro propositi ci sembrano simpatici ma – essendo noi, direi per natura, incapaci di esprimere positivamente la desiderabilità dello Stato e dell’autorità pubblica – troviamo che gli appelli contemporanei a favore di un controllo statale keynesiano o socialista, sebbene presentati in maniera eminentemente pragmatica, siano essenzialmente poco realisti e realizzabili. Non esistono più le condizioni sociali e politiche sulle quali questi progetti erano basati nel ventesimo secolo. Sotto la regola neoliberale i sindacati tradizionali e le organizzazioni della classe operaia sono stati distrutti, scannati e le associazioni che stanno alla base della cittadinanza politica sono state svuotate al punto da generare nostalgia persino tra le élites della destra. Questo non significa che si debba abbandonare ogni speranza e rassegnarsi alla regola neoliberale ma piuttosto che dobbiamo costruire un nuovo punto di partenza alternativo che coinvolga la vita produttiva e riproduttiva delle moltitudini quali esse sono oggi – riconoscendone le potenzialità e cercando di realizzarne la capacità di organizzazione e di cooperazione.
Infine un piccolo gruppo di intellettuali di sinistra si eccita per l’autonomia del politico in forme di avanguardia, spesso presentate come risposta all’incapacità dei movimenti sociali odierni, movimenti orizzontali, a rovesciare le strutture capitaliste esistenti e a porsi il problema di prendere il potere. Slavoj Zizek, per esempio, seguendo Alain Badiou, proclama: “una nuova figura di Padrone (in senso kojeviano) è necessaria… (e incalza) una nuova Thatcher della sinistra: un leader che sappia ripetere il gesto della Thatcher in una direzione opposta”. Conoscendo il lavoro di Zizek, noi non leggiamo queste affermazioni in maniera letterale e cioè come la proposta di innalzare qualche leader gauchista alla posizione di un’autorità ultima e definitiva. Non gli chiediamo chi dovrebbe essere il nuovo padrone e neppure se lo stesso Zizek stia presentandoci una application for job… le proclamazioni di Zizek vanno piuttosto comprese come un gesto provocatorio, sorretto da un lato dalla comprensibile frustrazione dinnanzi al venir meno di movimenti leaderless – senza leader (egli scrive al principio del 2013 quando Zuccotti Park, Tahrir Square e Puerta del Sol erano state ripulite dalla polizia) e d’altro lato condizionato dalle sue dogmatiche assunzioni psicanalitiche riguardo alla formazione dei gruppi – affermazioni che ovviamente non condividiamo. Jodi Dean, esprimendo simili frustrazioni dinnanzi alla sconfitta di Occupy ma senza l’abilità di Zizek a nascondersi dietro ambigue ed impertinenti provocazioni, accentua il tema di una leadership di avanguardia e propone la fondazione di un nuovo partito comunista. Come ci sembra di aver già detto, dato l’ampio sviluppo di sistemi immunitari sulla scena dei movimenti, ci sembra impossibile oggi – sia resa grazia a Dio! – imporre comitati centrali e leadership tradizionali sopra movimenti sociali dinamici e creativi.
Queste diverse affermazioni dell’autonomia del politico, dai liberal fino alla sinistra radicale, non esprimono soltanto il fatto di essere timorose e quasi ipnotizzate dall’autorità del neoliberismo ma anche una fede nella sovranità come un baluardo per restaurare il potere della sinistra. È vero, come d’altra parte ammettono molti di questi autori, che il neoliberismo ha minato i tradizionali poteri politici sovrani. Non bisogna guardare molto lontano per registrare la maniera nella quale in Europa le forze del capitalismo globale hanno amministrato la crisi dal 2008 e la forma, alquanto inelegante, con la quale i leader del capitale finanziario, andando oltre ogni ostacolo, attraverso la pressione dei “mercati”, hanno imposto la loro volontà non solo sugli Stati debitori ma su tutti i Paesi europei. Le società europee sono state letteralmente ricostruite seguendo i criteri gerarchici creati dal potere del denaro. Ne sono venute nuove configurazioni coercitive della divisione del lavoro (precarietà, disoccupazione di massa etc…), l’organizzazione aleatoria ma sistematica delle infrastrutture produttive, le scale salariali variabili nel riordino delle norme della riproduzione sociale, e i diversi disegni e le misure alternative rigidamente proposte, nei programmi di exit dalla crisi, ma che in realtà servivano per approfondire, attraverso la crisi, le divisioni di classe. Il capitale finanziario sotto comando neoliberale si è così liberato da ogni bisogno di rispondere alle tradizionali strutture politiche della rappresentanza e del funzionamento dei governi nazionali: meccanismi elettorali, strutture giuridiche fondamentali, e chi più ne ha più ne metta.
Quei richiami alla sovranità sono dunque attualmente ineffettuali. Ma anche pericolosi. Pericolosi perché perdono di vista che cosa è stata la sovranità nella sua storia e ciò che ancora vuole essere. Essa ha voluto sempre e solo staccare il potere dai soggetti, centralizzare il potere di decisione contro i soggetti, imporre il dominio sulle loro vite, mandarli a morire in guerra. Il problema che abbiamo, è quello di difenderci dalla sovranità. Abbiamo cercato di farlo, nei secoli della modernità, limitandola, togliendole almeno parte del carattere “assolutista”, ancor peggio, “coloniale” che essa aveva man mano assunto. Ma quei modi di controllarla si sono consumati. Non vorrei qui fare il prof. di storia del pensiero politico e ancora una volta mostrare come due idee regolative del mondo borghese per organizzare (e cioè eventualmente per limitare) la sovranità – quelle legate alla proprietà ed alla libertà e quelle legate alla rappresentanza – si siano trasformate da illusorie forme di controllo del sovrano in figure del suo dominio. Della prima dannata conversione, quella della proprietà e della libertà borghese nella struttura del comando capitalista attraverso il mercato, abbiamo già cominciato a dire. Ma della seconda, quella della rappresentanza che costituisce la sovranità, c’è qualcosa da aggiungere.
Vale la pena qui di ricordare l’imbroglio montato da Rousseau. Che, da un lato, fa partecipare gli individui alla fondazione del pubblico sovrano, che così definisce: “come la natura concede a ciascun uomo un potere assoluto sulle sue membra, il patto sociale dà al corpo politico un potere assoluto su tutte le sue; ed è questo medesimo potere che, diretto dalla volontà generale, porta il nome di sovranità” – dall’altro maledice la proprietà privata – “il primo uomo che disse questo è mio” ma il buon Rousseau che è stato così lucido e severo quando identifica la proprietà privata come sorgente di ogni corruzione e causa dell’umana sofferenza inciampa subito – quando confronta la proprietà e quella volontà generale che gli aveva risolto il problema della sovranità. Dato che la proprietà privata genera diseguaglianza, come si può creare (inventare) un sistema politico nel quale ogni cosa appartenga insieme a ciascuno e a nessuno (come avveniva, meglio, come avrebbe dovuto avvenire, in quella volontà generale che attribuiva a ciascuno e a nessuno la sovranità)? Qui la trappola si chiude sul buon Jean Jacques. Se il concetto di pubblico è posto infatti per rispondere alla domanda: che cosa appartiene a ciascuno e a nessuno? – e la risposta di Rousseau: è quanto appartiene allo Stato, in questo caso Rousseau ha inventato solo qualcosa che adorna, imbellisce, mistifica la continuità della presa di possesso del comune da parte di individui proprietari. E cerca di convincerci che essa ci includa. È legittimo che il pubblico assuma i nostri diritti e prenda decisioni riguardo a quello che produciamo – così avanza il ragionamento – quando il “noi” sia di nuovo sospinto (malgrado la volontà generale) verso una base individuale, verso la proprietà privata – quella stessa base dalla quale eravamo trionfalmente usciti in nome della volontà generale. Ecco l’implacabile logica del pubblico pragmatismo.
Gli intellettuali conservatori hanno da molto tempo smascherato le pretese democratiche della rappresentanza politica ed il Rousseauismo romantico e sebbene i loro argomenti siano stati spesso rivolti contro la stessa democrazia, essi contengono un nodo di verità. Già all’inizio del ventesimo secolo, per esempio, Roberto Michels teorizzò la “ferrea (o bronzea) legge dell’oligarchia” riguardante i partiti politici e l’inevitabile loro chiusura in una piccola clique. Il destino della mistificazione sovrana attraverso la rappresentanza era qui potentemente alluso. Oggi molti conservatori sostengono senza reticenza che le pretese democratiche della rappresentanza sono false. Basti qui ricordare quale straordinario esempio di questo atteggiamento sia dato dalla decisione della Suprema Corte americana (2010 Citizens United) che rimuove ogni limite a quanto individui e corporations possono spendere per sostenere candidati alle elezioni politiche. Mentre, a qualunque osservatore, la liceità di contributi illimitati sembra chiaramente costituire corruzione del sistema rappresentativo poiché essi garantiscono l’influenza di alcuni contro gli altri rappresentanti, la decisione della Corte muove – per così dire – dalla convinzione che il sistema rappresentativo sia già corrotto e non possa essere diverso. Consideriamo infatti l’equazione che il Justice Anthony Kennedy, rappresentando la maggioranza della Corte, stabilisce tra il rapporto del rappresentante al votante e al contributore. “È nella natura di un rappresentante eletto di favorire certe politiche e, come corollario necessario, di favorire i votanti e i contributori che sostengono queste politiche. Bisogna ben capire che c’è una sostanziale e legittima ragione – pur non la sola – di dare un voto, ovvero un contributo finanziario, ad un candidato piuttosto che a un altro, se questo candidato risponde producendo risultati politici a favore dei supporter. La democrazia è fondata su questa corrispondenza”. Quando si legge il ragionamento di Kennedy, che fa eco a quello di Michels, si comprende quanto sostanzialmente falsa sia la richiesta di una democratica rappresentanza politica.
Ciò detto, permettetemi di ritornare su un punto sul quale altre volte ho cercato di porre un’alternativa al potere sovrano: di tornare cioè al concetto di potere costituente. È un atto rivoluzionario, un evento concepito come un’eccezione giuridica che esprime ex nihilo un nuovo ordine politico: questa la sua definizione consueta. La rivoluzione americana o quella francese o quella russa ne costituiscono l’esempio più citato. L’atto di “prendere il potere” è qui definito dall’unità spaziale e temporale dell’evento rivoluzionario vittorioso. La sovranità del potere costituente deriva dunque, in termini giuridici, precisamente dal suo carattere di eccezionalità. Ora, quella mia assunzione è stata criticata negli ultimi decenni, per esempio da Giorgio Agamben e da Jacques Derrida. Per l’uno e per l’altro si poteva criticare in maniera convincente la nozione giuridica di potere costituente nella sua pretesa di separarsi dal potere costituito (per dirlo con Derrida: “la violenza della fondazione della legge conserva la violenza della conservazione della legge e non può rompere con essa”). E tuttavia, una volta accettata questa critica, resta valida la concezione del potere costituente che noi avevamo proposto perché impiantata non sulla sua figura giuridica ma sulla materialità del processo rivoluzionario. Noi possiamo così passare dal potere costituente all’azione costituente, dal potere costituente come concetto giuridico al potere costituente come dispositivo politico. Questo passaggio ci offre una base sovversiva che svuota ogni legame alla nozione di un evento unificato e propone il processo rivoluzionario come una macchina aperta e plurale che produce progressivamente le sue norme. Al fine di riconquistare utilità al concetto di potere costituente, oltre le sue configurazioni nel pensiero giuridico e politico, è necessario sempre differenziare, riconoscere la sua eterogeneità sociale e la sua durata temporale, configurarlo cioè come una potenza continua che si replica ed istituisce sempre nuove figure.
Insistiamo qui su alcuni concetti-chiave, meglio, su alcune nuove condizioni politiche, per ridefinire il potere costituente oltre il suo modello moderno. In primo luogo, si deve considerare la radicale differenza di come gli apparati giuridici ed amministrativi sono posizionati rispetto a – e successivamente assorbiti da – le strutture economiche della società dominata dal capitale globale. La società come un tutto è progressivamente sussunta nei circuiti dell’organizzazione economica e del comando capitalista, innanzitutto attraverso l’azione del capitale finanziario che riorganizza la divisione del lavoro a livello globale, si appropria profitto dalle forme materiali e immateriali del lavoro sociale ed estrae rendita dalla produzione e riproduzione della vita e dalla comunicazione/circolazione del valore. Il denaro è il veicolo primario attraverso il quale la finanza comanda il “comune produttivo” (productive commons), appropria il valore che esso produce e lo rende funzionale allo sfruttamento ed alla gerarchia dell’organizzazione sociale.
In secondo luogo, la costruzione del mercato globale indebolisce i poteri degli Stati-nazione e diminuisce la loro autonomia costituzionale. Gli Stati-nazione mantengono importanti poteri giuridici, economici ed amministrativi, evidentemente, ma essi sono progressivamente situati dentro, o anche subordinati a strutture e istituzioni del governo globale, oltre che alle domande del mercato capitalistico globale. Il denaro e la governance globale sono incluse una nell’altra e supportano le strutture giuridiche della società capitalistica globale.
In terzo luogo, nel processo di questa trasformazione biopolitica della società, le figure della forza lavoro e della cittadinanza si sovrappongono con una tale intensità che i conflitti sociali, economici e politici risuonano attraverso le strutture del potere ed amplificano l’un l’altro. L’immersione del lavoro vivo nella costituzione della soggettività politica crea una serie proliferante di antagonismi che scorrono attraverso ogni realtà istituzionale.
In questa situazione il concetto di potere costituente espresso nella tradizione giuridica moderna, come un potere originario incondizionato, comincia a perdere il suo significato. Si potrebbe concludere a questo punto che forse varrebbe la pena di abbandonare il concetto e smettere di parlarne. Pensiamo tuttavia che far questo sarebbe privarsi di un importante strumento di comprensione dell’espressione delle forze antagoniste e del loro potenziale per la trasformazione sociale. È quindi meglio ridefinire il potere costituente alla luce delle condizioni attuali.
Vediamo cosa succede nelle lotte. Strappare il potere costituente all’autonomia del politico al fine di congiungere insieme la critica del politico, dell’economico e del sociale può essere riconosciuto chiaramente nei più forti movimenti che agiscono contro l’ineguaglianza, le privatizzazioni e il potere della finanza. C’è stato del magico nell’aria quando i militanti hanno costruito accampamenti urbani a Il Cairo o a Istanbul, a Madrid, a New York, a Oakland o a Rio de Janeiro – hanno creato spazi urbani comuni, non più privati né pubblici ma caratterizzati da accesso libero e da sperimentali meccanismi di un’amministrazione democratica. Creare spazi urbani comuni è stato sperimentato come antidoto ai veleni della privatizzazione neoliberale – e queste esperienze sono sintomatiche di una lotta sempre più larga che pone il comune contro l’egemonia della proprietà privata e della finanza. Attaccare la proprietà privata ed insistere sulla cooperazione sociale ed il comune come motore di nuovi processi costituenti, non significa abbandonare attualmente il desiderio di avere accesso ai beni sociali e di consolidare la sicurezza della vita. Al contrario, portare la lotta dall’appropriazione al politico. Al contrario, con ciò si riconosce che la proprietà privata è l’ostacolo fondamentale alla sicurezza e un blocco all’accesso alle necessità della vita per una larga maggioranza. Inoltre, oggi, data la progressiva figura sociale cooperativa della produzione, il diritto di proprietà non può più essere diritto a monopolizzare dei beni e a permettere poteri individuali di decisione, non può più essere il diritto di un lupo che difende gelosamente il suo bottino da altri lupi, ma deve esser trasformato nel diritto al comune, in un exit dalla solitudine attraverso la produzione, verso la cooperazione ed un’esistenza sociale nell’eguaglianza e nella solidarietà.
Infine, la trasformazione del potere costituente in un processo continuo, è stato approfondito attraverso la sua immersione nel tessuto della biopolitica: il contenuto del potere costituzionale tende ad essere la vita stessa. Gli attivisti e i militanti non domandano solo un aumento del loro reddito o il sostegno ai servizi di welfare ma cercano di illuminare il fatto che tutta la vita – tutti i lavori di produzione e di riproduzione – sono soggetti a sfruttamento e ad estrazione di plusvalore. Nella continuità di queste lotte risiede un’espansione di bisogni, desideri e domande sociali. Il potere costituente può divenire una composizione di diverse singolarità costituenti – e così, concepire il potere costituente come un pluralismo moltitudinario significa rompere con ogni feticistica concezione dell’unità politica e finirla quindi con i concetti di popolo e di nazione posti tradizionalmente come unità.
A questo punto, alla luce delle lotte che hanno ridefinito il potere costituente come un processo continuo, radicalmente plurale e biopolitico, siamo in una posizione migliore per riconoscere la distanza e l’incompatibilità del potere costituente con la rappresentanza e la sovranità. Sempre di più le pretese democratiche di una rappresentanza politica vengono ampiamente riconosciute come vuota turpitudine e, non a caso, parlare in nome degli altri è stato proscritto nei movimenti sociali. In luogo della rappresentanza, cooperazione e aggregazione sorgono come meccanismi attraverso i quali una pluralità di forze politiche differenti agisce in comune. L’andarsene dalla rappresentanza appare in modo corrispondente in campo economico. Quando l’attività economica consiste in larghi network di cooperazione sociale che producono e riproducono la vita – soggettivando la società – allora il mandato rappresentativo non ha più senso. In questo contesto ogni ricorso alle nozioni di volontà generale sembra completamente fuori posto ed illegittimo. La volontà di tutti è già organizzata nella cooperazione.
L’esclusione della sovranità dal potere costituente diviene ancor più chiara. È impossibile oggi definire una forma di potere costituente concepita in termini di trascendenza o “eccezione”. Il sovrano richiede unità – un’unità che è irrimediabilmente rotta dal pluralismo radicale del concetto contemporaneo di potere costituente. Laddove le decisioni sovrane sono sempre vuote poiché il sovrano è separato, sopra la società ed agisce nell’eccezione, il potere costituente oggi è sempre pieno di contenuti sociali al punto di essere eccedente. Per ridefinire il potere costituente, l’eccezione del potere sovrano deve essere rimpiazzata dall’eccesso, cioè dalla natura eccedente della produzione e della cooperazione sociale.
Per concludere, che cosa significa, allora per la moltitudine prendere il potere? Prendere il potere rimane per noi un obiettivo centrale e, come abbiamo cercato di spiegare, non può semplicemente significare il rovesciamento della relazione di dominio e in ultima istanza, mantenere la macchina del potere sovrano semplicemente cambiando colui che siede alla guida. Per una moltitudine prendere il potere è in primo luogo un compito: inventare nuove istituzioni non-sovrane.
Attenzione tuttavia. Quando i nostri occhi si fissano sul politico istituzionale e assumono che il popolo (l’elettorato etc…) abbia le capacità necessarie per organizzare e sostenere programmi a lungo termine o per amministrare collettivamente le istituzioni – insomma, che il popolo sia capace di democrazia – ciò spesso si mostra come un’illusione. Se il popolo fosse composto da angeli – saremmo tentati di dire facendo eco al realismo, meglio, al cinismo di James Madison – allora e solo allora una vera democrazia sarebbe possibile. Il solo reale ed effettivo modo per rispondere a queste domande, oggi, è invece quello di spostare la nostra prospettiva dal terreno politico a quello sociale ovvero, per meglio dirlo, di combinare i due. È quanto i movimenti ci indicano. Soltanto allora saremo capaci di riconoscere e di promuovere, attraverso gli estesi circuiti e le capacità di cooperazione e di organizzazione della moltitudine, nuovi processi politici democratici: comprendendo che i talenti della cooperazione sociale sono una solida base dell’organizzazione democratica.
Accadde alla società sovietica, nei primi anni ’20 – parzialmente, brevemente – di connettere l’attività costituente radicalmente democratica dei soviet ai processi istituzionali di trasformazione economica e sociale. Per un periodo, la rivoluzione divenne una vera e propria macchina istituente, ovvero, piuttosto, un complesso di istituzioni costituenti. La formula proclamata da Lenin nel 1920: “comunismo = soviet + elettrificazione” combina una forma di organizzazione politica con un programma di sviluppo economico. Il progetto sovietico di sviluppo industriale incontrò in fretta ostacoli insormontabili, dovuti in parte al basso livello di industrializzazione russo e alle insufficienti basi industriali in termini di risorse sociali e culturali della popolazione – per non ricordare l’isolamento internazionale e l’accerchiamento da parte dei Paesi capitalisti. Ciò nonostante possiamo imparare dalla formula di Lenin la necessità di stringere la coppia “organizzazione politica rivoluzionaria e progetto sociale di trasformazione”.
Sarebbe anacronistico, naturalmente, riproporre un qualsiasi piano di modernizzazione economica. Ci muoviamo oggi su un terreno biopolitico ed il tema non è semplicemente quello di produrre beni ma piuttosto un’espansione ontologica dell’essere sociale.
L’impegno di oggi prende chiaramente forma quando sia situato nel quadro dello sviluppo capitalistico. Tra XVIII e XIX secolo – insegna Marx – il centro di gravità e il modo dominante di produzione capitalista è passato dalla manifattura (che fonda essenzialmente sulla divisione di lavoro gli aumenti di produttività) all’industria su larga scala (che aumenta la produttività introducendo macchinari complessi e nuovi schemi di cooperazione). Estendendo la periodizzazione di Marx al XXI secolo, ecco il centro di gravità del capitale spostarsi dall’industria su larga scala alla fase del general intellect – che è produzione basata su circuiti sempre più intensi e larghi di cooperazione sociale, predisposti da algoritmi macchinici come base per estrarre valore dalla produzione e riproduzione della vita sociale. In questa fase la distinzione tra economico e sociale viene progressivamente saturata. Questa démarche è strettamente connessa all’analisi delle trasformazioni del modo di produzione capitalista dalla manifattura (con la sussunzione formale della società e l’estrazione di plusvalore assoluto) alla fase dell’industria su larga scala (con la sussunzione reale della società e l’estrazione di plusvalore relativo) e infine alla fase dell’organizzazione produttiva del general intellect (con la sussunzione “cognitiva” della società attraverso un’incrementale cooperazione e uno sfruttamento finanziario estrattivo). La produzione e la riproduzione socializzate sono attività biopolitica. Ora, contro il lavoro alienato (cioè isolato, individualizzato, strumentalizzato) sorge una comune resistenza che, se nel regime industriale si è espressa in maniera estremamente potente come “rifiuto del lavoro”, oggi è espressa in nuove forme di antagonismo che sono attive sull’intero tessuto sociale. Il potere costituente non può dunque essere ancora concepito in termini puramente politici; deve piuttosto esser connesso ai comportamenti sociali ed alle nuove tecnologie di sussistenza, resistenza e trasformazione della vita. Il processo della costruzione di nuove istituzioni deve essere assunto dentro questa nuova materialità.
La nostra risposta alla domanda da cui siamo partiti non è ancora una proposta sostantiva ma piuttosto una linea-guida metodologica ed in ogni caso, non ci si deve aspettare qui una risposta che offra una soluzione e metta a riposo il problema. La nostra risposta è quella di chi riprende la palla e la rilancia, creando così una dinamica, un movimento. Per trovare le basi di nuove democratiche forme di un’organizzazione politica e istituzionale, cominciamo dall’investigare le reti cooperative che animano la produzione e la riproduzione della vita sociale.