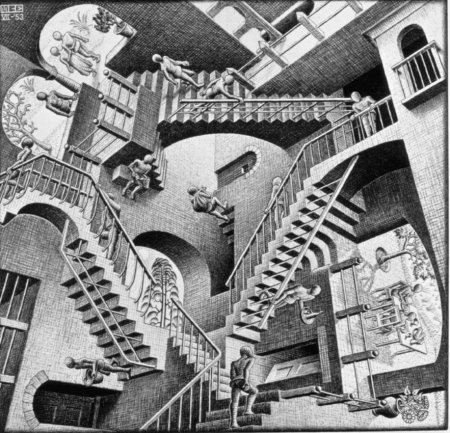Ora che sono andati in frantumi i due pilastri su cui si erigeva la cittadinanza novecentesca, e cioè la centralità del lavoro, da una parte, lo Stato sociale, dall’altra, l’esigenza di rifondare il discorso sulla cittadinanza sembra trovare risposta nelle lotte per i beni comuni, cioè in pratiche di riscrittura “dal basso” delle relazioni fra persone e cose che rifiutano il modello giuridico della proprietà pubblica e privata, e aspirano a collocare il rapporto fra collettività e beni, così come quello fra collettività e istituzioni su un altro piano.[1] Ne sono prova le recenti numerose occupazioni di spazi culturali – e non – di proprietà pubblica o privata, nate per difendere la destinazione originaria del bene, come nel caso dei teatri occupati in molte città d’Italia, ovvero per restituire una destinazione “socialmente orientata” a beni già produttivi e poi abbandonati dal titolare.
Le nuove occupazioni
e la “lotta per il diritto”
Molte occupazioni nascono dunque per difendere diritti sociali o, per usare un gergo “di movi-mento”, per produrre welfare dal basso. E in questo guadagnano legittimità.[2] Nelle “nuove” occupazioni si allestiscono spettacoli teatrali, si organizzano rassegne cinematografiche, corsi di formazione per adulti, “doposcuola” per bambini, nascono biblioteche, palestre popolari, scuole di italiano per migranti, scuole di lingue per autoctoni, spazi per bambini e molto altro: attività aperte al quartiere e alla città, capaci di riattivare circuiti di produzione di benessere sociale, ricreando legami di solidarietà orizzontale e generando nuove forme di ricchezza che forse non è percepita in termini di PIL, ma incide positivamente sulla qualità della vita dei residenti e di chiunque voglia fruirne.
Le nuove occupazioni non sono, insomma, solo luoghi di socialità giovanile e non sono soltanto l’esito di gesti di rottura nei confronti di una legalità percepita come estranea e ostile, ma mirano, oltre a ciò e prima di ciò, a restituire beni materiali di valore e, insieme ad essi, risorse immateriali come conoscenza, cultura, relazionalità, alla cooperazione sociale. Non senza smascherare le storture del sistema (manovre speculative, ardite operazioni di privatizzazione [3] dismissioni dovute a “tagli” in ossequio al patto di stabilità) – o le vere e proprie deviazioni da esso (investi- menti immobiliari della criminalità organizzata legati a operazioni di riciclaggio di danaro)[4] – che costellano la storia degli immobili occupati, spesso all’insegna di una partnership pubblico-privato che sacrifica l’utilità sociale a trame affaristiche più o meno lecite. In questo cambia anche la percezione del rapporto con il territorio e con le istituzioni.
Le pratiche del comune che da queste esperienze di occupazione prendono vita rivendicano la propria legittimità, in ciò cercando assetti stabili pur all’interno di una dimensione necessariamente dinamica e in continua trasformazione. Di qui la posizione dialettica, la sfida nei confronti delle istituzioni territoriali, resa talora manifesta dall’assunzione di denominazioni – la Libera Repubblica di S. Lorenzo, che si dipana a partire dall’occupazione dell’ex-cinema Palazzo a Roma, il Municipio dei Beni Comuni a Pisa, sorto intorno all’occupazione dell’ ex Colorificio Toscano – che se, da una parte, indicano la volontà di impossessarsi della terminologia propria della Sovranità statale, nello stesso momento in cui netta è la critica alla rappresentanza politica e alla sottrazione del comune da parte del pubblico statuale e delle sue articolazioni,[5] dall’altra esprimono l’aspirazione a dare vita a vere e proprie “istituzioni del comune”,[6] ciò che ci si può attendere sarà avvertita come ancor più urgente alla luce della torsione postdemocratica a cui sono sottoposte in maniera crescente le istituzioni repubblicane.
Siamo insomma ben lontani dalla sussidiarietà orizzontale, principio – ora di rilevanza costituzionale (art. 118 ult.co.) – intorno al quale una certa pubblicistica e una parte dell’associazionismo tendono a riaggiustare il discorso dei beni comuni ponendolo sotto l’ombrello della supervisione pubblica, sia in termini di individuazione e condivisione di obiettivi, sia in termini di controllo delle modalità di realizzazione degli stessi da parte della pubblica amministrazione. Qui siamo in effetti da tutt’altra parte, in una dimensione in cui sono patenti le spinte antipro- prietarie ed è patente la dimensione del conflitto, perché l’obiettivo è la restituzione all’uso comune di ciò che è stato catturato dai dispositivi pubblico-privatistici di appartenenza esclusiva.
Tanto non significa che queste stesse pratiche del comune, quali avamposti di una nuova idea di cittadinanza, rifiutino il diritto come strumento di regolazione dei conflitti. Al contrario, emerge un interesse per il diritto in una parte anche significativa del movimento, che appare inedito rispetto ad analoghe esperienze del passato.
Se, in una prima fase, il ricorso al diritto ha avuto natura meramente tattica, essendo finalizzato per lo più a “salvare” le varie occupazioni dai tentativi di sgombero portati avanti dai vari “aventi titolo” (proprietari o affittuari, ecc.) attraverso il rinvenimento di dispositivi giuridici che potessero prestarsi allo scopo,[7] nella fase corrente il coinvolgimento militante di un gruppo di giuristi sta dando luogo, da una parte, a un’elaborazione dottrinale estremamente avan- zata nel senso, ad esempio, di una profonda revisione critica dell’assolutezza del diritto di proprietà,[8] dall’altra a un inedito interventismo dei movimenti su un terreno più propriamente riformista, dacché si ritiene che le istanze di cui sono portatrici le mobilitazioni sfociate nelle occupazioni di cui parliamo debbano ora tradursi in un’attività di vero e proprio drafting legislativo finalizzato alla redazione di proposte di legge aventi come oggetto questioni come i beni comuni, il reddito di cittadinanza, il diritto all’abitare, e altri ancora.
Tale è, in particolare, l’obiettivo affidato alla riapertura della Commissione Rodotà (oggi Costituente dei beni comuni), commissione che ai tempi del secondo governo Prodi era stata investita del compito di redigere un testo di riforma della disciplina dei beni pubblici contenuta nel Libro III del codice civile, che nell’articolato che congedò nel 2008 aveva introdotto la nozione di beni comuni come tertium genus accanto ai beni pubblici e ai beni oggetto di proprietà privata, e che ora, forte del ruolo pathbreaking in tal modo giocato nel diritto e della risonanza da ciò derivatale presso i movimenti di lotta per i beni comuni, viene riproposta in forma non istituzionale e con una composizione “mista” di giuristi e attivisti poli- tici, come laboratorio di sperimentazione di forme di produzione giuridica “dal basso”. Cosa che di per sé suscita molte riflessioni e forse qualche dubbio, ma che ha un significato politico notevole, posto che esprime la volontà di ridare senso a una sovranità popolare ormai in disarmo, “riappropriandosi” addirittura della potestà legislativa e lanciando una sfida aperta alle élite arroccate dentro le istituzioni della Repubblica. Ma su questo torno in seguito.
Fra costituito e costituente
È nelle cose che un ritorno militante al diritto si confronti primariamente con la Costituzione repubblicana, fondamento normativo della cittadinanza novecentesca. E, specificamente, con la questione dell’attuazione della Carta costituzionale, e con il problema, oggi al centro di un vivace dibattito, della sua attualità.[9] Da una parte, infatti, si guarda alla Costituzione del 1948 come alla rivoluzione promessa – secondo le celebri parole di Calamandrei – e mai attuata. Da oltre un decennio almeno, cioè da quando l’apposita Convenzione licenziò la Carta di Nizza, la Costituzione repubblicana viene contrapposta a quell’idea di economia sociale di mercato, già presente nel Trattato sull’Unione Europea (dove è espressamente richiamata all’art. 3, 3° co. TUE) e, secondo l’opinione di molti,[10] filtrata nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea attraverso la ricollocazione della proprietà privata fra le libertà fondamentali, il riconoscimento della proprietà intellettuale, la marginalizzazione del lavoro e le sue tutele, l’affievolimento dei diritti sociali in termini di garanzia ed effettività.
L’ispirazione post-welfarista del diritto costituzionale dell’Unione Europea è allora contrastata da chi ritiene che i valori della Costituzione democratica siano per contro ancora attuali e debbano trovare affermazione attraverso la piena attuazione della parte sociale della costituzione (artt. 35-47)[11] con la finalità di arginare le politiche neoliberali dominanti a livello globale. Non è un caso che le mobilitazioni intorno ai beni comuni, dalla campagna per la ripubblicizzazione dell’acqua, alla difesa degli spazi occupati, cerchino proprio in quella parte della Costituzione i princìpi giuridici sulla base dei quali erigere un nuovo statuto dei beni in termini di accesso e di gestione partecipata. Vengono alla ribalta allora l’art. 43, che prevede l’affidamento di servizi pubblici essenziali e di imprese di preminente interesse generale a comunità di lavoratori o utenti, l’art. 42, 2° co., che lega il legittimo esercizio della proprietà alla realizzazione della sua funzione sociale, l’art. 41, che subordina la libertà di impresa all’utilità sociale e al rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana.
È una posizione che tende ora a radicalizzarsi alla luce delle più recenti vicende politiche, nelle quali il “sovversivismo dall’alto” delle classi dirigenti italiane[12] mostra il suo volto protervo e allarmante, spingendo ad aggrapparsi alla Costituzione quale estremo baluardo contro il tracollo della democrazia e il repentino consolidarsi dello stato d’eccezione.
Dall’altra parte è la posizione – minoritaria, ma non isolata – di chi considera l’intero disegno costituzionale inattuale e superato sul piano storico, economico e politico. Su questo diverso versante, la Costituzione lavorista del 1948 è per contro letta come l’esito di un compromesso fra capitale e lavoro, e di una conseguente operazione di “costituzionalizzazione” della lotta di classe, irrimediabilmente legati a una fase del capitalismo, quello industriale della cosiddetta produzione di massa, troppo distante dalla fase attuale per pretendere di dare fondamento al diritto e alla società contemporanei. Contrattazione collettiva e diritto di sciopero, gli strumenti attraverso cui la Costituzione del ’48 interpreta le figure soggettive di capitale e lavoro mirando a convogliare la spinta trasformativa di cui è portatore il movimento operaio nell’organizzazione delle strutture costituzionali della repubblica democratica, già a partire dagli anni Settanta del Novecento esauriscono la loro funzione per la drastica ridefinizione a cui vanno incontro le stesse soggettività di capitale e lavoro.[13] Peraltro, secondo questa lettura, le politiche neoliberali non si pongono realmente come modello alternativo, per così dire esterno, rispetto alle costituzioni lavoriste del secondo dopoguerra, ma operano al loro interno modificandole sia sul piano formale (vedi l’introduzione della regola aurea del pareggio di bilancio), sia sul piano materiale, attraverso una radicale ridefinizione della relazione pubblico/privato che passa per la patrimonializzazione della sovranità e l’invenzione dello “Stato regolatore”, assecondando un progetto di decostituzionalizzazione di portata globale che si manifesta attraverso il frammentarsi dell’ordine giuridico, il moltiplicarsi incontrollato delle fonti, nazionali e sovranazionali, e il riassemblaggio delle stesse in sistemi pluralistici in cui la Carta costituzionale perde inevitabilmente di centralità.[14]
Da parte di chi si avvicina ora al diritto per rivendicare i propri diritti di cittadinanza collocandoli in una prospettiva non più solo individuale ma collettiva, la critica alla centralità del lavoro propria del disegno costituzionale appare condivisibile ed è di fatto condivisa. Quando non per cultura politica, per condizione personale. È infatti innegabile che, con la crisi del lavoro fordista, a cui ora si affiancano e sovrappongono molteplici nuove forme di lavoro estranee al vecchio sistema delle relazioni industriali, milioni di persone in questo Paese, e certamente i trenta-quarantenni protagonisti delle lotte per il comune, restano ai margini del progetto costituzionale, escluse dalla garanzia di un’esistenza libera e dignitosa (art. 36 cost.), sia perché prive della garanzia di condizioni materiali di sussistenza, sia perché escluse – in quanto estranee alla categoria dei lavoratori salariati – dall’accesso a quegli strumenti di partecipazione politica – il sindacato (art. 39 cost.), lo sciopero (art. 40 cost.) – che contribuiscono alla dimensione della vita activa, cuore della (promessa della) pari dignità sociale dell’art. 3, 1° co., cost., che si esplicita nel comma successivo, dove si prescrive l’obiettivo della rimozione degli ostacoli di natura economica e sociale che «impediscono l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economi- ca e sociale del Paese». Nessun dubbio, quindi, che il lavoro abbia cessato d’essere fattore di emancipazione. O che sia tramontato quel disegno di soggettivazione politica attraverso il lavoro proprio della Costituzione.
L’idea di partecipazione alla cosa pubblica che emerge dalle pratiche del comune è del resto tutt’altra cosa. Essa è strettamente legata all’accesso e alla gestione diretta delle risorse che di volta in volta si assumano come comuni per origine o per destinazione, siano esse l’acqua, la conoscenza in rete, un immobile abbandonato, o lo stesso spazio urbano che si attraversa. Una partecipazione destinata dunque a svolgersi su un altro piano rispetto alle istituzioni della democrazia rappresentativa del Novecento, che sostengono l’architettura politica delle costituzioni del secondo dopoguerra; ma, per altro verso, indissolubilmente connessa alla critica della proprietà pubblica e privata che la Costituzione riconosce e garantisce.[15] Una critica che è tanto più radicale quanto più disconosce rilevanza alla titolarità della proprietà per attribuirla invece all’accesso ai beni e al loro uso.
Di fatto, le pratiche del comune che reclamano ora la scrittura di nuove regole giuridiche – e che interpretano questa stessa produzione di diritto come pratica del comune – non traggono immediatamente alimento dal progetto costituzionale. Nelle linee di fondo, potremmo anzi dire, esse segnano rispetto a questo una discontinuità, sebbene in alcuni casi il rinvio alla Costituzione continui a esercitare un forte richiamo simbolico, come già messo in evidenza. Tentando una sintesi fra le molteplici lotte che variamente interpretano la riappropriazione del comune, potremmo descrivere l’atteggiamento che da esse complessivamente emerge nei confronti della Costituzione come un movimento oscillatorio fra la strategia e la tattica. Perché la creatività con cui vogliono marcarsi queste operazioni di lawmaking non soltanto tende a cercare una legittimazione nella Costituzione, ma configura talora una vera e propria strategia di riappropriazione della stessa, affrancandola dal destino della non attuazione e depurandola dagli aggiustamenti posticci in senso neoliberale. Un atteggiamento apertamente minimalista, per contro, tende a forzare una delle principali istituzioni della cittadinanza novecentesca, ossia l’accesso (diffuso) alla proprietà borghese, nel contempo cercando nella Costituzione stessa quei princìpi utili a definire dispositivi giuridici capaci di difendere il comune e contrastare la sua appropriazione da parte sia del privato che del pubblico. E qui allora si giustifica l’uso tattico del principio della funzione sociale ex art. 42, 2° co., cost., o del richiamo alle comunità di lavoratori o utenti dell’art. 43 cost.
Se entrambe le mosse, o piuttosto solo la seconda e non invece la prima, siano da ritenersi costituenti, nel senso di capaci di creare “incidenti democratici di base”, ovvero di “produzioni istituzionali di democrazia dal basso” o, più radicalmente ancora, in grado di produrre una netta rottura rispetto al “costituito”,[16] è questione complessa, che involge anche, e necessariamente, la concezione del diritto che si assuma e il ruolo che si voglia riconoscere ad esso e alla relazione fra produzione del diritto e sua interpretazione. Se in teoria l’obiettivo di riappropriarsi della Costituzione si pone per definizione dentro l’alveo del sistema vigente, nei fatti le differenze fra i vari segmenti del movimento del comune sono meno significative rispetto alla critica dell’ordine costituito che complessivamente mettono in pratica. Mi sembrerebbe anzi, quanto meno in riferimento al diffondersi delle occupazioni che ho fin qui descritto, che la parola costituente possa essere usata a proposito, e che le sperimentazioni di assetti organizzativi al loro interno, in termini tanto di ricerca di soluzioni giuridiche quanto di creazione di più ampie relazioni politiche, prefigurino modelli di istituzioni del comune. Cosicché il tema della Costituzione può infine mettersi da parte per passare dal testo al contesto.
Il reddito di cittadinanza. Un progetto ambivalente
A cavallo fra la scrittura di un diritto del comune, che parte dallo statuto giuridico dei beni comuni per irradiarsi oltre questo nucleo, e la creazione politica del contesto in cui la produzione di nuovo diritto si colloca, contribuendo a generarlo, si pone la proposta di introdurre con legge ordinaria una forma universale di reddito garantito. Si tratta di una rivendicazione che dà corpo a progetti anche notevolmente diversi fra loro, fatti propri da movimenti, associazioni e partiti politici, e ora iscritta nell’agenda della Costituente dei beni comuni.[17]
Alla base vi è, come noto, la crisi del lavoro. E la crisi del lavoro, su cui molto si è detto e scritto, è in primo luogo perdita di centralità del lavoro salariato materiale, fordista. È però, soprattutto, «sganciamento del lavoro dallo spazio e dal tempo»,[18] intreccio inestricabile fra sfera della produzione e sfera della riproduzione, evaporare dei confini fra lavoro e non-lavoro. In sostanza, asservimento dei ritmi di vita, dei pensieri, delle relazioni, degli affetti alle esigenze del capitalismo cosiddetto cognitivo.
Il lavoro ha dunque smesso di garantire a chi lo svolge una vita degna, e men che meno è oggi la base della partecipazione alla sfera pubblica. Come ci ricorda Rodotà,[19] ciò che dava concretezza all’homo dignus, il rinvio al lavoratore, si perde in quanto è stato spezzato il nesso fra lavoro e dignità. Lo dimostra fra l’altro il fenomeno, relativamente nuovo in Italia, dei working poor, cioè di quelle persone che, pur regolarmente impiegate, sono al di sotto della soglia di povertà.
Sullo sfondo è, ovviamente, la crisi dello Stato sociale. È una crisi che si appalesa innanzitutto nel restringimento del welfare. La promessa della «pari dignità sociale» dell’art. 3, 1° co. cost. vacilla perché è l’intera gamma dei diritti sociali a perdere di effettività. Ma la crisi investe la stessa sovranità statale su più fronti. Sul piano interno, la ristrutturazione del sistema di relazioni industriali contempla ora la possibilità di derogare alle leggi dello Stato, come ha fatto Marchionne anticipando la riduzione delle garanzie del lavoro successivamente realizzata per legge dai governi Berlusconi e Monti. Sul piano esterno, gli ordini economici globali hanno da tempo alterato i compiti e le funzioni dello Stato,[20] ciò che a livello sovranazionale si manifesta attraverso quel patto di bilancio europeo (fiscal compact) che, condizionando fortemente le politiche sociali dei governi nazionali, colpisce direttamente i diritti sociali dei cittadini degli stati membri.
Questi dati interrogano direttamente l’attualità di una Costituzione come la nostra, che pone il lavoro al centro del proprio disegno e fa del lavoratore il modello antropologico di riferimento. E qui una possibile opzione sta nella ricostruzione del significato più profondo delle costituzioni democratiche, da quella di Weimar a quella italiana, incentrate sul lavoro. E quindi nella ricerca del fondamento costituzionale di uno ius existentiae sganciato dal lavoro che proprio nel reddito di cittadinanza troverebbe un forte aggancio.[21]
La consapevolezza di tutto ciò, d’altra parte, contribuisce ad alimentare e a diffondere l’opzione non lavorista, che diventa una cifra politica dei movimenti protagonisti delle occupazioni. La prospettiva qui non è allora il recupero del modello antropologico costituzionale attraverso il ripristino di una serie di garanzie di welfare, ma il netto rifiuto dell’antropologia triste del lavoratore. In questo quadro, diverse sono le giustificazioni filosofiche del diritto al reddito.[22] Fra le tante possibili, quella prevalente fra i movimenti e gli intellettuali, almeno in Italia, si iscrive nella tradizione marxiana. È la lettura post-operaista la quale, muovendo dal celebre Frammento sulle macchine dei Grundrisse – quello, si ricorda, in cui Marx fa riferimento al general intellect – sottolinea che, nel passaggio dal fordismo al postfordismo, è la vita stessa a diventare immediatamente produttiva, tanto da far saltare la distinzione fra lavoro e non-lavoro: il reddito garantito si giustifica allora non sulla base dell’avere (rendita) o del fare (salario) ma del semplice essere, cioè del partecipare in quanto «appartenenti alle reti globali di cooperazione sociale, al processo di accumulazione allargato».[23] In questa prospettiva, il welfare cessa di essere un sistema di sussidi ed “elargizioni” concesse dallo Stato al cittadino/suddito e recupera il profilo di progetto distributivo a vocazione universalista in virtù del quale a cia- scuno e a tutti è dato a compenso del contributo offerto alla produzione collettiva della ricchezza generale.
Di fatto, la rivendicazione del basic income interseca due prospettive politiche diverse, che mimano lo scarto fra costituito e costituente. Da una parte, la carta del reddito di cittadinanza può essere giocata ancora sul terreno costituzionale purché rischiarato dalla dimensione sovranazionale e, specificamente, europea. La via d’elezione è quella dei diritti fondamentali e dello ius existentiae che, nella versione rodotiana, rifiuta peraltro ogni riduzionismo (un reddito che non può essere minimo) e reclama invece il riconoscimento pieno della dignità umana in una prospettiva necessariamente universalista.[24] Sul piano interpretativo, l’enfasi che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riserva al rispetto della dignità umana (titolo I, art. 1) assume una robusta valenza sociale se messa in connessione con la rete di protezione welfarista prevista dall’art. 34 della stessa Carta «…Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà» (comma 3). La norma, letta nella prospettiva della tutela del reddito, costituisce il tassello fondamentale di una complessa intelaiatura normativa di cui è parte il dialogo fra le corti supreme, sovranazionali e nazionali che, attraverso la garanzia del basic income, dovrebbe rendere possibile – secondo alcuni – l’edificazione di un nuovo welfare europeo e di una nuova idea di cittadinanza. Nell’art. 34, il riferi- mento al lavoratore è omesso: l’esigenza al centro del disegno costituzionale italiano di andare oltre il grado zero dell’esistenza si ritrova attualizzato nel diritto europeo nell’impegno di assicurare a tutte e tutti il diritto all’esistenza – un’esistenza ovviamente conforme a dignità umana – attraverso il riconoscimento su base universale del reddito di cittadinanza quale garanzia tanto di condizioni materiali di sussistenza, quanto di vita activa, cioè di «equa par- tecipazione alla vita politica, culturale e sociale», come ha di recente affermato il Tribunale Costituzionale Tedesco,[25] nel censurare una legge federale del 2005 che aveva ridotto i sussidi per indurre i disoccupati a trovare lavoro a ogni costo.
Una ristrutturazione del sistema di welfare che ruoti attorno l’introduzione del reddito di cittadinanza non passa dunque per l’archiviazione del vecchio progetto costituzionale, ma al contrario potrebbe servire a ritrovare il significato emancipatorio proprio delle costituzioni democratiche del dopoguerra, rimettendo al centro del sistema costituzionale un modello antropologico inclusivo: non più il lavoratore, ma la persona immersa nella rete complessa della cooperazione sociale, parte integrante della comunità a prescindere dalla sua collocazione nell’area del lavoro o in quella del nonlavoro (ove a questa distinzione ancora si attribuisca validità). Saremmo in questo modo di fronte a un nuovo compromesso socialdemocratico, adeguato alle dinamiche economico-sociali del postfordismo.
Per altro verso, la rivendicazione del reddito apre squarci ben più radicali ove si coniughi all’opzione non-lavorista. Se si assume il lavoro come disturbo comportamentale della modernità;[26] se si ritiene che la crisi della “società del lavoro” sia giunta a un punto tale che anche le più elementari rivendicazioni non possano trovare ascolto che all’interno «di un grande movimento radicalmente anticapitalistico»;[27] se si assume che i nuovi lavoratori dell’immateriale, punta avanzata dell’attuale produzione capitalistica, siano impegnati in realtà nella produzione non di cultura, ma di immaginario simbolico del semio-capitalismo;[28] e ancora, se si ritiene che la ormai generalizzata condizione di proletarizzazione del lavoro intellettuale reclami l’esercizio dell’insubordinazione contro i modelli fordisti che, a dispetto delle mutate condizioni sociali, continuano a innervare le strutture della cittadinanza; e che tale insubordinazione debba finalizzarsi all’inveramento di una società post salariale nella quale le forme di vita siano liberate dalla subordinazione coatta al lavoro.[29] Se al lavoro si indirizza una critica non solo fenomenologica, comportamentale, ma categoriale, cioè una critica alla sua giustificazione quale termine di opposizione al capitale all’interno del capitalismo,[30] allora la rivendicazione del reddito di cittadinanza assume una valenza antisistema rispetto alla quale il ripensamento dei diritti sociali nel quadro del diritto vigente e lo stesso riferimento alla Costituzione trovano una giustificazione meramente tattica.
Scrittura del testo e produzione del contesto (oltre la critica della performatività del diritto?)
Alla radice della “riapertura” della Commissione Rodotà nella formula della Costituente dei beni comuni è l’idea che i movimenti in lotta, con il dovuto apporto tecnico dei giuristi che ne fanno parte, possano produrre diritto dal basso. La mobilitazione politica non è dunque finalizzata a un legal change affidato nella sua realizzazione concreta alle istituzioni competenti – al parlamento innanzitutto – e quindi ai meccanismi della democrazia rappresentativa. Al contrario, i movimenti assumono su di sé l’iniziativa e la responsabilità di un mutamento giuridico epocale:
dirigere e indirizzare le condotte sociali. È però questa stessa prospettiva a indicare che il diritto, quale dispositivo governamentale, se da una parte vincola, dall’altra abilita, e se “abusato” può dar corpo alla trasformazione.[39]
Si è parlato di una performatività “buona”, che può cogliersi allorché si affianchi a una lettura del diritto come pratica discorsiva l’analisi dei suoi effetti redistributivi. Il diritto non solo detta le regole del gioco, ma distribuisce la posta fra i giocatori: la decostruzione di una regola, la sua rilettura possono dar luogo a una diversa distribuzione del potere economico fra gli attori sociali; contemporaneamente produrre un’azione empowering sul piano simbolico che muta i rapporti di forza.[40] Si può dunque affidare alla scrittura di nuovo diritto una (più o meno moderata) prospettiva di cambiamento? Un diritto dei beni comuni che riesca scalfire il ruolo egemone della proprietà in senso economico e simbolico sarebbe certamente empowering per il 99% degli umani.
Ma, più modestamente, quel che ci si può ragionevolmente attendere dall’esperimento della Costituente dei beni comuni, da questa rinnovata “lotta per il diritto”, è dato da quanto si agita intorno alla stesura del testo. È appunto il contesto conflittuale che fa riferimento alla ed è parte della Costituente ad avere soprattutto rilevanza; le connessioni fra movimenti e lotte che attiva ed estende; le ricadute che l’aspirazione a muoversi dentro una legittimità che non sia più soltanto morale ma anche giuridica può avere in termini di produzione di un nuovo senso comune. Che già è visibile nel consenso che le occupazioni di cui parliamo si guadagnano fra la gente dei quartieri che attraversano. La scrittura di un testo normativo diventa allora strumento di soggettivazione politica, che ci si augura possa estendersi anche oltre i gruppi che già vede coinvolti. In questo senso, il ricorso al diritto, quale che sia l’esito dell’attività di drafting e il suo possibile impatto sul sistema vigente, promette trasformazione in quanto «prassi che … gioca l’opportunità di emancipazione sullo stesso terreno – concettuale e pratico – delle tecniche di potere con cui è confrontata»[41] percorrendo la via stretta che separa una rappre- sentanza politica ormai vuota da «un’irrappresentabilità sempre a rischio di trascolorare in ineffettualità».[42] In sostanza, una mossa che ha anche il senso di una sfida al cinismo che affligge molte analisi critiche del giuridico, ma al diritto non delega gli obiettivi dell’azione politica.
Ora, questa mossa risulta spiazzante per molti versi, ma principalmente rispetto (a) al precedente svolgersi della tradizione giuridica occidentale e (b) all’intero set delle critiche mosse al diritto da posizioni di sinistra radicale.
(a) Nella tradizione giuridica occidentale, il diritto non è sempre stato appannaggio dell’autorità politica. Nell’Europa continentale, in particolare, il diritto[31] è stato per molti secoli – dall’epoca del diritto comune sino alle codificazioni ottocentesche – di produzione largamente extrastatuale,[32] in quanto elaborato, con tecniche diverse in corrispondenze delle diverse fasi storiche, dai giureconsulti, liberi cittadini che non avevano mandato da alcuna autorità politica, ma creavano un diritto universalmente riconosciuto come tale[33] in virtù del prestigio personale di cui godevano, nonché per la legittimazione che conferiva loro la fonte sulla cui base operavano, il Corpus Iuris Civilis giustinianeo. Possiamo per questo parlare di un diritto “prodotto dal basso”? Certamente si tratta di una produzione di diritto diffusa in virtù della sua stessa origine sapienziale, carattere che si perderà una volta che, con i codici ottocenteschi, l’autorità statuale, appropriandosene, trasformerà quel sapere giuridico millenario in una legge dello Stato. Ma è pur sempre un diritto prodotto da élite di giuristi per servire interessi di ceti dominanti.[34] Non dunque un diritto dal basso nel senso che gli si attribuisce oggi.
Una diversa forma di produzione di diritto decentrata, presente ovunque e connaturata allo stesso fenomeno giuridico, è la consuetudine, la regola non scritta spontaneamente osservata da una comunità e consolidata nel tempo. Nei sistemi moderni, la sua forza cogente è tuttavia stabilita dallo Stato, nel quadro di un sistema di fonti del diritto organizzato gerarchicamente che alla consuetudine riserva appunto un ruolo marginale, subordinato alle fonti legali. Il riconoscimento del carattere vincolante della con- suetudine è, in un ordinamento complesso, una concessione del potere sovrano.[35]
Nel diritto contemporaneo, infine, la lex mercatoria rappresenta senz’altro un esempio di regolamentazione giuridica a produzione decentrata, diffusa e extrastatuale. Non servono però parole per argomentare che siamo di fronte a un diritto funzionale alle dinamiche del capitalismo globalizzato e coerente con il deperimento della sovranità statuale proprio di questa fase. Non per nulla la diffusione di fenomeni come quello della lex mercatoria genera allarme in chi in essa vede una zona d’ombra nel sistema delle garanzie assicurate dalle democrazie costituzionali piuttosto che una forma di distribuzione verso il basso del potere democratico.[36]
Insomma, tendenzialmente le soggettività marginali non producono diritto che il sistema giuridico possa riconoscere come tale. È questo schema rovesciabile?
(b) Quest’ultima considerazione ci porta direttamente a confrontarci con le critiche mosse “da sinistra” al diritto come sistema di regolazione sociale, per domandarci se un diritto prodotto dal basso, laddove configurabile, possa sottrarvisi o invece ne resti travolto. Va da sé che il tema è troppo ampio e serio per poter essere liquidato in poche battute. E tuttavia è il tema che attraversa in modo sotterraneo ma per- vasivo quanto sta tentando di farsi con l’esperimento della Costituente dei beni comuni e che non può essere sottaciuto o messo da parte semplicemente appellandosi a una creatività originaria, autolegittimante, di giuristi e movimenti. Soprattutto quando si teorizza lo stesso lawmaking come pratica del comune, cioè come pratica politica.
E allora, una prima risposta può abbozzarsi con riguardo alle critiche all’incoerenza intrinseca delle regole e dei sistemi giuridici. Tutto il fascino dei progetti decostruttivi e il disincanto verso il diritto come strumento di ingegneria sociale non valgono a celare il fatto che il solo ricorso all’internal critique, cioè a un’analisi che decostruisca il portato precettivo delle norme mettendone in luce l’intrinseca ambivalenza, può oggi non essere all’altezza del presente. Fare tesoro di quanto la denuncia dell’indeterminatezza dei dispositivi giuridici ha indicato, mostrando come essi possano prestarsi ai progetti politici più disparati, è necessario. Lo si è fatto ancora da ultimo, a proposito della funzione sociale della proprietà.[37] Ma non (sempre) basta per dare piena legittimazione giuridica alle azioni di riappropriazione del comune. E mettere mano allo statuto giuridico dei beni può allora non essere un progetto naif, sebbene il rischio di cadere in una fiducia illuministica nel legal change[38] ci sia e possa appannare la coscienza critica. Non credo che nessuno si aspetti dalla Costituente dei beni comuni il superamento del diritto borghese, ma la disarticolazione della proprietà è oggi conditio sine qua non della costruzione di una nuova cittadinanza possibile e tanto non può essere realizzato solo con interventi di microchirurgia.
Resta ovviamente aperta la questione, pregiudiziale, della fiducia nelle capacità di trasformazione del diritto e dell’opportunità, dunque, di affidare ad esso – e non piuttosto alla lotta politica – le sorti di un progetto così ambizioso. Il problema, così formulato, sarebbe mal posto, per le ragioni che dirò fra poco, ma intanto bisogna farsi carico di un’altra critica mossa al diritto, quella di matrice foucaultiana, che ne disvela la performatività, cioè l’attitudine a produrre la realtà che regola. In ciò rappresentando un caveat rispetto all’uso del diritto quale strumento di cambiamento e di emancipazione. Il diritto, in quanto pratica discorsiva, utilizza strumenti assai più sottili del comando e dell’obbedienza per governare le forme di vita. All’interno dell’ordine discorsivo che esse stesse stabiliscono, le regole giuridiche costruiscono i soggetti e le relazioni che nominano i quali, in tal modo, diventano artefici di quello stesso ordine, riproducendolo. In teoria, un diritto “dal basso” dovrebbe ribaltare l’ordine del discorso dominante, ma non per questo perderà la sua performatività, cioè l’attitudine a creare le identità, a dirigere e indirizzare le condotte sociali. È però questa stessa prospettiva a indicare che il diritto, quale dispositivo governamentale, se da una parte vincola, dall’altra abilita, e se “abusato” può dar corpo alla trasformazione.[39] Si è parlato di una performatività “buona”, che può cogliersi allorché si affianchi a una lettura del diritto come pratica discorsiva l’analisi dei suoi effetti redistributivi. Il diritto non solo detta le regole del gioco, ma distribuisce la posta fra i giocatori: la decostruzione di una regola, la sua rilettura possono dar luogo a una diversa distribuzione del potere economico fra gli attori sociali; contemporaneamente produrre un’azione empowering sul piano simbolico che muta i rapporti di forza.[40] Si può dunque affidare alla scrittura di nuovo diritto una (più o meno moderata) prospettiva di cambiamento? Un diritto dei beni comuni che riesca scalfire il ruolo egemone della proprietà in senso economico e simbolico sarebbe certamente empowering per il 99%
degli umani.
Ma, più modestamente, quel che ci si può ragionevolmente attendere dall’esperimento della Costituente dei beni comuni, da questa rinnovata “lotta per il diritto”, è dato da quanto si agita intorno alla stesura del testo. È appunto il contesto conflittuale che fa riferimento alla ed è parte della Costituente ad avere soprattutto rilevanza; le connessioni fra movimenti e lotte che attiva ed estende; le ricadute che l’aspirazione a muoversi dentro una legittimità che non sia più soltanto morale ma anche giuridica può avere in termini di produzione di un nuovo senso comune. Che già è visibile nel consenso che le occupazioni di cui parliamo si guadagnano fra la gente dei quartieri che attraversano. La scrittura di un testo normativo diventa allora strumento di soggettivazione politica, che ci si augura possa estendersi anche oltre i gruppi che già vede coinvolti. In questo senso, il ricorso al diritto, quale che sia l’esito dell’attività di drafting e il suo possibile impatto sul sistema vigente, promette trasformazione in quanto «prassi che … gioca l’opportunità di emancipazione sullo stesso terreno – concettuale e pratico – delle tecniche di potere con cui è confrontata»[41] percorrendo la via stretta che separa una rappresentanza politica ormai vuota da «un’irrappresentabilità sempre a rischio di trascolorare in ineffettualità».[42] In sostanza, una mossa che ha anche il senso di una sfida al cinismo che affligge molte analisi critiche del giuridico, ma al diritto non delega gli obiettivi dell’azione politica.
(Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista “Lettera Internazionale”)
Note
1 Mi piace qui riprendere le parole di Carla Lonzi, “Sputiamo su Hegel”, in Sputiamo su Hegel. La donna clitoridea e la donna vaginale e altri scritti, 3° ed., Scritti di Rivolta femminile, 1974, p. 54, perché mi pare che le lotte in corso preludano a una trasformazione profonda tanto quanto quella prodotta dalla rivoluzione femminista.
2 Non a per caso ne parla negli stessi termini riportati nel testo Rodotà nelle prime pagine de “Il diritto di avere diritti” proprio per indicare uno dei luoghi emblematici della rivendicazione, ma, insieme, del più recente fiorire dei diritti a livello globale.
3 Come nel caso di Scup a Roma.
4 È questo il caso del Cinema Palazzo, ancora a Roma.
5 Su questo punto rinvio al mio Beni comuni. Oltre l’opposizione natura/cultura, in Lettera Internazionale, n. 113, 2012, pp. 9 ss.
6 G. Allegri, “Le esperienze giuridiche delle nuove istituzioni comuni nella crisi delle democrazie capitalistiche”, in G. Allegri, M. R. Allegri, A. Guerra, P. Marsocci (curr.), Democrazia e controllo pubblico dalla prima modernità al web, ES, 2012, pp. 89 ss., parla al riguardo di nuove istituzioni comuni quali epifanie di una “democrazia contro lo Stato”.
7 Emblematica al riguardo la vicenda giudiziaria del cinema Palazzo, su cui v. C. Agabitini, Tutela possessoria e beni comuni: il caso del cinema Palazzo, nota a T. Roma, 2.2.2012, in NGCC, 2012, I, pp. 850 ss.
8 Su questo cfr. per tutti S. Rodotà, “Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide”, in M. R. Marella, Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, ombre corte, 2012, pp. 311 ss.
9 Su cui si veda ad es. L. Nivarra, “Non illudiamoci, la Costituzione è dietro le spalle”, in Il manifesto, 10 gennaio 2013.
10 Cfr. ad es. A. Somma, “Democrazia economica e diritto privato. Contributo alla riflessione sui beni comuni”, in Materiali per una storia della cultura giuridica, vol. 31, n.2, pp. 3-36, Giuffrè, 2011.
11 L. Carlassare, Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Feltrinelli, 2012. Sull’attualità del progetto costituzionale quale agenda politica per la realizzazione del bene comune cfr. S. Settis, Azione popolare. Cittadini per il bene comune, Einaudi, 2012. Sulla necessità di “invertire la rotta” riconducendo il riformismo nell’alveo costituzionale, cfr. U. Mattei, Contro riforme, Einaudi, 2013.
12 G. Azzariti, “Una convenzione per la democrazia”, in Il manifesto, 10 maggio 2013.
13 S. Mezzadra, Costituzione, movimenti e proces- si costituenti. Appunti in vista del seminario di Roma, in www.uninomade.org.
14 Per una presa di posizione a questo riguardo si consenta il rinvio a M.R. Marella, “Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà e le spinte antiproprietarie dell’oggi”, in G. Alpa e V. Roppo (curr.), La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, Laterza, 2013, pp. 105 ss.
15 E ancor prima, forse, alla critica della stessa dicotomia pubblico/privato intorno a cui la carta costituzionale costruisce l’equilibrio fra Stato interventore e iniziativa economica privata.
16 A. Negri, La civetta costituente, online al link www.uninomade.org/la-civetta-costituente/ (consul- tato l’ultima volta il 1 giugno 2013).
17 Per un quadro aggiornato cfr. BIN-Italia, Reddito minimo garantito. Un progetto necessario e possibile, Edizioni Gruppo Abele, 2012.
18 G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l’Italia e per l’Europa, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2011, p. 41.
19 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012, in part. il capitolo “Il diritto all’esistenza”, pp. 232 ss.
20 Cfr. M. Bussani, “La globalità asservita e il dirottamento dello Stato”, in S. Chignola (cur.), Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti, ombre corte, 2012, p. 222.
21 G. Bronzini, Il reddito di cittadinanza., cit., p. 54.
22 Un’utile sintesi può trovarsi in L. Coccoli, “Filosofia e reddito di base. Tentativi di giustificazione”,
in Progetto lavoro, n. 14, 2012.
23 In tal senso, cfr. A. Fumagalli, “Per una nuova
interpretazione”, in Bin-Italia (cur.), Reddito per tutti, cit. La posizione post-operaista sul tema è illustrata in M. Hardt e A. Negri, Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Rizzoli, 2001, p. 372.
24 S. Rodotà, opp. locc. citt.
25 Decisione del 9 febbraio 2010. Può leggersi in www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/l s20100209_1bvl000109.html, visitato il 23 gennaio 2013.
26 R. Kunz, “La dittatura del tempo astratto. Il lavoro come disturbo comportamentale della modernità”, in Gruppo Krisis, Manifesto contro il lavoro, DeriveApprodi, 2003, p. 65.
27 R. Kunz, N. Trenkle, “Il superamento del lavoro. Uno sguardo alternativo oltre il capitalismo”, in Manifesto contro il lavoro, cit., p. 101.
28 G. Allegri, L’insubordinazione al lavoro del Quinto Stato. Enunciati collettivi e invenzione istituzionale, marzo 2013, on file with author.
29 G. Allegri, opp. locc. citt.
30 R. Kunz, N. Trenkle, opp. locc. citt.
31 Mi riferisco soprattutto al diritto privato, tanto
perché storicamente fornisce le categorie ‘scientifiche’ sulla base delle quali vengono elaborate le strutture concettuali proprie delle altre branche del diritto, sia perché è il settore giuridico più da vicino riguar- dato dal nostro discorso, che, come sappiamo, si dipana dal tema dei beni e delle forme di appartenenza e godimento.
32 Cfr. F. Vassalli, La extrastatualità del diritto civile, in Studi in onore di A. Cicu, II, Varese, 1951, 481 ss.; G. Tarello, voce Codificazione, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, II, pp. 465 ss., Utet, 1988.
33 R. Sacco e A. Gambaro, Sistemi giuridici com- parati, Utet, Torino, 2002, pp. 250 ss.
34 Si vedano ad es. le notazioni di uno storico del diritto in merito all’istituto della rescissione, general- mente presentato come un veicolo di giustizia sociale nel diritto del mercato: «L’intricata vicenda della rescissione, guardata nel concreto dei suoi protagonisti, non è certo una storia di umili ma di potenti, non di individui spinti dal non essere titolari di beni produttivi a domandare in compera mezzi di sussistenza, costino quel che costino; non d’individui portati dal bisogno, per fornirsi di qualche cosa col quale tirare innanzi la vita, a rivolgersi a uno ch’è pronto a dare poche monete a strozzo, avendo potuto accumulare più di quanto sia capace di consumare, in grado perciò stesso di accelerare l’accumulazione… I protagonisti di questa storia sono, da un lato, gente che ha comunque qualcosa da vendere e, dall’altro, gente che può permettersi di far compere; da un parte e dell’altra c’è sempre gente che ha sempre qualcosa da perdere… Una storia consumata in ambienti nei quali ciascuno è persuaso che sia lecito naturaliter se circumvenire. Non una storia di povera gente dunque, ma di ricchi naturaliter disposti a sbranarsi l’un l’al- tro. Simultaneamente interessati però a che non si producano sensibili mutamenti nei patrimoni comparati fra loro» S. Caprioli, “Iniquitas rei. Studi preparatori sui contratti rescindibili”, in Annali Perugia, 1974. II, p. 95 e ss.
35 E. Conte, “Possedere l’uso. Profili oggettivi e soggettivi della consuetudine nel diritto comune”, in S. Zorzetto (cur.) La consuetudine giuridica. Teoria, storia, ambiti disciplinari, Pisa, 2008, 41-61; Id., “Roman Law vs. Custom in a Changing Society: Italy in Twelfth and Thirteenth Centuries, in Custom. The Development and Use of a Legal Concept in the High Middle Ages”, ed. P. Andersen e Mia Münster-Swen-dsen (Congresso Aarhus, Danimarca, 2008), Copenhagen, 2009, 33-49. Classico sul tema R. Koestler, “Consuetudo legitime praescripta. Ein Beitrag zur Lehre vom Gewohnheitsrecht und vom Privileg”, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung, XXXIX, Weimar, 1918.
36 Rodotà, opp. locc. citt., in particolare “Parte prima. Narrare i diritti”.
37 Per una ricostruzione genealogica del principio rinvio ancora al mio Il principio costituzionale della funzione sociale della proprietà e le spinte antipro- prietarie dell’oggi, cit., pp. 112 ss. Analizza il mutato significato della nozione nel contesto europeo L. Nivarra, La proprietà europea fra controriforma e “rivoluzione passiva”, in C. Salvi (cur.), Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani, Giappi- chelli, 2012.
38 Con buona pace di E. Vitale, Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Laterza, Roma-Bari, 2013, le dinamiche interne al diritto sono assai più complesse di quanto i progetti funzionalisti possano far credere. Cfr. fra i molti W. Brown e J. Halley (eds.), Left Legalism/Left Critique, Duke University Press, 2003.
39 M. Spanò, Azioni collettive. Soggettivazione, governamentalità, neoliberismo, ES, 2013.
40 D. Kennedy, “The Stakes of Law, or Hale and Foucault!”, in Sexy dressing etc., Harvard University Press, 1993, pp. 83-125.
41 Così M. Spanò, cit., p. 164.
42 Ivi, p. 8. L’autore individua nella class action quel dispositivo giuridico che producendo soggettivazione politica può dar vita a un’ipotesi di “politica dei governati”. Il senso non mi pare troppo distante da quanto si suggerisce nel testo, sebbene agire in giudizio in modo collettivo implichi forse un grado di mobilitazione politica diversa dallo scrivere collettivamente un testo di legge. Diversamente attribuisce alla class action le potenzialità di uno strumento di difesa collettiva della costituzione nel quadro di un progetto di cittadinanza attiva che si iscrive in quello che si è definito qui il costituito S. Settis, Azione popolare, cit., pp. 199 ss. Una dinamica di soggettivazione attraverso (o contro) il diritto è prefigurata anche da chi vede nella scelta del rito ordinario anziché abbreviato la via per sviluppare un’operazione politica rispetto ai processi contro gli attivisti che partecipano alle lotte studentesche o territoriali (es. no-tav).
Maria Rosaria Marella, ordinario di Diritto privato all’Università di Perugia, dove insegna Diritto civile e Diritto delle biotecnologie. Si occupa di teoria critica del diritto e di teoria femminista. Nei suoi scritti ha dedicato particolare attenzione alla famiglia, alla giuridificazione del corpo, alla disciplina delle relazione sessuali e ai diritti della persona. Fra le sue ultime pubblicazioni: Critical Family Law, in American University Journal of Gender, Social Policy and the Law, vol. 19, 2, (2011), “Sesso, mercato e autonomia private”, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, (2011). Per L.I. ha scritto: “Beni comuni. Oltre l’opposizione natura/cultura”, n. 113, 2012