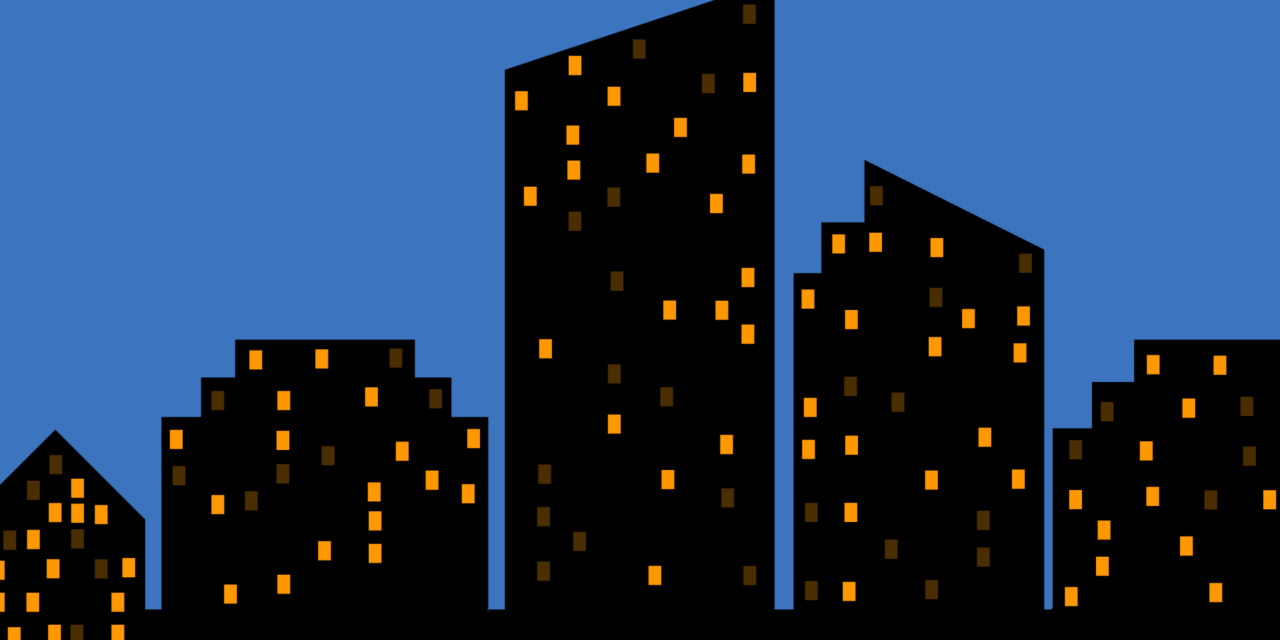Intervista di LUCA BERTOCCI a MARCO ASSENNATO
Pubblichiamo una conversazione pubblicata per Into The Black Box a cura di Luca Bertocci svoltasi a Parigi con Marco Assennato – militante e professore associato all’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Si è incentrata sul problema della metropoli nel cambiamento climatico e – in questo contesto – sull’intreccio tra progetto politico-urbanistico, soggettività politica per la trasformazione dello stato di cose presente e tecniche operative. Interroga l’ecologia politica, l’architettura e le militanze. La prima parte, che si legge di seguito, fa focus sul rapporto tra enigma della moltitudine, il grande spazio urbano planetario ed il problema di pensare affermativamente, immaginando la critica nel suo doppio aspetto di denuncia e progetto. Emergono le idee guida di Architetto Sociale e Progetto della Moltitudine. La seconda parte, invece, cerca di legare la prima ad un necessario rapporto con le discipline della costruzione che, se già era apparso, è qui più intensamente guadagnato al pensiero politico. Si sviluppano in generale molteplici tracce – seppur parziali – di riflessione e ricerca da discutere ed approfondire nell’ottica di uscire dalla coltre che ci sembra coprire il dibattito accademico e non.
L. La prima questione è quella di cui abbiamo parlato anche ieri, ovvero se è possibile – secondo te ed alla luce dei tuoi studi e della tua esperienza politica ed intellettuale – tentare di affrontare i nodi, l’intreccio tra problema della metropoli, enigma della moltitudine e climate change fuori da un doppio pantano. Ovvero senza cadere in visioni catastrofiste oppure ideologiche, cioè che antepongono posizioni moralistiche o utopiche all’analisi materialistica dello stato di cose. Penso soprattutto alla questione della Natura che ultimamente addensa attorno a sé il dibattito. Quel pantano credo ci renda problematica una discussione seria intorno alla potenza produttiva, alla potenza creativa, trasformatrice di mondo, di spazio e ambiente che invece si esprime nella volontà di esodo della moltitudine, nella volontà liberogena verso una vera socializzazione della società.
M. Direi così: il fatto di tenere insieme questi tre termini che tu proponi – moltitudine come elemento soggettivo, metropoli come infrastruttura e climate change – dovrebbe essere per gli approcci critici una necessità, addirittura un’urgenza. Il problema è che il dibattito ecologico che si va configurando, tanto sui livelli più accademici quanto nelle sfere di movimento, non sa pensare la dimensione metropolitana, la sua eccedenza, se non in termini di rifiuto. E di conseguenza non riesce a coglierne né le potenzialità, né, in realtà mi sembra, la centralità critica rispetto al tema del climate change. Penso sia un elemento di buon senso affermare che non esiste nessuna possibilità di affrontare un discorso serio sulla crisi climatica e sui problemi ambientali oggi a livello globale se non si è capaci di interrogare questi enormi spazi urbanizzati che sono le grandi metropoli contemporanee. Sto parlando di luoghi che non sono necessariamente – o non sono più – in Europa e che rappresentano oltre che territori fondamentali della produzione contemporanea anche delle enormi macchine di consumo, di produzione (e spreco) di energia e di inquinamento su scala globale. Quindi ripensare la questione ecologica contemporanea anche a partire da queste dimensioni materiali mi sembrerebbe una necessità. Semplicemente è uno scoglio, un tema teorico con cui non si può non confrontarci se vogliamo dare risposte o tentare analisi realiste della situazione in cui ci troviamo. Mi sembra che però gli approcci dominanti all’ecologia politica non riescano a pensare questo spazio se non in chiave catastrofista, o facendo riferimento ad un altrove, ad un altro spazio di vita, più “naturale”, più organicamente connesso alla ontologia dell’umano e del non umano. Un mitico “luogo” che tuttavia, devo confessare, personalmente stento a pensare. Insomma non capisco bene a cosa ci si riferisca quando si indica in maniera un po’ naive questa dimensione naturale perduta di cui la metropoli sarebbe lo specchio rovesciato. Proprio in questi giorni stavo rileggendo alcune vecchie cose di Felix Guattari, scritte all’epoca della sua ricerca ecosofica. Ecco mi pare che lì ci sia una buona traccia di lavoro: perché Guattari dice esplicitamente che non si può pensare la connessione tra umanità e biosfera – ovvero porsi seriamente il problema ecologico – senza connettere queste due dimensioni a ciò che lui chiama meccanosfera e che fa coincidere con i molteplici agencements urbani della metropoli contemporanea. Qui ecologia ambientale, economia, ecologia sociale ed ecologia scientifica incontrano l’ecologia urbana. Questo insieme concettuale, Guattari, lo chiamava ecosofia. Penso fosse un tentativo – terribilmente intelligente – di dire che se si può pensare una linea di fuga, si deve pensare dentro alla connessione tanto degli aspetti produttivi che problematici e catastrofici del climate change, e per farlo bisogna ridare centralità ai territori metropolitani. Altrimenti i processi concreti materiali che impattano la vita del pianeta ci passino sulla testa (o sotto i piedi) senza che ce ne accorgiamo.
L: La questione soggettiva della moltitudine per come abbiamo imparato a riconoscerla sappiamo che implica come spazio quello metropolitano. Se la mettiamo al centro, stiamo dicendo sostanzialmente che implichiamo l’infrastruttura materiale che supporta questo esodo e questo movimento di fuga, contro, via-dà. Movimento che però a sua volta non indica, non presuppone spazialmente un luogo geo-localizzato in cui si dovrebbe giungere, un fuori da raggiungere secondo tragitto. Questa questione però va presa sul serio, soprattutto negli studi urbani. Cosa intendo: penso a Koolhaas, che nella sua analisi – disincantata e tafurianamente liberata dalla nostalgia – di questi spazi di cui andiamo discutendo è riuscito a guadagnarli al massimo dell’analisi. Noi dovremmo allora riuscire a fare di questo disincanto metodologico qualcosa di più di un rifiuto ideologico, o di un disprezzo. Bisognerebbe piuttosto guadagnare la Bigness alla critica, all’immaginazione politica antagonista. Con questa immagine dell’architetto collettivo, dell’architetto sociale vorrei indicare la capacità produttiva di spazio della moltitudine, che agisce e fa metropoli planetaria. La prima implicazione di questa postura è la responsabilità per così dire che le discipline costruttive – l’architettura, l’ingegneria etc – acquisiscono. Per procedere nella direzione che sto tracciando mi sembra cioè indispensabile comprendere il ruolo dirimente di quelle tecniche, che diventano la sede per pensare una parte importante della politica. Cosa ne pensi di questa impostazione? Come collochi le discipline costruttive nel problema che stiamo cercando di approcciare, nell’intreccio di metropoli, moltitudine e climate change?
M: Tu dici, “dall’operaio sociale all’architetto collettivo” come maniera per guadagnare la Bigness alla critica, cioè rovesciare il cinismo di Koolhaas in capacità critica rispetto ai temi di cui stiamo parlando. Mi pare sia una traiettoria interessante. Ma credo anche che questa espressione contenga livelli diversi del problema. Voglio dire: ci sono qui tre questioni. La prima riguarda le trasformazioni dell’architettura come lavoro (o forse si dovrebbe dire più precisamente: dell’architettura come lavoro “astratto”, cioè preso nella macchina della valorizzazione capitalistica). Il che vuol dire interrogare la radicale mutazione della funzione, dei ruoli, della figura stessa dell’architetto dentro alle dinamiche del lavoro contemporaneo ed in particolare di fronte ai problemi che pone la grande dimensione urbana globale. Tutto ciò non può che condurre al riconoscimento della natura già largamente socializzata e cooperativa del lavoro di progetto per come si da oggi concretamente, mediato come è da programmi informatici sempre più complessi, da tutto un sapere immateriale prodotto collettivamente e che in qualche modo ha largamente superato, surdeterminato la figura stereotipa dell’architetto come artista. Quell’individuo isolato con gli occhiali di corno rotondi e il papillon che disegna la forma dell’ambiente in cui viviamo, e attraverso il suo disegno determina le forme di vita, di socialità, l’organizzazione dello spazio pubblico e privato attribuendogli peraltro un valore di tipo plastico, estetico, formale. Questa figura (largamente mitologica, a dire il vero) è andata in frantumi nella seconda metà del XX secolo, anche se sopravvive come un fantasma nelle frustrazioni e speranze dell’architetto come tecnico, professionista liberale o imprenditore di sé stesso. Ad ogni modo è certo che oggi l’architettura è uno dei settori del lavoro cognitivo, e si fa concretamente attraverso una divisione del lavoro che articola ruoli variabili e stratificati che andrebbero analizzati seriamente. Tuttavia questa natura sociale del lavoro architettonico, cioè di una parte delle tecniche che permettono di configurare lo spazio metropolitano, è in realtà negata dall’immagine dell’architetto come autore, creativo, designer, imprenditore di sé. Immagine che risponde banalmente alle necessità del marketing utile a far stare sul mercato le agenzie di architettura. Dunque, primo livello: riconoscimento e analisi del lavoro degli architetti come lavoro socializzato, cooperativo che incrocia saperi diversi che vanno al di qua e al di là dell’architettura. Questo primo strato sta, secondo me, nella formula “farsi architetto collettivo”.
Secondo punto: questa questione del farsi architetto della moltitudine, mi sembra esprima anche una necessità politica che va molto al di là della questione architettura. Perché in fondo, gli architetti fanno progetti. Quindi mi pare che tu provi a porre il tema, il problema, la domanda: qual è il progetto della moltitudine? Sono capaci i movimenti moltitudinari contemporanei di articolare qualcosa che sta nell’ordine della proiezione e tuttavia indichi un percorso verificabile e discutibile, realisticamente analizzabile? Sono capaci questi movimenti di prefigurare qualcosa che potremmo chiamare un progetto di piano del comune (da contrapporsi alla crisi del piano capitalista o ai piani di ristrutturazione neoliberale dei nostri territori)? Questa domanda è una domanda politica che a me sembra fondamentale, perché anche lì si tratta di uscire da ogni postura semplicemente – per quanto giustamente – negativa e riprendere un complesso complicato lavoro affermativo che è l’unico che esiste in realtà nella prassi politica. La prassi politica non si dà solo come puro negativo, e qualsiasi movimento negativo esiste in realtà solo in quanto è capace di saltare oltre la critica del suo antagonista. Architetto collettivo dunque come metafora di un problema: qual è il progetto della moltitudine? Cosa potrebbe voler dire pensare un piano del comune nel mondo globalizzato di oggi, che è il mondo attraversato da crisi spaventose di ordine sociale, finanziario, ecologico ed anche militare, politico, istituzionale?
Terzo elemento: giocando con un andirivieni tra architettura, politica e spazio metropolitano questa espressione dell’architetto sociale o collettivo allude a un fatto che negli scritti di Koolhaas – seppur rovesciato – è individuato abbastanza con precisione. Cioè il fatto che ragionare sullo spazio metropolitano ci mette di fronte al tema di una realtà che ha la caratteristica di essere ingovernabile secondo un metodo gerarchicamente ordinato, verticale, verticistico e statuale cui la nostra tradizione politica è abituata. Cioè quella che Koolhaas chiama Bigness – l’eccedenza metropolitana – è certamente tutto il comune negativo con il quale cinicamente gioca nella sua attività di intellettuale e architetto, ma è anche il riconoscimento che il grande spazio metropolitano è in qualche modo già da sempre costruito collettivamente, socialmente e irriducibile a qualche unità verticale. È già da sempre spazio comune enigmatico per ogni forma di disciplinamento e controllo che voglia darsi in maniera repressiva, rigida. Lo spazio metropolitano è dove le cose accadano, dove le differenze si danno, dove si riapre costantemente la dinamica storico-politica, quindi andrebbe interrogato come tale, cercando di volta in volta di definire nel modo più realistico e critico possibile la complessità degli attori, dei soggetti, delle dinamiche che ne determinano la dinamica produttiva. Di nuovo, Guattari, con molto anticipo chiedeva agli ecologisti: siete sicuri che la metropoli sia solo e semplicemente “sinonimo – lo cito – di serializzazione e omogeneizzazione delle singolarità”? Come evitare il rischio di scivolare in pulsioni di ri-territorializzazione che, diceva Guattari, “non trovano che un’espressione patologica nel ritorno ai nazionalismi, ai tribalismi, agli integralismi religiosi”? Non è forse una urgenza – ed una urgenza ecologica almeno dal punto di vista sociale – ripensare la metropoli globale come spazio che produce “nuove terre transculturali, transnazionali, trasversali e dei valori liberi dalla fascinazione del potere territorializzato”? A quest’altezza si pone, mi pare, il tema della metropoli come spazio comune della moltitudine.
L: Grazie per aver tirato fuori questa idea del progetto della moltitudine, che effettivamente è uno dei fuochi che illuminano la nostra chiacchierata e in generale la ricerca mia e di altri compagni e compagne, ricerca politica ed accademica, nell’intreccio delle due. Proverei ora a concentrarmi proprio su questa questione del Progetto: cosa vuol dire pensare il progetto? Lo dicevamo anche in altra sede, c’è un po’ questo non detto nell’aria: Progetto incarna, tiene dentro in maniera non problematizzata esplicitamente la dimensione politica e quella urbanistica. La formula classica “i soviet + l’elettricità” esplicita questa doppia natura urbanistica e politica del Progetto in un intreccio che non è separabile, non è risolvibile, le due cose si danno insieme. Vorrei concentrarmi su questo perché credo che se assumiamo la dimensione del General Intellect e la metamorfosi planetaria della città cioè questa idea per cui la condizione metropolitana è planetaria, impregna, è l’ontologia sociale – come scrivi in Progetto e Metropoli – per cui è la natura naturante che pre-sta, che è pre-potente rispetto a ciò che si osserva spazialmente qua fuori e su questo tavolo, allora quell’intreccio è esplicito, è demistificato. General Intellect, urbanizzazione planetaria e Bigness comportano insomma secondo me riporre al centro, svelare in un certo senso, una verità: ovvero dicono, impongono, espongono il segno radicalmente urbano che è scomparso dall’idea di progetto politico, l’elettricità che supporta il soviet, l’infrastruttura materiale che presuppone, che meglio co-produce la possibilità di pensare il Progetto, in tutte le sue accezioni. Anche “di vita” – su questo in sede marxista c’è una letteratura che andrebbe urbanamente esplorata e tagliata per lavorare sul rapporto tra tempo e Progetto. Del resto il pensiero del futuro è sempre un pensiero urbano, urbanistico del futuro, che piaccia o meno. Mi sembra che non si possa insomma non dire che è tempo di prendere per le corna il Progetto, riguadagnandolo alle infrastrutture materiali attraverso cui si pensa. Quindi di nuovo, torniamo alle tecniche costruttive, al supporto che ingegneria, architettura etc non possono che portare in questo processo. Ti chiedo di elaborare adesso su questo nodo più esplicitamente. Non sono forse quelle discipline il dove chi si pone il problema del progetto della moltitudine – ed in generale della trasformazione dello stato di cose presenti – non può che andare a cercare per mettere fuori la testa dalla coltre dell’ideologia e della catastrofe? Cercherei quindi di lavorare su questa idea del progetto nel suo etimo latino, che implica la visione, per arrivare dopo a quella tedesca, che implica la separazione da uno stato di cose.
M: Il progetto – nell’etimo latino, come in un celebre articolo Massimo Cacciari aveva fatto notare negli anni 80 – implica una proiezione in avanti, una visione del futuro. Però a differenza di approcci semplicemente utopistici, il progetto non si può mai limitare – né quello architettonico né quello politico – ad indicare un orizzonte di senso che ipostaticamente fa da attrattore di un percorso. Ma deve – in questo è diverso dall’utopia – anche indicare, esplicitare il percorso che permette di raggiungere questo obiettivo. Percorso vuol dire: i conflitti attraverso cui deve passare, le contraddizioni da risolvere, le maniere specifiche con cui farlo. Progetto architettonico vuol dire essere capaci di interpretare, analizzare maniere, forme, misure specifiche della trasformazione che vogliamo far subire ad un ambiente determinato. Questo è fondamentale per entrare in tensione con una certa retorica ecologista, oggi dominante tanto nella discussione architettonica, quanto in quella politica: pensare un progetto significa pensare la trasformazione delle cose. Il progetto non è semplicemente conservativo, e anche quando si dà giustamente come obiettivo la conservazione di un ambiente, di un patrimonio, la loro durata, lo fa modificando coscientemente una situazione preesistente – ciò “da cui parte”, qui è l’etimo tedesco, nel senso di provenienza che può essere attivato. Conservare in termini progettuali significa trasformare per preservare, trasformare per far durare quanto più possibile il valore, le qualità di un ambiente costruito o naturale. Questo tipo di ragionamento mi pare fondamentale per la riflessione critica, tanto negli studi urbani e architettonici, quanto per questioni politiche. È inutile negarlo: viviamo un passaggio in cui si fa fatica a porsi in questa ottica, a pensare la trasformazione delle cose ed il futuro. Il futuro è una specie di grande interdetto nel passaggio che stiamo vivendo, non semplicemente in termini utopici. Zygmunt Bauman, nel suo ultimo libro, giustamente intitolato Retrotopia sosteneva questa tesi: viviamo un momento storico nel quale il pensiero del futuro ci è precluso. Quindi le utopie sono fuorigioco e al massimo riusciamo a lavorare con quelle che lui chiama retrotopie, utopie regressive: il ritorno nel ventre della grande madre terra, il ritorno nei territori, il ritorno delle identità. E lo scriveva con grande angoscia e tentando una prima coraggiosissima critica che riguarda tanto derive conservatrici reazionarie, quanto buona parte di posture teorico-politiche che si vorrebbero critiche. Guarda, dobbiamo esser sinceri: non è possibile non vedere il fondo animista e vitalista, reattivo insomma, dell’ipotesi Gaia! E del resto, penso che nessuno di coloro che l’hanno sostenuta lo negherebbe: né Lovelock e Margulis, e neppure Latour, che pure è assai più ambiguo. Il contrario della retrotopia non è secondo me soltanto la capacità di riattivare, di aver il coraggio di immaginare nuove utopie – su questo ci ha richiamati in Francia un filosofo molto elegante come Macherey, o in ambito statunitense Jameson, che rilancia il tema dell’utopia come pensiero del futuro e capacità critica, di rifiuto dello stato di cose presente. Questo è estremamente importante, secondo me, anche perché trovo la prospettiva catastrofica, come tutta la pappa retorica sull’antropocene, terribilmente occidentalo-centrica. Abbiamo bisogno invece di utopia e di decolonizzare i nostri modi di pensare, ma questo significa, come ha scritto Achille Mbembe nel suo bellissimo La communauté terrestre pensare insieme la catena simbolica che lega l’umano e il non umano, l’animale, il vegetale e i dispositivi tecnologici e artificiali che fanno parte della catena del vivente. Vita e macchina si intrecciano indissolubilmente, natura e metropoli – o metropoli come natura naturante. Non esiste la nuda vita, insomma. Ora però questo è giusto ma non basta. Secondo me, dicevo, oltre all’utopia ci serve anche progetto, ci serve non solo orizzonte ma anche la strategia che permette la trasformazione concreta dello stato di cose presente. A me sembra che questa Stimmung attraversi sempre la domanda e la ricerca che si fa o dovrebbe fare sulla dimensione urbana. Non esiste nessun’altro approccio che valga la pena di essere ragionato, se non quello che è capace di tenere insieme queste caratteristiche.