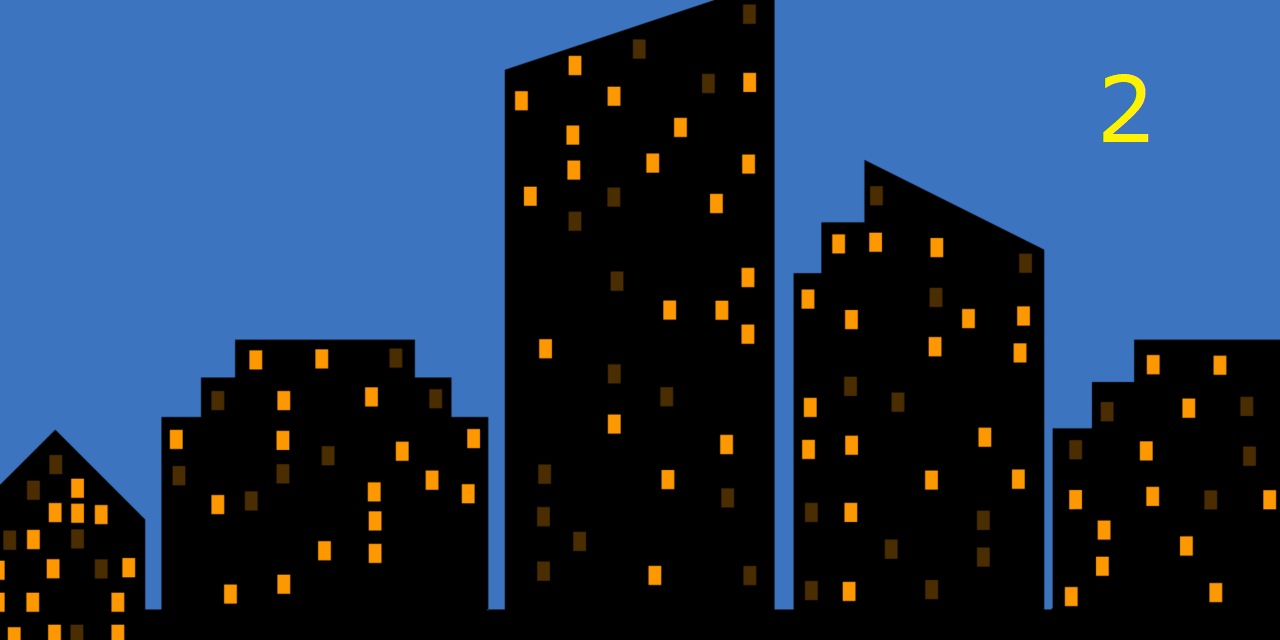Intervista di LUCA BERTOCCI a MARCO ASSENNATO
Pubblichiamo la seconda parte (la prima può essere letta qui) della conversazione pubblicata per Into The Black Box a cura di Luca Bertocci svoltasi a Parigi con Marco Assennato– militante e professore associato all’Ecole nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais. Si prova a guadagnare ora più intensamente al progetto politico la questione dell’infrastruttura materiale che lo possa supportare e co-produrre. Ritornano le idee guida di Progetto della Moltitudine e Architetto Sociale – dentro e fuor di metafora – per caratterizzare una postura operativa da dentro e contro: ovvero pensandosi infrastruttura. Molte domande vengono aperte e andranno raccolte, ad esempio: quali tecnologie, oggi, possono sostituire “l’elettricità” del vecchio adagio, con che epistemologie dello spazio-tempo socio-naturalmente prodotto si possono immaginare strategie di trasformazione ambientale che a loro volta supportino la liberazione del comune planetario – nel suo intreccio di eccedenze umane e non umane?
L: Visto che la conversazione sta andando in questa direzione, vorrei parlare adesso di una cosa che pensavo di guardare alla fine, ma l’hai già richiamata. La porrei come una provocazione produttiva (che peraltro è l’unico modo per fare pensiero e non cantare con stupore la filastrocca della tautologia): se rimuoviamo, se ci rifiutiamo di osservare le cose secondo la traccia che sta emergendo, secondo me – non so tu cosa ne pensi – c’è un po’ il pericolo che quell’elemento soggettivo, moltitudinario, si esprima comunque ma senza che siamo in grado di vederlo, interpretarlo, di coglierlo, di esserne in qualche modo – al più o al meno – espressione politica, avanguardia politica che esplicita, domanda e cerca di lavorare esplicitamente a quel progetto comune, a quel progetto del comune. Questo è il pericolo: se non rimettiamo al centro questa materialità di cui stiamo parlando si rischia di non cogliere il movimento reale che abolisce, che sta abolendo, che vuole abolire, che lavora ad abolire – benché senza un progetto esplicito – lo stato di cose, cioè la cattura capitalistica del comune. Ci sfugge questo, il movimento reale che si incarna, si dà ed in parte produce ciò che vediamo, lo spaziotempo complessivo in cui viviamo. Mi spiego meglio: sono stato in Olanda per ricerca – un posto diciamo fuori dal coro per chi volesse occuparsi di ecologia politica o critica: per ragioni ovvie, è un paese molto ricco, non ho notizia di molte lotte sociali là. Eppure, il lavoro di tanti atelier di architettura e urbanistica che ho incontrato, in qualche misura mi ha dato segno di un approccio che mi è sembrato potesse fortificare il ragionamento che stiamo abbozzando e che ci potesse permettere di mettere fuori la testa dalla coltre. Negli anni siamo passati attraversoparole prezzemolo come gentrificazione con cui è stato tentato di coprire un problema che eccedeva questa etichetta. Così turistificazione, che oscurava il diritto umano a valicare a prezzi accessibili le colonne d’Ercole, fenomeno che ha permesso alla mia generazione di riprodursi, che tante volte abbiamo giudicato senza osservarci nell’atto invece di desiderarla, di essere i primi produttori e produttrici di questa volontà di metropoli planetaria. Adesso crisi ecologica, catastrofe. A me sembra che spesso si confonda il (legittimo) disprezzo con la critica, che del comune quando appare – in fondo – si abbia paura. Ma così corriamo il rischio di lasciare che altrove questi problemi vengano affrontati e catturati. Credo che ad esempio – e moltissimi altri se ne potrebbero e dovrebbero fare – negli atelier, nelle sedi dove si discute di progettazione di lungo periodo per stare con il problema del cambiamento climatico, credo che lì dentro già pulsi, già insieme si produca e venga in parte catturato quel progetto del comune umano e non umano cui andavamo accennando. Insomma, ho avuto la sensazione che potesse essere interessante andare a vedere lì come la sfida viene raccolta, come lì questo progetto non esplicito cominci ad apparire per poi – in secondo luogo – da lì riportarlo a noi, da lì riguadagnarlo alla prassi politica. Ti chiederei adesso di elaborare su questo nodo, di stare dentro questa idea di progetto della moltitudine, di architetto sociale dentro e fuor di metafora.
M: Guarda, devo dir la verità: il rischio che noi non vediamo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente, non mi pare un gran rischio… nel senso che l’importante è che questo movimento si dia, indipendentemente dal fatto che ricercatori universitari o militanti se ne accorgano! E se si da, si darà da sé un progetto, una direzione, delle strategie, delle forme di organizzazione. Ovviamente è una battuta, ma mi serve a spostare il ragionamento. Insomma io credo che il problema non sia tanto il vedere o non vedere i movimenti e le lotte globali contemporanee ma, politicamente: come possiamo noi – ricercatori-trici, militanti, attivisti/e, – contribuire da una parte ad evitare che i movimenti restino presi nel pantano di prospettive regressive e d’altra parte, per dirla ancora con Guattari, a rizomatizzare, a spiazzare, a de-territorializzare tutte le forme patologiche e reattive del rifiuto dello stato di cose presente. Questa è la partita, secondo me.
Ora da questo punto di vista le parole che tu evochi, gentrificazione, turistificazione, etc, come anche antropocene… sono state fin qui un po’ le parole chiave degli studi urbani critici. E tuttavia hanno secondo me il difetto di funzionare come dei mots-valises, delle parole che indicando tutto, non indicano niente di specifico. O meglio: indicano orizzonti problematici. Per esempio gli studi sulla gentrificazione possono essere considerati una prima approssimazione alla necessità di costruire una analisi tecnicamente solida e politicamente intelligente delle dinamiche della rendita immobiliare, tra forme di vita e produzione di valore. Gli studi sulla cosiddetta turistificazione possono essere un preliminare modo di denunciare l’effetto distruttivo che una gestione mercantile e ciecamente, avidamente quantitativa della democratizzazione dei viaggi di piacere, può produrre, rispetto alla giusta tutela di un certo patrimonio comune storicamente accumulato, penso alle città d’arte etc. Così come nelle intenzioni dei teorici dell’antropocene (o del capitalocene), ci sta senza dubbio l’indicazione di contraddizioni e limiti dei modelli di sviluppo del nostro sistema economico, insomma l’esigenza legittima di ripensarli. Non c’è dubbio che dobbiamo reinventare un modo di produrre, far circolare la ricchezza e riprodurre la società. Tuttavia quelle categorie indicano dei problemi, ma una volta che li hanno indicati a me sembra – come tu stesso hai detto – che funzionino tautologicamente. Non ci aiutano ad affrontare il problema, non si va molto oltre la conferma di una dinamica catastrofica tipica dello sfruttamento capitalistico dei luoghi, degli spazi e delle risorse. Il punto è come fare un passo oltre, come passare dalla generica denuncia delle dinamiche di gentrificazione ad una rivendicazione di mobilità sociale e fisica nei quartieri e tra gli spazi urbani. Il tema è quello dell’appropriazione e valorizzazione comune, della rivendicazione del diritto ad una qualità degli spazi urbani che sia all’altezza della vita che vogliamo vivere. Lo stesso riguarda il turismo: più che quella specie di aristocratico disprezzo che viene vomitato di fronte alla democratizzazione degli spostamenti su scala globale, si dovrebbe forse ricominciare – alcuni giovani ricercatori lo fanno, in Italia ad esempio il libro di Salerno Per una critica dell’economia turistica – a fare appunto una critica dell’economia turistica, cioè a dire che il turismo è un settore dell’economia, che comporta forme del lavoro, gerarchie, probabilmente organizzazione e conflitto. E ancora generalmente dentro alla critica ecologica il rischio è di sostituire al vecchio mito della classe operaia portatrice di per sé di un avvenire radioso e universalmente buono, quello della difesa dell’ambiente e della biosfera come valore in sé portatore spontaneamente di un equilibrato rapporto tra uomo e ambiente (che può, tra l’altro, assai facilmente prendere un carattere totalitario e reazionario). Una volta che i problemi sono stati indicati, bisogna insomma iniziare a spacchettare queste parole che altrimenti ci impediscono di leggere realisticamente i processi, sia nella loro drammatica criticità che anche nella loro apertura ad altre forme di vita e di produzione, di organizzazione sociale.
In qualche modo tutto questo discorso che stiamo facendo attorno a progetto, politica, metropoli e moltitudine – mi sembra sia questo il senso di quello che dici quando fai riferimento agli atelier di urbanistica e architettura in Olanda – ci indica come necessità quella di dotare di pensiero politico le tecniche di gestione e trasformazione dell’ambiente e dei territori urbanizzati, di privarle della loro pretesa neutralità e dall’altra parte di attrezzare il pensiero politico di capacità tecnica. Questo è il punto. Se invece il pensiero critico rimane chiuso nella logica della denuncia, del rifiuto, della fuga, della retrotopia e la tecnica operativa resta cristallizzata in una specie di impermeabilità alla politica, secondo me non riusciamo né a individuare soluzioni tecniche realistiche concrete (progetti!), di cui il nostro tempo ha disperatamente bisogno, né a far avanzare di un millimetro la critica dello stato di cose presenti. Questo doppio vincolo nel quale siamo, questa coltre che ci copre non funziona né sul piano della pratica, del fare, né su quello della critica. Questo è il tema: dotare le tecniche di pensiero politico e attrezzare il pensiero politico di tecniche operative. Questa mi pare l’urgenza. Secondo me gli studi urbani e la ricerca architettonica potrebbero essere intese come degli interessantissimi laboratori nei quali tentare questa impresa di dotare la politica di tecnica e di pensare politicamente le tecniche operative. Perché appunto un’architettura senza progetto non è architettura, e una riflessione urbana incapace di pensare l’artificialità dei territori – e quindi la trasformazione dell’ambiente – non è una riflessione urbana seria. Questo mi sembra il nodo.
L: Altrimenti è difficile pensare una politica affermativa…
M: Ma sì, ma voglio dire: gli spazi urbani e l’architettura sono fatti terribilmente materiali. Ma quello che stiamo dicendo, bada bene, vale anche per quel largo settore della sociologia urbana o della geografia che esiste e definisce attori, dinamiche, conflitti tecniche di gestione in maniera rigorosa e precisa. Senza però la capacità di farne materia politica, anche queste ricerche diventano fotografie statiche, cristallizzazioni. Ed allora, per dirla con Pierre Bourdieu, anche la sociologia “più rigorosamente dedita a descrivere sarà sospettata di prescrivere”. Non si esce da questo vincolo. Senza politica non c’è analisi e non si dà analisi che non sia un campo di lotta politica. Limitarsi a dire “le cose stanno così” diceva Bourdieu “è criminale, perché non c’è nulla di meno neutro quando si tratta dei mondi sociali, che l’enunciare l’essere con autorità”. Allora anche lì, su quel livello, dobbiamo ricominciare ad avere un po’ più di coraggio teorico. Disincanto e progetto, realismo e utopia…
L: Giusto allora un’ultima questione che penso si leghi a questa del coraggio teorico. Mi sembra emerga dalla nostra chiacchierata la necessità – non per inventare l’ennesima formula, ma poiché credo colga una dimensione inedita nella pratica e critica politica – di pensarsi infrastruttura, di costruire infrastrutture, di pensarsi costruendo e viceversa, lavorando proprio nel cuore delle discipline come l’architettura che sono – come scrivi – tecniche che pensano. Mi sembra interessante catturare con questa idea l’elastico di pro-iacio e entwurf – di visione (etimo latino) e via-dà (etimo tedesco) – cioè il movimento, l’abisso entro cui (come fece vedere Cacciari) si muove il progettare. In più, riprendendo un classico, mi sembra potrebbe così apparire in inedita ed operativa luce la posizione, il metodo da dentro e contro. Né verso putativi fuori, né entro scenari apocalittici ma urbanamente da dentro e contro. Abbiamo detto: metropoli implica una certa soggettività, una certa educazione soggettiva alla sua altezza, all’altezza della vita nervosa che esplicita. Siamo arrivati quindi al punto di dire che è necessario attrezzare la politica con strumenti tecnici e viceversa far parlare politicamente quegli strumenti tecnici. È qui – e su questo ti chiedo di intervenire – che mi sembra che l’idea del pensarsi infrastruttura, del divenire architetto anche delle militanze, scarti rispetto alla coltre. Da una parte assume operativamente la Bildung della Grosstadt, dall’altra si apre a pensare, ad agire, ad esplicitare, ad attivare la necessaria postura costruttiva, progettuale in senso urbano-politico anche del metodo “da dentro e contro” evitando però di ricadere nel principio di forma, nell’architettura assoluta, nell’oggetto urbanistico espressionista. Pensarsi infrastruttura ci carica secondo me di questa responsabilità per i nostri giorni inedita: ovvero di immaginare la trasformazione politica dello spaziotempo nella sua elastica materialità, cioè di fare in definitiva Progetto, di raccogliere a questo livello del problema – qui nell’urbanizzazione planetaria, nella Bigness e nel cambiamento climatico – l’agitazione tecnologica e metabolica della moltitudine, il suo lavorare e trasformarsi con la materia. Cosa ne pensi di questo approccio? Può essere utile a fini che ci siamo posti? Coltre → architettura, urbanistica, ingegneria → prassi e pensiero politico che diradi la nebbia.
M: Pensarsi infrastruttura secondo me è di nuovo, sostanzialmente, il non lasciare all’altro – all’infrastruttura capitalistica – tutta la forza, l’intelligenza, la potenza che produciamo noi in comune, collettivamente. Vuol dire avere il coraggio di dire che questa enorme rete di connessioni, di commerci, di spostamenti di uomini e cose che copre il pianeta, così come questa enorme rete di circolazione di saperi, conoscenze e ricerche, tecnologia e produzione… che tutto questo è ricchezza comune e come tale va rivendicata e gestita. Questo secondo me è pensarsi infrastruttura, pensarsi tecnicamente. Ci sono due dimensioni del comune: il comune non è semplicemente un dato inerte, ciò che non dipende dalla produzione – sul quale sarebbe imposto un elemento distruttivo, cioè l’attività dell’uomo capitalisticamente organizzata – ovvero, l’acqua, l’aria, il verde dei campi etc. Il comune è anche e soprattutto tutto l’accumulo di tecniche e storia, di sapere, di scienza e di tecnologia che costituisce oggi la ricchezza del mondo : è questa qui l’infrastruttura che va pensata e rivendicata in comune. Il che vuol dire piegandone le dinamiche in una direzione che non sia distruttiva. Questo vuol dire rovesciare completamente il discorso critico per come si muove almeno negli ultimi tempi, dominato com’è da misticismi, orientalismi, localismi, ma anche da un fondo terribilmente heideggeriano, no? – in questo senso dicevo che serve coraggio teorico. Il problema è che il coraggio teorico ce lo danno le lotte che si sviluppano e siamo in grado di costruire, che a loro volta stanno al livello del pensiero che riusciamo a produrre. Sai come diceva il vecchio Marx : “L’umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere”. Io penso che sia proprio così, almeno nel senso che è solo dalla riattivazione di terreni di lotta su questi livelli che stiamo analizzando che secondo me questa forza anche di pensiero e di progetto potrà lentamente strutturarsi.