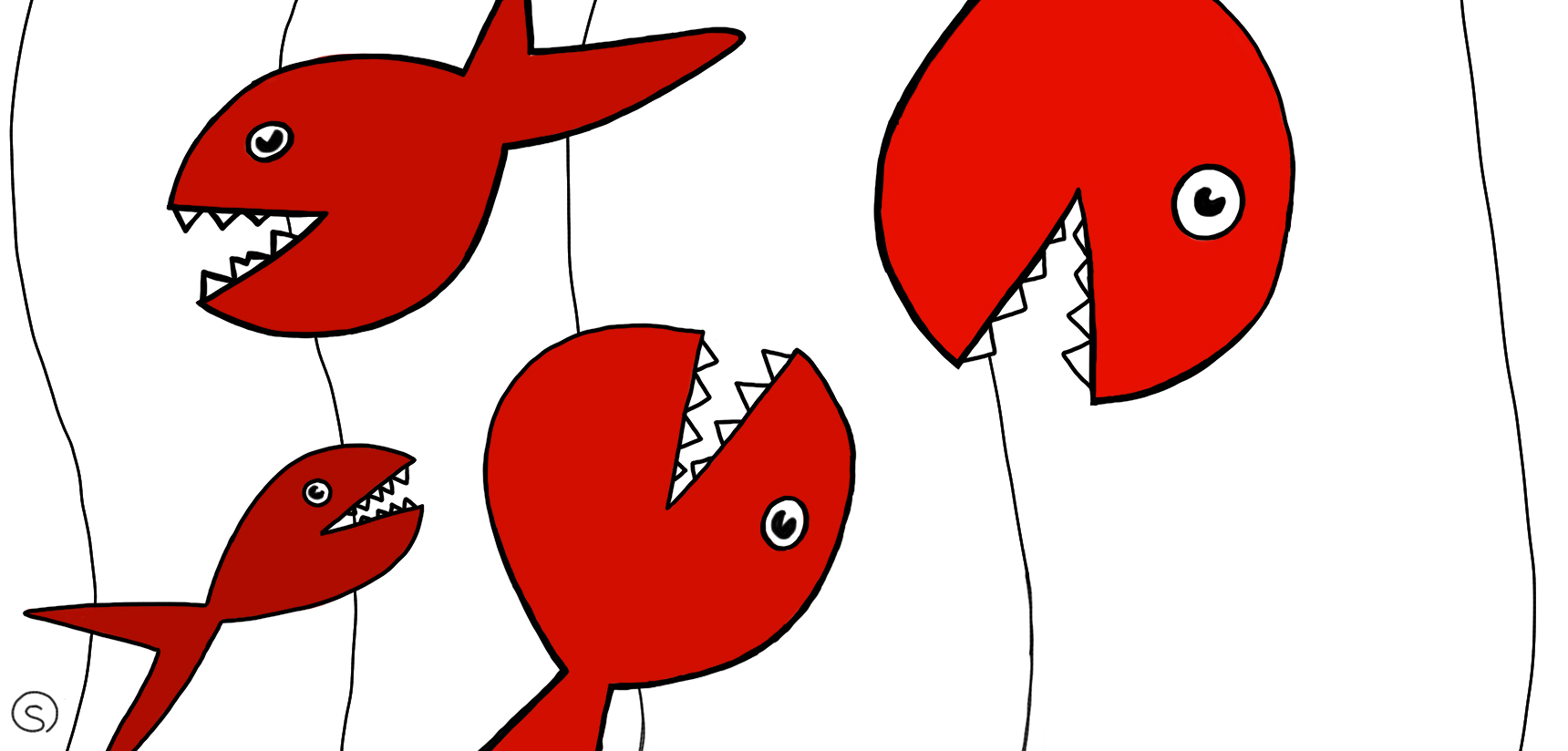Di GIROLAMO DE MICHELE
A cavallo fra Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines e L’Archéologie du savoir, cioè nel 1968, quando Foucault partecipa a due dibattiti su metodo archeologico [Réponse à une question, Sur l’archéologie des sciences], la pratica archeologica ha una valenza politica?
Una risposta è in un piccolo corpus di enunciati sulla regressione archeologica, prodotto da un gruppo di studiosi in esplicita relazione con l’archeologia foucaultiana, che può rendere il senso delle parole in una temperie politica e culturale che oggi ci appare lontana. Si tratta di Gianni Celati, Italo Calvino, Enzo Melandri, Guido Neri, che si riunirono per un certo periodo attorno all’idea di una rivista che avesse al proprio centro un’idea di archeologia che, quantomeno per Melandri e Celati, doveva tenere insieme l’Archeologie di Foucault e le pagine sull’archeologia di La linea e il circolo di Melandri. I testi “archeologici” di Celati e Calvino, poi pubblicati autonomamente, furono concepiti come materiali per la discussione del progetto. Il comune denominatore è il procedimento archeologico, inteso come «il risalire la genealogia finché non si giunge a monte della biforcazione in conscio e inconscio del fenomeno in questione. Si tratta dunque d’una regressione: non però all’inconscio come tale, bensì a ciò che lo ha reso inconscio – nel senso dinamico di rimosso» [Melandri, La linea e il circolo].
Per Celati, il privilegio dell’oggetto archeologico rispetto all’oggetto storico sta nel fatto che mentre questo «può essere posto al centro d’una rete di sviluppi, o visto come indice d’una direzionalità», quello «è al margine dei possibili sviluppi, ed esaurisce in sé la propria continuità: come si dice, non ha fatto storia». L’archeologia introduce «il principio della differenza dell’altro rispetto all’io, della differenza dell’altrove rispetto al qui, e quindi dell’impossibile identificazione di questi poli. […] Questo definisce la poetica archeologica come ritrovamento di una alternativa alla Storia, o visione delle scelte scartate dalla Storia. Perché in questo modo la Storia non si mostra più come destino, e neanche come grammatica dell’agire umano, ma piuttosto come una serie di emergenze controllate con la loro riduzione a forme di identità con un telos o tracciato monumentale che porta fino a noi; oppure con la loro rimozione e scarto quando non si adeguano a queste forme di identità» [Il bazar archeologico (1970-1972), poi in Finzioni occidentali].
Per Calvino, «i metodi continuamente rettificati e aggiornati durante gli ultimi quattrocento anni per stabilire un posto per ogni cosa e ogni cosa al suo posto (e mettere da parte ciò che resta fuori), – quei metodi unificabili in una metodologia generale, la Storia, cioè la scelta d’un soggetto denominato l’Uomo» non tengono più: «L’urto che li sfascia – l’antagonista di quel preteso soggetto – si chiama ancora Uomo, ma quanto mutato da quello che credeva d’essere: è il genere umano dei grandi numeri in crescita esponenziale sul pianeta, è l’esplosione della metropoli, è la fine dell’eurocentrismo economico-ideologico, è il rifiuto da parte degli esclusi, degli inarticolati, degli omessi d’accettare la storia per loro fondata sull’espulsione, l’obliterazione, la cancellazione dai ruoli». Assumere lo sguardo dell’archeologo significa perciò mettersi «dalla parte del fuori, degli oggetti, dei meccanismi, dei linguaggi» [Lo sguardo dell’archeologo (1972), poi in Una pietra sopra].
Per Melandri, infine, «l’archeologia richiede una regressione dionisiaca. Come osserva Valery, nous entrons dans l’avenir à reculons: per capire il passato, dovremmo parimenti risalirlo à reculons. Così inteso, il concetto di regressione diventa tanto ampio da comprendere nella sua virtuale giurisdizione non solo il Don Giovanni di Mozart o la Traumdeutung di Freud, ma anche il Black Power e ogni alta emergenza del rimosso, dell’escluso e dell’alienato» [La linea e il circolo].
Una quindicina d’anni dopo, Foucault espliciterà questa regressione verso il rimosso come lo studio del potere a partire da ciò che gli resiste, piuttosto che dal punto di vista della sua razionalità interna [Le sujet et le pouvoir, 1982]: a partire, diciamo noi, dall’emersione «delle diverse forme di resistenza ai diversi tipi di potere», sia come prese di parola che come visibilità, di ciò che alla razionalità del potere oppone resistenza, che da questa razionalità è rimosso, omesso, obliterato.
Secondo il Melandri de La linea e il circolo, «quel che muore, anche se Foucault non vuol dirlo, è l’uomo borghese, vittoriano e riformista»: un’interpretazione un po’ riduttiva, ma all’ordine del giorno, al suo tempo. Riletta oggi, potremmo forse assumerla, a fronte di un biopotere che assume sempre più le forme di una thanatocrazia, come ideale regolativo o, ricordando la lezione dei cinici, come stile di vita e di militanza rivoluzionari: «la vera vita come vita altra, come una vita di lotta, per un mondo cambiato» [Il coraggio della verità, 1984].
Questo testo è estratto da una relazione presentata al seminario “I distruttori della ragione” il 19 marzo 2015, all’interno della Scuola di Dottorato e Ricerca in Filosofia dell’Università di Padova (Dipartimento FISSPA) – XXVIII ciclo.