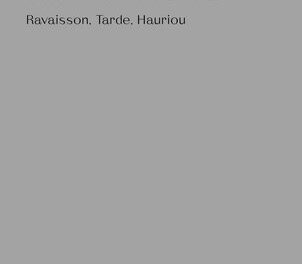di ALESSANDRO TAGARIELLO.
“Chi conosce se stesso e gli altri / riconoscerà che anche qui / Oriente e Occidente non sono più separabili” (Goethe, Divano occidentale orientale)
“La vendetta del Cielo non dimenticherà. Il tiranno arretrerà per le mie parole di fuoco, / e tremerà per l’ira di un poeta” (frammento di un poema nascosto nella parete della stanza del poeta iraniano Ferdowsi rivolto al Sultano Mahmud di Ghazni).
La pittura di Ali Banisadr [→ qui il suo sito] sembra coniugare le sonorità e il ritmo narrativo della grande tradizione poetica iraniana con l’assordante rumore del conflitto Iraq-Iran. Questa curiosa forzatura ha trovato la sua problematica soluzione quando l’artista iraniano – classe 1976 – fuggì con la famiglia negli States qualche mese prima che la guerra fosse terminata.
Sappiamo bene quanto questo conflitto sia figlio della piega teocratico-militare cresciuta in seno alla rivoluzione iraniana nel ’79 che provava a mettere insieme la spiritualità con le molteplici soggettivazioni etico-politiche (Foucault). E quanto, pertanto, questa “dualità dell’Uno” nel segno dell’Islam1 abbia prodotto pesanti coercizioni, morte e instabili faglie geopolitiche iscritte nel comando della potente macchina estrattiva dell’oro azzurro.
A Teheran, dov’era di casa la famiglia Banisadr, il clangore delle sirene anti-raid e il boato delle bombe rimasero appiccicati alle orecchie del piccolo Ali, peggio di uno sputo. Sin da subito questa sorta di acufene soggettiva da trauma fu da lui registrata senza mediazione alcuna su fogli da disegno.2 Tragico automatismo da surrealista in erba. Fu come se lo “stupro” uditivo di centinaia di migliaia di bambini si fosse rappreso in quel gesto spontaneo. E quei segni così espressivi, divenuti “suoni interiori” (Kandinsky), più tardi, si sarebbero prolungati nella lugubre granulosità del carboncino sulla carta e nei suoi graffiti californiani, per riversarsi poi nella ridda di pennellate che brulicano inquieti nello spazio delle grandi tele.
Ma quale specifico legame c’è tra certa poesia persiana e il modus operandi di Banisadr?
 Le sonorità poetiche, cui l’artista attinge, attraversano la portentosa epopea epica dello Shāhnāmeh (“Codice Regio” o “Libro dei Re”), antico testo rielaborato in versi dal poeta medioevale Ferdowsi, in cui la prima dinastia degli achemenidi, lascia spazio a ben altre scorribande. Questo lussureggiante poema persiano fa risuonare – secondo uno dei pionieri degli studi indo-iranici, l’orientalista e traduttore Italo Pizzi – il testo sacro pre-islamico, l’Avestā, concrezione poetico-cosmologica della religione zoroastriana.
Le sonorità poetiche, cui l’artista attinge, attraversano la portentosa epopea epica dello Shāhnāmeh (“Codice Regio” o “Libro dei Re”), antico testo rielaborato in versi dal poeta medioevale Ferdowsi, in cui la prima dinastia degli achemenidi, lascia spazio a ben altre scorribande. Questo lussureggiante poema persiano fa risuonare – secondo uno dei pionieri degli studi indo-iranici, l’orientalista e traduttore Italo Pizzi – il testo sacro pre-islamico, l’Avestā, concrezione poetico-cosmologica della religione zoroastriana.
Georges Dumézil ha ravvisato nei suoi testi, i miti come quello degli antichi Arii (Irani e Indiani) mostrano essenzialmente le medesime funzioni, sacrale-giuridica, guerriera, produttiva.3 Nel nostro caso, dunque, l’elemento di religiosità presente in quei popoli – che dall’Asia centro-settentrionale si stanziarono in un’area ben più vasta dell’attuale Iran – si intrecciò ben presto con la presunta paternità originaria che essi accamparono su quella terra. Ma come puntualizza Pizzi nella sua Storia della poesia persiana (1890),4 quell’area in realtà era puntellata da popolazioni nomadi (i Turanici, antenati degli Sciiti), «diverse di lingue e di stirpi, ma già potenti e famose nelle arti e nei commerci, abili nella lavorazione dei metalli e dunque adoranti «deità infernali e sotterranee», che di quelle miniere ferrose ne erano i custodi. Questo aspetto ctonio diverrà il grimaldello nelle teste della casta sacerdotale zoroastriana per legittimare, sul piano religioso e non solo, l’avversità degli iranici – legati al culto della luce, dimora del spirito benigno Ahura Mazdà – nei confronti dei “barbari” delle caverne, custodi, a loro dire, di Anra Mainyu, lo spirito maligno. Ed ecco l’Avestā, nella sistematizzazione che ne farà il profeta Zarathuštra, quale potente “organon” mistico-prescrittivo. Qui i segni simbolico-spirituali, un tempo dispersi – perché legati essenzialmente ad un naturalismo “meticcio” che seguiva i cicli dell’agricoltura praticata dagli iranici – si incardineranno nello scontro mitico e, insieme storico, con i nomadi (funzione guerriera in rapporto con quella produttiva). È su questa lunga opposizione verso tutto ciò che sarà avvertito come “straniero” che si giocherà la lunga costruzione di una curiosa identità nazionale che dovrà inglobare, a partire dal VII sec., l’islamismo arabo, abbandonando così man mano la musicalità dell’antico alfabeto pahlavi (di che si compone lo Shāhnāmeh e l’Avestā), in favore dei caratteri arabi.
Ora, è proprio la molteplicità dei piani sonori presenti nell’antica poesia orale – questo lirismo luminoso che dà voce, ad esempio, allo stridìo metallico dell’acinace in guerra, come al flusso proteiforme della preghiera (tradotti nell’elegante calligrafismo persiano) – che ritroviamo, in qualche modo, nello squassamento ritmico dei tratti pittorici di Banisadr. Tratti che si nutrono della splendida produzione miniata del XVI e XVII sec., vivida nella preziosità dei colori e che accompagna questa oralità modulata nei testi. Qui, le immagini moltiplicano la complessità narrativa, costituendo così il materiale “fermentato” nella testa di Ali.
Accanto al suo interesse per la poesia epica persiana, troviamo anche l’esplorazione visiva delle biforcazioni seriali di Louis Borges (scrittore da lui omaggiato con il quadro: Aleph), della densità “aperta” e transtorica di Umberto Eco e Orhan Pamuk e della scrittura post-moderna dell’iraniana Porochista Khakpour (la copertina del cui libro: The Last Illusion presenta una sua opera inedita).5
Ma cosa accade quando mondi narrativi apparentemente così lontani si articolano sulle sue tele?
Banisadr dirà: «Sono affascinato da tutte le storie di guerra, le cospirazioni, il colonialismo, la corruzione, le battaglie antiche e moderne… L’opposizione e il conflitto sono al centro del mio lavoro».6
Ad un primo sguardo, le opere dell’artista sembrano mostrare un materiale narrativo eterogeneo che letteralmente deflagra, perché c’è una forza pittorica altrettanto potente che le si oppone.
Ma sarebbe un esercizio troppo semplice che presuppone già un cliché: il falso-movimento della rappresentazione come istituzione degli opposti. Qui, invece, il conflitto di cui parla Banisadr è il motore della produzione di differenza, grazie all’invenzione immanente di tratti pittorici a più teste. Molteplicità di piani cromatici a più dimensioni, delirio della storia dispersa in lacerti visivi.
Si tratta di rapporti di forza interni all’opera, dunque, di tutta una microfisica dell’evento pittorico.
E allora, proviamo innanzitutto col dire che l’eterogenea iconografia occidentale cui l’artista fa riferimento, è attraversata da linee di forza zigzaganti, sghembe, “oppositive” che risuonano nella medesima organizzazione visiva persiana.
 Vediamo da vicino. Gli stimoli percettivi di Ali che guardano a ponente, vanno dal fitto bestiario della “coppia” fiamminga, Pieter Bruegel il Vecchio e Hieronymus Bosch – non a caso legatissimi alla infinita ricchezza e miseria della cultura religiosa popolare (si pensi a Proverbi fiamminghi del primo, come al Giardino delle delizie del secondo) – fino al proto-astrattismo di De Kooning, certo Richter e Cecily Brown.
Vediamo da vicino. Gli stimoli percettivi di Ali che guardano a ponente, vanno dal fitto bestiario della “coppia” fiamminga, Pieter Bruegel il Vecchio e Hieronymus Bosch – non a caso legatissimi alla infinita ricchezza e miseria della cultura religiosa popolare (si pensi a Proverbi fiamminghi del primo, come al Giardino delle delizie del secondo) – fino al proto-astrattismo di De Kooning, certo Richter e Cecily Brown.
Dunque, se in arte sono più importanti le alleanze delle filiazioni, cerchiamo di capire cosa trova Banisadr in questa sostanza compositiva endogena, comune all’arte persiana e a questi pittori, trascinata da fughe che producono una visione complessa.
In un’intervista l’artista ci dà una mano: «Non ho un punto focale nel lavoro. Ogni parte del dipinto è importante. Non c’è gerarchia».
E allora, se la cartografia dell’arte medioevale – nelle miniature d’oriente come nei tableau d’occidente – è attraversata da soggetti artistici che illustrano l’Hortus conclusus della vita quotidiana, come espressione del sorvolo della potenza divina celebrata in ogni più piccolo dettaglio dipinto sul piano – saturazione visiva, questa, che, nel Novecento, si prolungherà curiosamente nell’ateismo centrifugo della pittura gestuale –, con Banisadr giungiamo ad una perdita “anarchica” e definitiva del centro. E questa perdita, provocata da molteplici micro-esplosioni segniche locali, sembra condurre il nostro sguardo nell’istante in cui il conflitto si tuffa nell’indeterminatezza diffusa.
Certo, in questi tratti pittorici riconosciamo la straordinaria lezione di Velázquez, nel loro apparire al contempo rapidi eppure così potentemente definitivi, precisi, nella visione d’insieme, ma qual è quell’attività artistica che cospira con l’indeterminatezza, tanto da restituircene la sua costituente invisibilità?
Con Deleuze, diciamo che è senz’altro la musica quell’arte che ha a che fare con l’estrazione di un universo indeterminato. Intendiamo riferirci ai suoni percussivi: basti pensare a Ionisation di Edgard Varèse [→ qui].
Ora, se «l’essenza clinica della musica» è schizofrenica, così come la pittura è più vicina all’isteria,7 chi ha tentato nell’arte figurativa di colmare questo scarto ha dovuto schizofrenizzare l’opera.
Ci viene subito in mente Kandinsky con Lo spirituale dell’arte, nel quale crea ed organizza le corresponsioni tra suoni e colori, secondo una visione più mistico-poetica: «Il colore è il tasto, l’occhio è il martelletto, l’anima è un pianoforte».
Banisadr si spinge più avanti. È più viscerale, bulimico. Le sonorità più disparate prima di tutto: musicali, poetiche, letterarie, cinematografiche (si pensi all’opera Ran come cadeau ad un film di Kurosawa).
L’umiltà gli fa dire: «C’è sempre un suono che sento con il movimento dei colori. Kandinsky possedeva la sinestesia. Anch’io penso di averne un po’».8
Ma quale suono può avvertire mentre “sente” il colore (percezione insieme visiva e uditiva), se non il movimento reale, percussivo, e per ciò stesso indeterminato, della guerra. C’è «una guerra civile nella mia testa» – dice.
 Il trauma fa segno e il mondo va in frantumi sotto l’effetto dinamico di forze attive (nella parte superiore dei quadri) e reattive (in quella inferiore); aggiunge l’artista: «in alto si fluttua e si medita» – riferimento al suo interesse per la religione zoroastriana esemplificata in opere come Fravashi [a destra] presentata alla Biennale di Venezia del 2013.
Il trauma fa segno e il mondo va in frantumi sotto l’effetto dinamico di forze attive (nella parte superiore dei quadri) e reattive (in quella inferiore); aggiunge l’artista: «in alto si fluttua e si medita» – riferimento al suo interesse per la religione zoroastriana esemplificata in opere come Fravashi [a destra] presentata alla Biennale di Venezia del 2013.
Ora, queste forze sono il risultato di gesti pittorici che seguono un flusso sonoro sintonizzato sui colori nello stesso istante in cui questi sono agiti. Pura simultaneità dello scambio.
Se la tavolozza di Banisadr è così ricca vorrà dire dunque che avremo molteplici suoni; anzi, molteplici timbri. Non a caso il percetto di timbro è comune alla musica e alla pittura. In musica, la timbrica è per sua natura multidimensionale, non misurabile. Medesima sorte nei quadri dell’artista: la morfogenesi delle immagini è unicamente policromatica; cosicché la molteplicità di movimenti dei colori potrà produrre la sua polifonia. Con l’unica non trascurabile differenza, però, rispetto alla performance musicale: il direttore d’orchestra ha abbandonato il leggio, il centro della scena. Ed è per questo che i “musicisti” (o ciò che resta di loro) si danno alla pazza gioia. Beanza della moltitudine!
Con Miles Davis nelle orecchie, Banisadr dipinge come il jazzista con la sua tromba: prelevando dall’eterogeneo e mettendo talvolta la sordina nei guizzi inventivi (equivalente delle politure sottrattive locali – procedura dagli echi baconiani). Ma, diversamente dal rapporto che Pollock ad esempio intrattiene con la musica jazz imbrigliata in qualche modo nell’inorganicità di una visione astratta, gli ascolti del nostro si traducono in una pittura subfigurativa sempre in bilico tra caso e necessità e che magicamente riesce a mantenere “udibile” il limite tra visibile ed invisibile nello spazio del Fuori.
Nelle sue opere, la visione “a volo d’uccello” è tutt’altro che un modo inedito di spostare il punto di vista per ritrovare comunque, in un tutto organizzato che quella visione consente, l’integrità di Dio e di sé – vedi Bosch e Brueghel o le miniature persiane.
Questo volo non ha nulla di metafisico, la rappresentazione si è dileguata e con essa qualsiasi tutela dell’Ordine. E la linea d’orizzonte non è che la furiosa traccia dell’articolazione energetica delle forze attive e reattive. Sogno nietzschiano…
Qui la scelta del punto di vista sembra coincidere con un dispositivo audio-visivo che per sua natura modifica la materia pittorica portandola ad un perenne stato di turbolenza. Un po’ come avviene nel Principio di Indeterminazione di Heisenberg, lì dove si afferma che qualsiasi sistema di osservazione e misurazione di fenomeni subatomici porta all’alterazione dello stato dell’osservato (es: impossibilità di misurare contemporaneamente la posizione e la quantità di moto di una particella).
Del resto, dal punto di vista fisico cos’è la luce se non il risultato di un movimento insieme ondulatorio e corpuscolare dei fotoni, puri attributi non visibili e misurabili? E la visione pittorica non è già un’organizzazione quantitativa e perturbante di ciò che permane sui bordi dell’invisibile?
Ecco così che l’indeterminatezza timbrica, percussiva, presente nelle opere di Banisadr, è ritagliata su questo sfondo fenomenico incommensurabile, di cui si può cogliere unicamente l’effetto analogico caotico.
Ma non basta un cambio di paradigma per mutare l’impiego del dispositivo audio-visivo. Occorre anche una diversa organizzazione dello spazio. E infatti l’artista affronta la composizione complicando i piani sui quali sciamano le timbriche. Il risultato è una lotta tra uno spazio piatto ed uno profondo. Ancora una volta, però, questo scontro non veicola una qualche dualità, perché nel movimento dell’andirivieni lo sguardo dell’osservatore coglie dinamicamente i continui salti e le piroette segniche, le cancellazioni parziali che fanno debordare questi spazi.
Così come le stratificazioni ottenute sono tempo catturato durante le sessioni pittoriche e di cui possiamo coglierne pian piano lo scorrere grazie alla qualità dell’intervento artistico: uno splendido cronocromatismo al servizio della musicalità delle immagini.
Il tema della spiritualità politica in rapporto alla rivoluzione islamica affrontato da Foucault è problematizzato molto bene in un post di Wu Ming 1 dal titolo: Foucault in Iran: rivoluzione, entropia, uguaglianza [→ qui]. In alcuni passi lo scrittore mette in luce la questione della reductio ad unum delle molteplicità politico-religiose, provando a riflettere su quanto – al netto delle differenze – questa fase ricalchi la “termodinamica” della rivoluzione par excellence, quella francese. Tema, quest’ultimo, magistralmente romanzato nell’ultimo libro del collettivo: L’armata dei sonnambuli. ↩
Nell’articolo pubblicato online sul → “Whitehall Magazine” e moderato da Katy Donoghue, Ali Banisadr dice qualcosa di interessante in merito ai suoi ricordi d’infanzia, mentre conversa con la scrittrice Porochista Khakpour: «[…] My mom says that when the bombings were happening I would make drawings based on the sounds and vibrations, to make sense out of what was happening». ↩
Georges Dumézil, L’ideologia tripartita degli Indoeuropei, Il Cerchio ed, 2003. ↩
Le suggestioni letterarie e le dichiarazioni dell’artista contenute in questo pezzo sono state tratte dagli articoli: How Ali Banisadr holds memory di Emily Mc Dermott; da un’intervista di Julie Chae: Conversation with Ali Banisadr; e dal dialogo tra Banisadr e l’artista americano Greg Lindquist pubblicato sul sito di quest’ultimo: Conversation with Ali Banisadr. Vedi, infine, “International Flash art”. ↩
Dal sito della galleria di Thaddaeus Ropac che presenta opere dell’artista, un breve ma efficace inciso [→ qui]. ↩
Gilles Deleuze, Francis Bacon. La Logica della sensazione, Quodlibet, 1995, pag 116. ↩
Frase tratta dall’articolo di Meghan Dailey apparso su “New York Street Journal” Painter Ali Banisadr’s Sound Inspiration. ↩