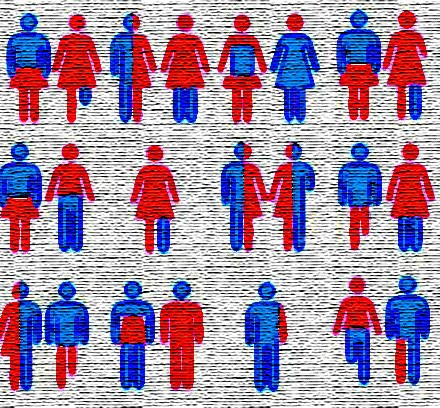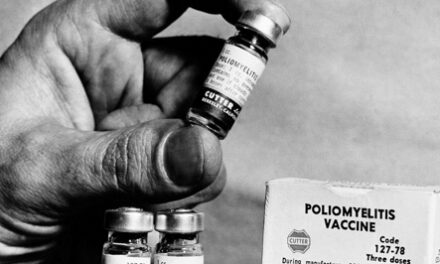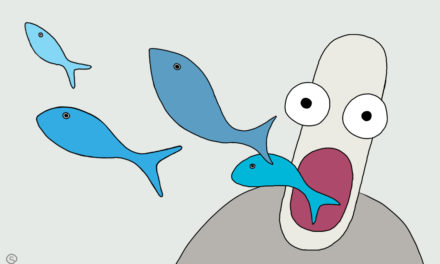di MARIA ROSARIA MARELLA.
[pubblichiamo l’introduzione al saggio di M.R. Marella pubblicato in Politica del diritto, vol. XLVIII, n. 3, settembre 2017, pp. 383-413. L’intero saggio è scaricabile in pdf ⇒ qui]
Sommario
1. Introduzione – 2. Sessualità e identità – 2.1. Dalla rivendicazione delle differenze alla critica anti-identitaria – 2.2. Dispositivi giuridici, identità e costruzione del soggetto – 2.3. Queer Theory e femminismo – 3. Critiche post-coloniali – 4. Conclusioni: il queer come stile
1. Introduzione
La teoria queer nasce come reazione all’istituzionalizzazione degli orientamenti sessuali, delle identità sessuate e della sessualità in genere, prodotte dalle politiche identitarie della sinistra “liberal” che si affermano negli Stati Uniti a partire dagli anni Ottanta, quando le varie espressioni dei movimenti di liberazione sessuale che prendono vita negli anni Sessanta e Settanta vengono sterilizzate nel politically correct e convogliate in un nuovo conformismo, perdendo quei tratti di trasgressione che ne avevano fatto una controcultura e un progetto di liberazione e trasformazione1. In risposta ad esse, la teoria queer offre innanzitutto lo strumentario teorico per comprendere e analizzare gli aspetti coercitivi di tali politiche identitarie. In secondo luogo propone una postura, uno stile, un posizionamento alternativi alla seriosità e a un certo bigottismo che caratterizza l’identity politics e i suoi cantori accademici, una volta divenuti mainstream (Ford 2007). L’identity politics produce infatti un nuovo senso del decoro, un set di indicazioni prescrittive sul modo corretto in cui la sessualità – particolarmente nelle sue espressioni “dissidenti” (Halley 2000, pp. 40-41) – deve esprimersi per poter accedere alla sfera pubblica. Parallelamente essa diffonde un chiaro messaggio: la rivendicazione dei diritti LGBT è materia riservata ai professionisti (Ford 2007), politici, giuristi, intellettuali di mestiere. La teoria queer offre per contro la possibilità di riportare la sessualità, nelle molteplici forme di vita che essa connota, dentro il quotidiano e la controcultura pop, nei conflitti e le negoziazioni fra le multiple soggettività che popolano le relazioni urbane (Binnie 2010, p. 21), sottraendola all’ortodossia. Facendone l’oggetto di una teoria street-level.
Il punto d’attacco, come noto, è stato essenzialmente il matrimonio gay2. Prima che il tema venisse iscritto nell’agenda del movimento gay e lesbico, all’inizio degli anni Novanta, l’istituto del matrimonio era ritenuto in sé discriminatorio in quanto esclusivamente eterosessuale. Veniva giudicato come un privilegio che gli eterosessuali gelosamente custodivano per conservare intatta la loro supremazia nella società. Ma inizialmente non era un obiettivo realmente condiviso nel movimento omosessuale.
In risposta allo stigma che colpisce la comunità gay statunitense in seguito alla terribile epidemia di AIDS che la travolge, la rivendicazione del matrimonio same-sex si rafforza e diffonde. Nelle parole di uno dei suoi sostenitori più noti e radicali, William Eskridge, la vicenda dell’AIDS è in qualche modo esemplificativa della cultura gay, dell’innocenza e la spensieratezza che hanno caratterizzato la comunità gay prima di quel tragico momento. Ma l’attraversamento di quella vicenda marca una svolta all’insegna di un nuovo senso della propria dignità. Una dignità che deve trovare il suo suggello nell’accesso al matrimonio (Eskridge 1996). Ora, la gran parte degli attivisti pro-gay rights sono inizialmente sconcertati da questa campagna; ritengono infatti che ci siano questioni assai più importanti per cui battersi: lotta all’AIDS, accesso alle cure mediche, lotta contro l’omofobia, contro le discriminazioni sul posto di lavoro, contro le disuguaglianze e l’onnipresenza di privilegi “etero” nella vita quotidiana.
Ma c’è un nodo strategico da sciogliere prima di tutto questo: la scelta è infatti fra lo schierarsi a favore dell’affermazione e la difesa dell’identità gay e lesbica o, all’opposto, mobilitarsi per promuovere una cultura non normativa della sessualità. In questa alternativa si definisce il significato che si intenda attribuire all’uguaglianza come valore giuridico e obiettivo politico; una questione che sta al cuore dello scontro fra i sostenitori dell’identity politics e i suoi oppositori.
Ovviamente la seconda posizione è quella chiaramente espressa dal pensiero queer, che in questa contrapposizione mette a fuoco i suoi capisaldi3. Il rifiuto del matrimonio è rifiuto dell’invadenza dello standard eterosessuale che lo regola, ma ancor prima, rifiuto della legittimazione della sessualità da parte del diritto dello Stato – o dello Stato di diritto! Inoltre il disciplinamento che il matrimonio realizza non riguarda solo le persone che si sposano ma anche quelle che ne restano fuori, quelle che restano fuori anche dal matrimonio same-sex: adulteri, promiscui, divorziati, single, prostitute, chi fa sesso coi minori, ecc. Infatti, finché il matrimonio esiste, lo stato continua a regolare (a stigmatizzare) il sesso di chi non è sposato (Warner 1999). Ed è il rigetto di questo disciplinamento la prima rivendicazione della sexual justice reclamata inizialmente dal movimento gay e lesbico, ma poi abbandonata dagli attivisti pro-marriage, che ad un tratto mettono da parte la critica radicale alla famiglia e al matrimonio elaborata innanzitutto dalle femministe lesbiche per rifugiarsi in un ideale romantico di vita coniugale spogliato di qualsiasi valenza politica e interpretato come fatto unicamente individuale e privato, il trionfo dell’amore e nient’altro.
 Questa vicenda è al cuore dell’identity politics LGBT, che nella richiesta di accesso al matrimonio sperimenta una certa idea di uguaglianza (normalizzazione per il queer) e certamente la persuasività retorica del binarismo etero/omo4. Il pensiero queer per contro rigetta in radice la sostanza di tale binarismo poiché al contrario concepisce l’identità sessuale non come categoria ma come continuum (fra etero e omosessualità), come fluida e mutevole e non come monolitica e “una volta per tutte”. Non a caso il pensiero queer afferma che le identità omosessuali non preesistono all’identity politics che le concerne, ma sono da essa create (Halley 2000, p. 42). Pertanto la critica al matrimonio same-sex non riguarda solo l’opportunità politica della sua rivendicazione o lo specifico del matrimonio reso accessibile a coppie gay e lesbiche, ma piuttosto il matrimonio come istituzione giuridica e sociale, in quanto dispositivo in grado di costruire l’identità sessuale di chi vi accede e di chi non vi accede, quale che sia il suo orientamento. Mentre la corsa al mainstream conduce gli attivisti pro-marriage ad assumere l’istituzione acriticamente, come componente naturale della realtà sociale, l’atteggiamento queer con l’ironia, la beffa, lo scherno, punta tutt’all’opposto al disvelamento del suo carattere di mera (= artificiosa) convenzione sociale (Ford 2007). È dunque una critica riferibile in primo luogo allo stesso matrimonio eterosessuale, ed esportabile a ogni ulteriore contesto normativo che si definisca intorno alla codificazione di un’identità.
Questa vicenda è al cuore dell’identity politics LGBT, che nella richiesta di accesso al matrimonio sperimenta una certa idea di uguaglianza (normalizzazione per il queer) e certamente la persuasività retorica del binarismo etero/omo4. Il pensiero queer per contro rigetta in radice la sostanza di tale binarismo poiché al contrario concepisce l’identità sessuale non come categoria ma come continuum (fra etero e omosessualità), come fluida e mutevole e non come monolitica e “una volta per tutte”. Non a caso il pensiero queer afferma che le identità omosessuali non preesistono all’identity politics che le concerne, ma sono da essa create (Halley 2000, p. 42). Pertanto la critica al matrimonio same-sex non riguarda solo l’opportunità politica della sua rivendicazione o lo specifico del matrimonio reso accessibile a coppie gay e lesbiche, ma piuttosto il matrimonio come istituzione giuridica e sociale, in quanto dispositivo in grado di costruire l’identità sessuale di chi vi accede e di chi non vi accede, quale che sia il suo orientamento. Mentre la corsa al mainstream conduce gli attivisti pro-marriage ad assumere l’istituzione acriticamente, come componente naturale della realtà sociale, l’atteggiamento queer con l’ironia, la beffa, lo scherno, punta tutt’all’opposto al disvelamento del suo carattere di mera (= artificiosa) convenzione sociale (Ford 2007). È dunque una critica riferibile in primo luogo allo stesso matrimonio eterosessuale, ed esportabile a ogni ulteriore contesto normativo che si definisca intorno alla codificazione di un’identità.
Ora, nell’analisi giuridica, il punto di vista queer in tanto è proponibile e utile, in quanto anche nel diritto gli si riconosca un lavoro da svolgere, in quanto cioè serva a smascherare e a sottoporre a critica il ruolo che le identità eventualmente giochino quali dispositivi in grado di configurare lo statuto giuridico delle persone nelle loro relazioni sociali, economiche, familiari. Ebbene, se è vero che la rilevanza normativa delle identità è un dato strutturale dell’attuale esperienza giuridica, tanto da essere annoverata fra i caratteri salienti della corrente fase di globalizzazione del diritto (Kennedy 2006), allora l’approccio queer può rivelarsi uno strumento importante per l’analisi critica. E questo è quel che tenterò di argomentare nelle poche pagine che seguono, a partire da qualche cenno allo strutturarsi di una ‘questione identitaria’ all’interno del diritto attuale.
Una “questione identitaria” come tendenza dominante nel discorso giuridico sembra in primo luogo investire la soggettività giuridica intesa come categoria che definisce l’astratta attitudine ad essere titolare di diritti e doveri. Nella fase corrente, il soggetto di diritto sembra invero aver perduto quella vocazione universalistica, trasversale alle innumerevoli differenze che connotano le persone in carne e ossa, che ha contrassegnato la sua comparsa nel diritto moderno e la sua funzione di elemento ad un tempo unificante e semplificante della varietà delle relazioni giuridiche che attraversano il tessuto sociale5. Quella nozione appare oggi come frammentata in molteplici identità che assumono rilevanza giuridica e mappano le differenze in senso statico e dinamico (dal genere, la razza, l’orientamento sessuale, la cultura e la fede religiosa all’età e alla condizione di disabilità6, in una partitura biopolitica a 360 gradi, che non disdegna di dare specifico rilievo pure al ruolo assunto occasionalmente o stabilmente nel mercato7. Se qualcosa è rimasto degli originari caratteri di universalismo e trasversalità, questo è da ravvisarsi nel rispetto della dignità umana, in quell’accezione minimalista della dignità che si esprime con il divieto di pratiche eugenetiche, clonazione riproduttiva, vendita delle parti del corpo, come esemplificato dall’art. 3 della Corte dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e corrisponde a quel nucleo duro dell’umano, ridotto ai termini ultimi della nuda vita, che non deve essere alterato. Per il resto non vi sono diritti civili o patrimoniali, come è stato un tempo per la proprietà, o diritti sociali, come quelli riconosciuti al lavoro dalla costituzione italiana, capaci di costituire l’ossatura di una soggettività giuridica omogenea. Dietro la matrice comune di una sostanza umana ultima e minimale, giuridificata nel principio del rispetto della dignità, emerge la frammentazione del soggetto di diritto in un caleidoscopio di identità, senza che sia possibile cogliervi i lineamenti di un disegno politico “promozionale” chiaro e preciso, quale emergeva invece dalla fisionomia del cittadino borghese prima e del lavoratore salariato poi. Già rispetto a questa prima affermazione, peraltro, la teoria queer offre un angolo visuale non banale, permettendo di individuare nel soggetto sessualizzato – qualcosa che va oltre la mera rilevanza giuridica della sessualità – la cifra di un progetto di società la cui portata politica merita di essere indagata. Ma di questo oltre.
Per altro verso la rilevanza giuridica delle identità si presenta come l’esito della centralità acquisita dai diritti umani, rispetto ai quali le identità individuali giocano un ruolo essenziale di strumento di adjudication. Per sua natura, infatti, il discorso dei diritti umani si articola attraverso l’individuazione di specifiche e differenti identità che tendono a frammentare la soggettività giuridica secondo genere, età, razza, orientamento sessuale, ecc., in tal modo occultando le condizioni economiche e sociali che nella realtà connotano le singole forme di vita (e con ciò il progetto politico che sta dietro l’individuazione di tali specifiche identità). Propria di questa fase è dunque la declinazione dei diritti fondamentali secondo identità particolari e non più su base universale. Ne consegue che stella polare della loro tutela sia non già il principio dell’uguaglianza sostanziale ma la formulazione di svariati divieti di discriminazione, tanti quante sono le identità reputate meritevoli di riconoscimento giuridico.
C’è dunque una grammatica giuridica, fatta di identità, di diritti umani, di antidiscriminazione, che rivendica per sé un nuovo tecnicismo, volto – come sempre quando il diritto pretende di porsi come mera tecnica – a occultare le ricadute politiche del legal enforcement, le reali poste in gioco, i rapporti di forza all’interno della società. È proprio qui, allora, che il punto di vista queer si rivela strategico, a partire dalla consapevolezza che il diritto e le istituzioni giuridiche normalmente generano e tutelano gerarchie sociali fondate sulle identità e che, fintanto è così che funziona, l’identità sarà sempre al centro dei progetti di riforma, e sarà sempre anche parte del problema. È ancora il pensiero queer ad avvertire, del resto, dell’evanescenza della linea di demarcazione fra un regime giuridico che dà riconoscimento ad un’identità e l’imposizione surrettizia di un codice di condotta che intorno a quell’identità si struttura, ossia dei possibili effetti coercitivi della rivendicazione di diritti identity-based (Appiah 1994).
Certamente, dunque, l’adozione di una postura queer porta ad affinare le armi dell’analisi critica innestando sul ceppo del realismo giuridico la prospettiva biopolitica ed estendendo lo spettro di indagine dell’analisi distributiva al terreno delle identità definite dalla sessualità, dalla razza, dall’età, dalle condizioni di salute, ecc.
Tuttavia, questo breve contributo è specificamente dedicato alla teoria queer, perciò la critica alla istituzionalizzazione delle identità e ai limiti delle politiche identitarie sarà comunque focalizzata sulla sessualizzazione delle identità stesse, prendendo spunto da alcuni fra i dispositivi giuridici che la rafforzano/determinano.
Con l’avvertenza che l’affermazione del “piacere omosessuale” non è direttamente collegata a progetti di anti-subordinazione e che “la lotta contro la repressione sessuale” può non aver molto a che fare con istanze di democrazia e uguaglianza sociale (Bersani 1987, pp. 197-222, specialmente 205 ss; Halperin 1995). ↩
Sul tema cfr. Warner 1999, p. 81 ss. ↩
Li illustra Warner (1999, p. 88 s.). Per una rassegna di temi e posizioni cfr. anche Cossman 2012. ↩
La critica al binarismo etero-/omosessualità è al centro del lavoro seminale di Sedgwick, trad.it. 2011. ↩
Cfr. Tarello 1988 e Gambaro 1988. ↩
Come emerge a chiare lettere dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. ↩
Si veda la rubrica del Titolo I, Libro I BGB e gli artt. 13 e 14 del Codice civile tedesco (BGB) come riformato nel 2002, che prevedono sotto la rubrica delle persone fisiche il consumatore e l’imprenditore. ↩