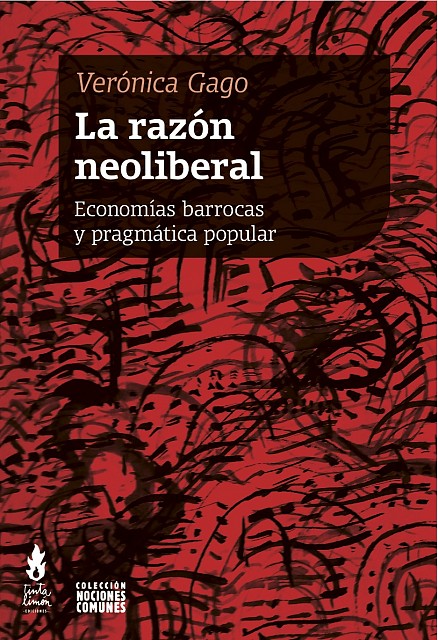Di MARIANA CARBAJAL e RITA SEGATO.
L’antropologa femminista Rita Segato è un’appassionata della conversazione. È incredibile come, a partire dal dialogo, costruisce pensiero. Quando cominciò a lavorare con i prigionieri condannati per stupro nel carcere di Brasilia, pensò che era una situazione eccezionale e che avrebbe presto abbandonato il soggetto di studio. Ma da allora, ormai già da più di due decadi, studia e cerca di capire la violenza contro le donne e in particolar modo i crimini sessuali. In un’intervista con PáginaI12 ha parlato delle motivazioni che muovono gli uomini che commettono abusi sessuali, della successione di episodi simili che si stanno dando ultimamente e della visione che ha la Giustizia rispetto a questo tipo di fatti. «Trattano la sofferenza delle donne come un “crimine minore” e questo lo vediamo. Dobbiamo avvisarli, far capire loro”, dice riferendosi agli operatori giudiziari.
Nell’ultima settimana, gli stupri di gruppo che si sono susseguiti nel paese l’hanno spinta a tornare sull’argomento.
Da anni parla di fratria maschile, del comportamento imitativo degli uomini in cerca di esibizione e di potenza nei crimini sessuali. «Definisco nei miei testi il crimine di genere come un crimine non strumentale ma bensì “espressivo”. Esprime la capacità di dominio e controllo della posizione maschile. È, proprio per questo, un crimine territoriale. Se ha un’utilità, questa utilità è “espressiva, comunicativa”. Esprime proprietà, e direziona questo enunciato agli sguardi dei pari nella corporazione maschile. È un crimine, in un certo senso, auto-riferito», segnala l’antropologa. Segato concepisce queste condotte come parte di un mandato corporativo della maschilità. L’ha detto spesso. Però ora il suo pensiero è diventato visibile. Ha anche detto che gli stupri di gruppo, in branca, che si ripetono, non sono la risposta al crescente attivismo femminista ma alla «precarizzazione della maschilità attraverso la precarizzazione della vita». Di conseguenza, la maschilità mostra il suo sfondo, nell’ansia di mostrare una potenza che non può più esercitare. La capacità di appropriazione, indispensabile per la qualifica maschile, per l’acquisizione del prestigio maschile, oggi si ottiene solamente con la violenza», spiega ancora una volta.
«La violenza emerge quando i metodi non violenti non esistono più per l’appropriazione, che è la struttura e il linguaggio in un mondo di proprietari, com’è il mondo di oggi, quando non si ottiene il controllo territoriale e dei corpi attraverso altri tipi di potere, come quello economico, politico, morale o intellettuale… e secondo alcuni psicoanalisti che ho ascoltato, anche il potere sessuale è gravemente compromesso anche nei più giovani», racconta a PáginaI12. La sua produzione accademica comprende numerosi libri, l’ultimo, Contra-pedagogías de la crueldad (Buenos Aires, Prometheus, 2018).
– Perché dice che la Giustizia ha difficoltà a processare la violenza machista?
– Come dico sempre, è evidente che agli occhi della pratica del Diritto il crimine di genere è un “crimine minore”, e questa idea è già un concetto nel mio vocabolario, una categoria critica che è indispensabile far arrivare agli operatori del Diritto. Trattano la sofferenza delle donne come un “crimine minore”, e lo vediamo. Dobbiamo avvisarli, far capire loro. Racconterò un aneddoto personale. Correva l’anno 1993 quando mi presentai davanti al direttore del Penitenziario di Brasilia per concordare con lui come avrei realizzato, insieme a un gruppo di studenti, una lunga serie di interviste a detenuti già condannati per stupro. Si trattava di un progetto richiesto dal Segretario della Pubblica Sicurezza al rettore dell’Università di Brasilia. Durante questa prima visita in carcere, il direttore mi offrì un caffè mentre facevamo conversazione. Nel suo ufficio un uomo di mezz’età scriveva a macchina. Il direttore lo chiama per servire il caffè. Quando uscimmo, il direttore abbasso la voce e mi disse: “È un detenuto. Però ci da una mano qui nella Direzione. È un medico. Quello che gli è successo potrebbe capitare a chiunque. Ha ucciso la moglie”. Questa frase è un assaggio di quello che mi ha sconvolto fino ad ora e che, non a caso, ci interessa ora. Non si pensi che si tratta di un caso eccezionale, questa scena si è ripetuta molti anni dopo nel Carcere di Campana, provincia di Buenos Aires. L’ho visitato nel 2007 con il professor Rodolfo Brardinelli, dell’Universidad de Quilmes, mentre stavamo sviluppando il progetto “Habla preso. El derecho umano a la palabra en la cárcel”1, ispirato al progetto omonimo che realizzai a Brasilia dopo che la ricerca con gli stupratori mi mostrò la totale e assoluta mancanza di promozione della pratica riflessiva e responsabile all’interno dell’istituzione penale. Lì, nella mensa in cui venimmo invitati a pranzo, arrivò un uomo anziano a portare i piatti. Di nuovo, come nella scena precedente, quando si allontanò, il direttore ci spiegò a voce bassa, per delicatezza verso il detenuto: “È molto anziano e ci aiuta in cucina. Non è pericoloso. È dentro solo perché ha chiamato due ragazzine di strade a vedere dei porno con lui”. Non so per il resto dei presenti, però il disgusto per la mano che mi serviva il pranzo mi impedì di mangiare.
– Davvero sconvolgenti queste due scene. Perché le due rispettive direzioni penitenziarie hanno trovato inoffensivi questi due detenuti?
– Perché un aggressore di genere non metterà a rischio la proprietà o la vita dei proprietari. Nel senso, non si tratta di un delinquente pericoloso per i beni e per i loro proprietari. In questo senso, avvocati e direttori di carceri vedono il crimine di genere come un crimine di un altro tipo, lo classificano in un altro modo. Da una parte, nel loro foro interno, non riescono a concepirlo come un crimine “contro le persone” e non costruiscono l’immagine del suo autore come una figura minacciosa per la società. In altre parole, non lo percepiscono come una figura che minaccia beni giuridici di valore universale e di interesse generale. La figura maschile incarna e iconizza il bene giuridico di valore universale e di interesse generale. La figura femminile è letta dal senso comune come bene giuridico di valore particolare, di interesse privato.
– Seguendo il suo ragionamento… È possibile che per questo motivo né la società in generale né gli operatori del Diritto riescano a metabolizzarlo o posizionarlo dove dovrebbe essere classificato, come un crimine nella pienezza di questo concetto?
– Certo. Ne consegue che la vittima di questo delitto, la vittima sessuale, in generale una vittima con il corpo di una donna, anche se non sempre, non sia agli occhi del pubblico una persona piena, non ha lo status di un cittadino a pieno titolo, di un soggetto pieno. Questo effetto, a sua volta, si accentua come conseguenza della struttura binaria dell’ordine patriarcale moderno, ordine monopolistico, unitario. Il potere patriarcale moderno è binario, e la sua struttura è diversa dalla struttura duale dell’ordine comunale. Nel passaggio alla modernità, lo spazio domestico comunale, che non era né intimo né privato, viene privatizzato. In questo modo, l’ambito che, in un immaginario arcaico, è lo spazio vitale delle donne, il loro spazio di compiti e socialità, esperisce una brusca caduta di prestigio e potere. Si trasforma nell’altro dell’agora della politica e del Diritto, residuale e depoliticizzato. Questo spiega la situazione spoliticizzata, privata, residuale, marginale della vita delle donne nella prospettiva statale e, di conseguenza, anche nella prospettiva dei pubblici ministeri e dei giudici, con alcune eccezioni.
– Vuol dire, insomma, che le nostre vite nella prospettiva statale storicamente non sono state considerate, in quanto non pertenevano all’ordine pubblico…
– Esatto. A partire dalla privatizzazione dello spazio domestico come intimo ed espropriato della sua politicità propria, che nel mondo comunale aveva e ancora ha, tutto quello che succede alle donne, dall’aggressione sessuale al femminicidio, è catturato dall’intimità e riferito alla libido sessuale. È per questo motivo che la denuncia delle donne non è ascoltata dallo Stato: perché noi donne, a meno che non facciamo un grande sforzo di imitazione, non apparteniamo all’ordine pubblico, abitiamo un altro spazio, specialmente quando appariamo nel ruolo della vittima – “non è stato aggredito un cittadino”, “non è stato assassinato un cittadino” -, l’aggressore non rappresenta un pericolo al bene giuridico di interesse universale. Insomma, questa è la struttura che sta dietro al “crimine minore”.
– Si presume, in ogni caso, che gli operatori di giustizia dovrebbero avere una formazione e una competenza che permetta loro di vedere questi crimini con un altro sguardo…
– Purtroppo non ce l’hanno. Ciò che mi spaventa, soprattutto, è l’evidente indistinzione tra la mentalità di un giudice, di un pubblico ministero e la mentalità del senso comune. Il senso comune degli operatori del diritto non è diverso dal senso comune di qualsiasi figlio di un vicino di casa. Non c’è, come invece in altre professioni, un “senso comune giuridico”, vale a dire, alimentato dal sapere giuridico e, per questo, sfortunatamente, giudici e pubblici ministeri agiscono come “operatori del costume” e non del diritto, quando si tratta di crimini di genere. Parlare di violenza di genere con un giudice – e includo qui i più prestigiosi che abbiamo avuto – è lo stesso che parlarne con un impiegato pubblico, un fisico, un panettiere, Gli operatori del Diritto devono capire che le aggressioni sessuali non sono una questione di libido ma bensì di potere, di controllo, di mandato di maschilità che domina la società e le istituzioni, che è un mandato di potenza e crudeltà, di insensibilità, di formazione segnata dalla mancanza di empatia. Una formazione la cui scuola è il corpo della donna.
– Lei sottolinea che la dottrina del garantismo giuridico non ha capito che le garanzie nel caso della violenza di genere devono operare in una direzione opposta. A che cosa si riferisce?
– La giustizia garantista è stata guidata da un’idea di equità: garantire la giustizia a coloro che si trovano sul lato negativo della cittadinanza, a chi è disempowered, ai penalizzati dalla storia. Ma non procede nello stesso modo quando si tratta di genere. In questo caso continuano a pensare nei termini di cittadinanza generale. Di una cittadinanza che, in realtà, non esiste. Dietro alla giustizia garantista e all’ideale non finalizzato alla punizione, si trova, senza essere nominata, la prospettiva della discriminazione positiva. Se non esistesse nel suo fulcro alcuna nozione di vulnerabilità del detenuto, condannato, non ci sarebbe motivo di alzare le bandiere delle garanzie, in quanto sarebbe, in realtà, ridondante. Chiunque sia imprigionato per reati contro la proprietà e contro la vita di persone che possiedono proprietà e dignità, o, in molti casi, proprietà come dignità, è, come molti di noi hanno già dimostrato, povero e non bianco: soggetti subalterni e diseredati. Il garantismo sui crimini di genere dovrebbe procedere nella direzione opposta, perché la controcorrente, la vera discriminazione positiva, è dall’altra parte del crimine: il potente è l’autore, che precisamente delinque per riprodurre, dimostrare e spettacolizzarsi nella posizione di dominio che la maschilità gli conferisce agli occhi degli altri uomini e della società in generale. Il crimine di genere è un crimine di eccesso di potere e la vulnerabilità si trova dalla parte della vittima, la quale è colei che necessita della discriminazione positiva, che è colei che necessita dell’azione affermativa, perché è quella che non ha ancora acquisito lo status di piena cittadinanza. E le prove sono una grande quantità di sentenze che non registrano o non garantiscono la piena dignità umana per le donne.
(traduzione di Clara Mogno)
Questo testo è stato pubblicato in castellano per PáginaI12 il 6 gennaio 2019.
ndr: “Parla il detenuto. Il diritto umano alla parola in carcere” ↩