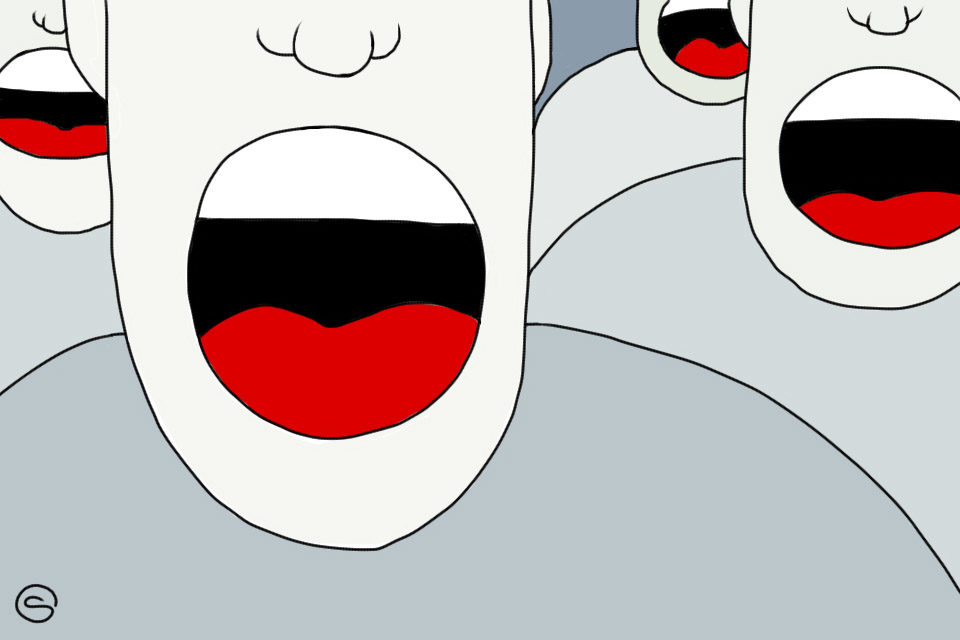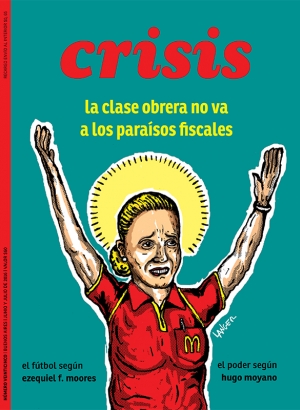di GABRIELE PALUMBO.
The problem of the color-line
Come una spina nel fianco della cultura Americana, la « questione razziale » riemerge ciclicamente ad animare l’opinione pubblica ed il dibattito politico statunitense. Ed ogni ritorno, ogni nuova ondata, riporta in luce tensioni del sottosuolo che scuotono la struttura stessa della società dove problematiche sedimentate e complesse si presentano come nuove forme scivolose di crisi. The problem of the color-line, si rivela il segnalibro di un altro capitolo di denuncia dei confini della libertà e della democrazia americana. È interessante evidenziare come, nella discussione politica, posizioni attuali ricordino pieghe e caratteristiche già viste pur con nuove, importanti sfumature. Questo intreccio di novità e passato struttura tanto la forma della protesta quanto quella della reazione, svelando, sul tema dei diritti civili, il lavoro di una coscienza collettiva americana irrisolta. Il tema della libertà e dell’uguaglianza, cosi come la definizione dello « spirito americano », rappresentano insomma un campo di battaglia ancora aperto. In questa battaglia, passato e presente si intrecciano in modi spesso contraddittori. Basterebbe citare lo slogan di Donald Trump – “Make America great again” – dove promesse future e retorica del passato si fondono banalmente in uno stadio quasi primitivo. Ritornare a prima di cosa? Prima di un presidente nero? Prima delle marce per i diritti civili?
Se volessimo semplificare, ai due versanti del fiume in piena, agli estremi opposti di questa crisi identitaria che sembra attraversare il paese, si trovano due schieramenti che hanno in comune un forte malcontento per lo stato attuale della società. Da un lato della barricata, gli Stati Uniti sono considerati come una nazione inaccettabilmente debole, attraversata da tanti, troppi, « multi »: culturale, razziale, religioso. Per questa parte della società, l’America si è trasformata in una foresta indecifrabile di minoranze e molteplicità dove « lo spirito conservatore », con il braccio armato, si perde confuso e frustrato tra formule politically correct, divieti « innaturali » ed incertezze postmoderne. Dall’altra parte, sul fronte opposto, riemerge invece la corrente della denuncia progressista, della spinta riformatrice, che chiede di completare un percorso di uguaglianza e di libertà percepito come tradito o, più ottimisticamente, sospeso. Nel doppio sforzo di smascherare l’incompiutezza ma anche di tracciare nuovi obiettivi di giustizia, quest’ultima corrente appare riprendere una bandiera – magari lasciata al suolo negli anni ’60 o persa nei ’70 – per riuscire a fare altri metri, forse pochi passi, prima di essere di nuovo colpito.
#BlackLivesMatter
Stavolta a raccogliere la bandiera sono state tre donne, Alicia Garza, Patrisse Cullors, e Opal Tometi, che nel 2013, indignate dagli eventi di cronaca, hanno creato l’hashtag #BlackLivesMatter. Secondo le parole di Alicia Garza, lo slogan è nato come un «call to action for Black people» dopo che un vigilante privato, George Zimmerman, venne considerato dai giudici come “non responsabile” dell’uccisione del teenager Trayvon Martin. Partita dunque dai contenitori moderni dei social networks, Twitter in primis, la protesta da lì a poco si è riversata nelle strade. Prima a Ferguson, nel Missouri e poi in tutto il paese, richiamando apertamente eventi del passato, come quei Freedom Riders che nel 1961 proprio da Ferguson avevano sfidato la dottrina del «separate but equal». In poco meno di tre anni, il Black Lives Matter ha attraversato gli USA, disegnando una sorta di simbolica via crucis segnata da sempre nuovi episodi di violenza impunita da parte di polizia e vigilantes. Pur rimanendo decentrato e poco definito, Black Lives Matter ha ispirato manifestazioni e dibattiti pubblici, come anche energiche proteste urbane culminate in scontri con le forze dell’ordine. Ma è nel web che il movimento ha continuato ad avere il proprio principale veicolo di diffusione. Sotto questo slogan è andato crescendo un flusso di video-denuncia, testimonianze dirette, immagini riprese da telefoni cellulari, webcam o videocamere pubbliche, che ha finito per attirare l’attenzione dei grandi network di informazione americani. L’esecuzione a freddo di Walter Scott (4 Aprile del 2015), le immagini dal Texas di un poliziotto fuori controllo ad una festa di adolescenti (5 Giugno del 2015), il terribile urlo « I can’t breath » di Eric Garner prima di morire soffocato nella stretta dei poliziotti (17 Luglio 2014), sono tra i tanti esempi di video virali che hanno riportato la questione razziale in primo piano. A tal proposito come ha dichiarato Angela Davis, prigioniera politica durante il periodo delle Black Panthers, «Black Lives Matter è il movimento di cui abbiamo bisogno adesso per ricordare l’attualità di un razzismo che molti di noi avevano consegnato al dimenticatoio della storia ». Eppure, malgrado la forza del movimento, ridiscutere della questione razziale in America si rivela un compito assai arduo, ostacolato da nuove e vecchie forme di resistenza ed impermeabilità, che stanno condizionando sotterraneamente la campagna elettorale per le presidenziali. Proviamo allora ad attraversare questa fenomenologia reazionaria.
Black President or Black Leader.
Il primo argomento utilizzato contro le denunce di BLM è il seguente: che senso ha parlare di razzismo e discriminazione sotto la presidenza di Barack Obama? Evidentemente, minimizzare la portata storica e simbolica dell’elezione di Barack Obama sarebbe stupido. Considerando che solo 50 anni fa, il diritto elettorale dei neri era di fatto negato in molti stati della cosiddetta Cotton Belt, o ricordando il famoso discorso « The Ballot or the Bullet » tenuto da Malcom X nel 1964, vedere nel 2008 il nuovo inquilino della Casa Bianca ha avuto un valore catartico per un’intera nazione: un successo storico per l’affermazione del principio di eguaglianza razziale in un paese in cui Obama stesso si affrettò a dichiarare che «tutto è possibile ed i sogni diventano realtà». Proprio dopo aver attraversato un picco inaudito d’impopolarità interna ed internazionale sotto la guida di George Bush, l’America ritornava ad identificarsi con il cambiamento, spinta dall’entusiasmo per la nuova presidenza. Nello stesso tempo però, l’elezione del 2008 ha confuso due livelli ben diversi: quello della rappresentanza simbolica e quello della rappresentanza di interessi. Si potrebbe, per esempio, usare il paragone storico di Margareth Thatcher, dove questa divergenza di livelli è stata, per certi versi, ancora più evidente. Nel 1979 in Inghilterra, una donna era eletta per la prima volta alla guida di una potenza occidentale. Ma l’elezione della lady di ferro non ha portato alcun beneficio al movimento femminista britannico o tanto meno europeo. E come ha giustamente ricordato la giornalista Nina Lakhani, nel suo articolo «How much did The Iron Lady do for the UK’s women?», neppure la base elettorale, o la base politico-culturale, a sostegno della Thatcher aveva alcuna intenzione di identificarsi con il femminismo. Il problema è che eleggere un presidente nero, allo stesso modo, è ben diverso da eleggere un Black Leader. Ed è sostanzialmente questa distanza fra piano simbolico e risultati politici che scardina il giudizio sull’ «era Obama». Sebbene il presidente, soprattutto nel secondo mandato, abbia provato ad avanzare alcune riforme o proposte come il Fair Sentencing Act, è stato evidente sin dagli esordi che, per l’amministrazione, qualsiasi riferimento complessivo alle problematiche razziali fosse un passo verso un campo minato. L’accusa di giocare « the race card » è stata costante e lo stesso Obama si è mosso molto prudentemente in direzione di una politica « race-neutral » piuttosto che « race-conscious ». Segnare il passaggio storico verso l’eguaglianza e rappresentare finalmente una società senza razzismo, sono diventati la sottotraccia di un indirizzo politico quasi ecumenico che, affrettandosi a proclamare il progresso, ha inevitabilmente nascosto molta polvere sotto il tappetto. Di fronte a tutto ciò, Black Lives Matter suona come una nota stonata, che ricorda piuttosto come l’eguaglianza non si misura nei simboli ma negli interessi, nelle possibilità e nelle condizioni materiali di vita.
The Cool War
In effetti, oltre al successo di Obama, la stessa linea di « neutralità razziale » emerge ormai in una miriade di personaggi televisivi, star hollywoodiane, stelle sportive o star della musica spesso usati come esempi di quanto la « blackness » abbia ormai trovato posto nella cultura mainstream fino ad essere accettata ed esaltata. Dal “Black is Beautiful”, slogan della grande rivoluzione culturale portata avanti negli anni sessanta, si è passati al “Black is cool”. La battaglia estetica, che per intellettuali come Steve Biko, era parte integrante di una battaglia politica per rompere il dominio razziale, sembra essere stata vinta. Un’intera generazione di artisti che costituivano una vera e propria avanguardia impegnata a ridiscutere la percezione del sé e capovolgere le maschere identitarie del costume e del mercato, potrebbero ammirare il cambiamento nell’attuale multicolorità di massa. Tuttavia l’accettazione e l’assimilazione della « cultura nera » è stata, e continua ad essere, ambigua e contraddittoria. Da una parte è evidente, come ha scritto Dexter Thomas, insegnante alla Cornell Unversity, che i neri hanno vinto “the cool war”. Musica, stile, arte e cultura nera sono oggi prodotti di successo riconosciuti. Nel mercato globalizzato la minoranza si traduce in esclusività e la particolarità sembra vendersi benissimo. Ma il mercato mastica, digerisce e sputa quello che considera non opportuno. Seguendo il concetto di vendibilità, che è già trasformazione e selezione, la Blackness è ricondotta ad articolo commerciale e come tale smussata e raggirata nei suoi aspetti meno comodi. Ma quando l’incantamento commerciale si spezza, le contraddizioni riemergono.
Basti guardare alla tempesta che ha di recente attraversato la NFL con il caso di Colin Kaepernick. Come è noto, il quarterback di San Francisco ha deciso di inginocchiarsi durante l’inno nazionale (che viene ripetuto negli Stati Uniti, prima di ogni competizione sportiva, locale, statale, nazionale che sia), in segno di solidarietà al movimento del Black Lives Matter. Un semplice gesto di dissenso che ha sollevato una marea di polemiche. Cosa vuole questo ricco giocatore ? Perché offende la bandiera americana ? Perché portare nello sport la politica ? Kaepernick e gli atleti che hanno deciso di emularlo, hanno spiegato a più riprese che il loro gesto non rappresentava un insulto al paese, né aveva l’obiettivo di criticare i riti dell’NFL: si trattava semmai di « sensibilizzazione politica » al problema dell’abuso di potere delle forze dell’ordine americane. Eppure, questo atteggiamento – chiaro e per molti versi difensivo – non è bastato a calmare o ridurre l’ondata di critiche ed insulti dei tanti fans disturbati nel veder accenni di protesta sociale dentro l’NFL. Un disturbo che ha tutti i sintomi dell’intolleranza.
Eppure pochi mesi prima, proprio durante il SuperBowl, – che è di gran lunga l’evento sportivo più seguito negli USA – Beyoncé si confermava vera star della serata con il suo strabiliante spettacolo « Formation ». Circa 170 milioni di spettatori hanno ammirato la grande popstar, al seguito di un gigantesco gruppo di ballerini, esibirsi in una performance che richiamava apertamente, con lattice nero e pugni alzati, le Black Panthers. Il risultato ? Un successo nazionale contestato da pochissimi spettatori. Ci si potrebbe chiedere allora cosa distingue questi due eventi mediatici. Dalla loro differenza, in effetti, emerge l’irrisolto cortocircuito di una memoria storica che pur essendo accettata come prodotto di marketing, viene sistematicamente negata in quanto strumento di lotta. L’America post-Obama dovrà allora affrontare il paradosso per il quale la « Black coolness » diventa una gabbia che snatura intenzioni e occlude dissensi. Le stesse celebrità afro-americane, si pensi a figure quali Le Bron James, Carmelo Anthony, Oprah Winfrey o persino personaggi un tempo refrattari al coinvolgimento politico come Michael Jordan, anche se animati da un sincero intento di denuncia, una volta promossi nell’Olimpo dello star system, sembrano soffrire, con diverse pendenze, della « sindrome di Obama ». Come poter essere critici in una società che ti ha elevato fino al successo? Non si diventa la prova vivente della sua giustezza? Proprio perché storie di « successo », quelle individuali rientrano nell’ideologia piatta della società dei sogni che si realizzano, dell’eccezionalismo americano. Le vittorie dei singoli rafforzano l’idea di una neutralità razziale collettiva che rischia di non volersi più mettere in gioco. Le fortunate o meritate affermazioni individuali degli afro-americani poste in opposizione alle domande di cambiamento diventano favole reazionarie che oltre a minimizzare implicitamente le disparità, impediscono il dissenso. Eppure assumendo piuttosto proprio il diritto alla protesta di gruppo, alla critica e alla lotta collettiva, come metro affidabile di un progresso sociale e di un vero superamento delle discriminazioni, la situazione attuale si rivela capovolta. Mezzo secolo fa due atleti ostentavano il pugno chiuso con al collo due medaglie olimpiche mentre Mohamed Ali dichiarava di combattere la « dominazione degli schiavisti bianchi contro tutte le popolazioni di colore del mondo ». Oggi Kaepernick, con un gesto ben più innocuo, suscita scandalo e la battaglia di BLM per l’acquisizione di garanzie collettive incontra fortissime resistenze. In questa società « race-neutral » che fine ha fatto la libertà di protesta? Quanti limiti sono posti oggi alla critica ed ai diritti collettivi?
“Explain to me”
Un terzo dispositivo retorico, opposto alle denunce di BLM, viene praticato da coloro che, pur ammettendo una differenza “sociale” fra bianchi e neri, pur riconoscendo la scarsa qualità ed aspettativa di vita delle minoranze americane, restituisce al mittente colpe e responsabilità. È il caso ad esempio del giornalista Ben Shapiro, che proprio in un confronto con alcuni esponenti del Black Lives Matter lo scorso maggio, ha riassunto una delle critiche più insidiose e più comuni al movimento : le ingiustizie ci sono ma è ora che le minoranze, come quella afro-americana, piuttosto che ricadere in « narrative vittimistiche » si assumano la propria responsabilità, dimostrino di ripudiare violenza e ignoranza, di voler migliorare. « You explain to me why black kids aren’t graduating high school? Explain that one to me. Explain to me why black kids are shooting each other in rates significantly higher than whites are shooting each other? ». Queste sono le domande che Shapiro retoricamente sollevava per confermare la necessità di un cambiamento interno alla comunità di minoranza. Tale assegnazione di responsabilità rispolvera lontane ed inesorabili reminiscenze coloniali. Ancora una volta riferimenti al passato: in particolare, quel giudizio di inadeguatezza o inferiorità, rilanciato in chiave di mancata predisposizione al progresso civile, continua ad essere un utile strumento per mantenere inviolati i rapporti di forza e chiudere in fretta ulteriori analisi. Eppure, per rispondere alle domande “concrete” di Shapiro, basterebbero pochi dati. Il Centro Nazionale di Statistiche sull’Educazione (NCES), ha infatti di recente messo in evidenza come la differente “economic starting line” renda molto difficile concludere la scuola per i ragazzi neri. Sostenere il costo dei college, ottenere o ripagare i debiti bancari – che attualmente molti studenti devono assumere prima di intraprendere un percorso universitario – sono ostacoli duri che rendono l’educazione, negli USA di oggi, un privilegio più che un ascensore sociale. Una situazione aggravata da diffuse pratiche di discriminazione razziale presenti ancora oggi nei processi di assunzione per lavori qualificati. Addurre il benessere di una comunità o di un gruppo, al livello di educazione raggiunto, significa, di fatto, invertire i termini del problema. Come ha scritto Darrick Hamilton, osservare un’associazione fra livello alto di educazione e benessere, deducendone che l’educazione è causa del benessere rischia di essere come costatare la presenza simultanea di ombrello e pioggia, per concludere che è l’ombrello ad avere determinato la pioggia. E’ evidente dunque che i rapporti lineari di causa ed effetto sono ad uso, per Shapiro come per altri, di assoluzioni o condanne sommarie ed inutili a cui bisognerebbe piuttosto rispondere con la ricerca, partendo dalla complessità dell’intreccio razzismo-cultura-classe in una prospettiva prima di tutto storica.
13th
Un prezioso tentativo di tracciare un quadro storico dell’attuale crisi razziale, è stato recentemente realizzato con il documentario di Ava DuVernay, 13th. Frutto di una collaborazione collettiva cui hanno partecipato oltre ad Angela Davis, molti studiosi come Henry Louis Gates e Jelani Cobb, questo documentario descrive, con puntuali riferimenti storici, le tappe di una cultura della criminalizzazione delle minoranze in America. Una prospettiva storica generale che partendo dal periodo post schiavista, arriva fino alla situazione attuale, soffermandosi con più attenzione nel periodo “law and order” della presidenza di Nixon. Da qui in poi, secondo gli autori, il binomio criminalità-repressione si è consolidato come approccio guida per le politiche contro le tensioni sociali riducendo, nella pratica, ogni intervento alla carcerazione. Il risultato è stato il passaggio da duecentomila americani in carcere nel 1970 a due milioni e mezzo nel 2015, circa il 25% della popolazione carceraria mondiale, di cui il 37% sono afro-americani. Accanto a questa spaventosa carcerazione di massa, si è verificata l’espansione di un vero e proprio stato poliziesco, in cui l’agente di polizia, armato, è spesso l’unica risposta ai problemi sociali più disparati. Questa ratio ha caratterizzato gli anni di Ronald Reagan, con la “guerra alla droga” ed il via libera alla privatizzazione del sistema carcerario ma è stata sposata ed esaltata anche dalla linea democratica con l’amministrazione di Bill Clinton. Nel 1994, su proposta dell’allora senatore Joe Biden, Clinton ha firmato il Violent Crime Control and Law Enforcement Act: un massiccio dispositivo giuridico che, fra gli altri controversi provvedimenti, eliminava il diritto all’educazione universitaria per i detenuti ed instituiva 100.000 nuovi posti in polizia. Cultura poliziesca, legalizzazione delle armi, scarse politiche per il rinserimento sociale dei detenuti o per la prevenzione al crimine, definiscono un quadro storico e sociale complesso senza il quale non è possibile capire la specificità del caso americano, primo paese occidentale per la mortalità per arma da fuoco. In questo contesto, gli episodi denunciati dal Black Lives Matter, appaiono in linea con quello che viene definito “razzismo istituzionalizzato”. Una cultura nella quale il confine imprecisato fra stereotipi razziali, interventismo poliziesco ed impunità, si traduce in “incidenti mortali” per gli afro-americani.
A broken system
Probabilmente il maggior successo politico del Black Lives Matter, è stato sollecitare numerose inchieste condotte dal dipartimento di giustizia per analizzare il comportamento dei vari distretti di polizia. Inchieste che stanno svelando il razzismo strutturale del sistema. In un rapporto pubblicato il 10 Agosto del 2016, ad esempio, malgrado l’ostracismo della polizia nel registrare i dati o conservarli, il dipartimento di giustizia di Baltimora dichiarava più di 10.000 arresti ingiustificati, 300.000 perquisizioni sommarie ed altre impressionanti cifre concludendo che «racially disparate impact is present at every stage of BPD’s enforcement actions, from the initial decision to stop individuals on Baltimore streets to searches, arrests, and uses of force». Com’è evidente non si tratta di poche «mele marce», ma del manifestarsi di un razzismo solido e stratificato dentro il corpo di polizia americano. Una situazione che dimostra il completo fallimento di anni di provvedimenti politici sul controllo delle armi, sul degrado urbano, che, insieme ad anni di militarizzazione interna, hanno portato di fatto ad un scontro diretto, senza alcuna mediazione, fra questo tipo di polizia e la comunità afro-americana. Il problema della razza dunque, lungi dall’essere noiosamente retorico o superato, rimane piuttosto attuale nell’America post Obama. Durante il secondo dibattito delle primarie democratiche, sfidata da un candidato ben più di sinistra come Bernie Sanders, Hillary Clinton ha dovuto prendere esplicitamente le distanze dal provvedimento di Bill Clinton del 1994. Pochi mesi dopo, da candidato democratico alla presidenza, lei stessa ha ufficialmente etichettato come «broken» l’attuale sistema poliziesco e «mass incarceration» la situazione carceraria. Il programma elettorale di Hillary Clinton contiene un’incoraggiante riforma della giustizia sostenuta da tre capisaldi : cambiare il rapporto comunità-polizia con transparenza, meno armi e più formazione; riformare il sistema penitenziario abolendo la privatizzazione, alleviando le pene e dando priorità a metodi alternativi alla detenzione; promuovere progetti di reinserimento per ex detenuti. E’ evidente come Black Lives Matter abbia inspirato tali punti e come la dialettica elettorale di Bernie Sanders abbia contribuito ad accogliere molte richieste del movimento nella piattaforma del partito democratico. Ma, nella prevedibile distensione post elettorale, quando le promesse tendono a cadere, occorrerà senz’altro mantenere la tensione e pressione politica di movimenti come Black Lives Matter per evitare quei vicoli ciechi a cui tanto la politica “race-neutral” quanto l’esaltanzione “cool” della blackness hanno condotto.