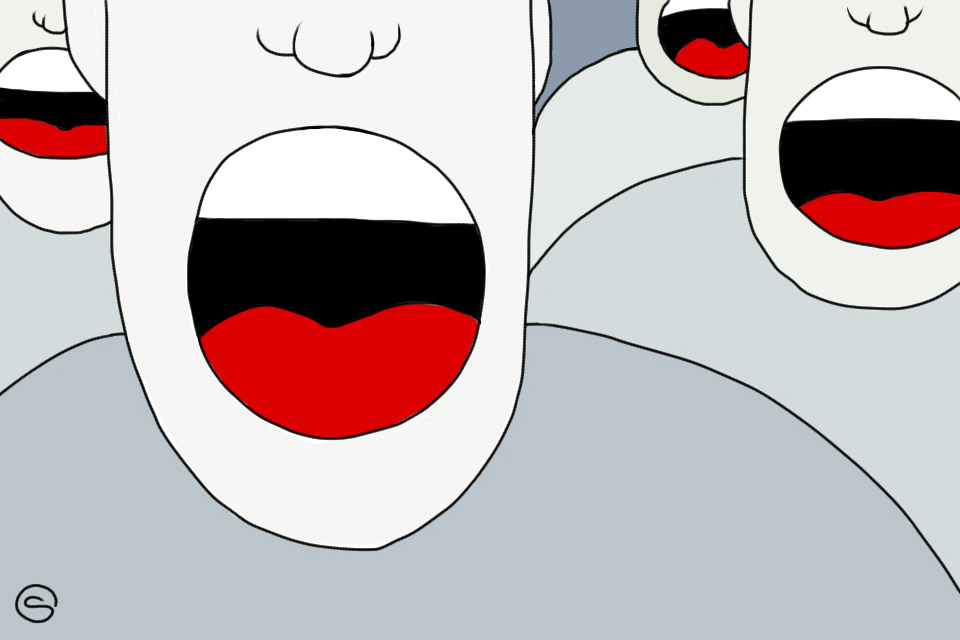di GIROLAMO DE MICHELE.
La fine del 2013 ha lasciato all’anno nuovo, tra le tante dubbie eredità, un “Appello per le scienze umane” scritto da Asor Rosa, Esposito e Galli della Loggia1: un Appello a suo modo esemplare dello stato di un’Accademia che tiene i suoi anni al guinzaglio.
Volendolo sintetizzare, questo appello denuncia «la crisi verticale che investe l’intero retaggio culturale italiano, di cui la tradizione umanistica è parte fondante», lo stato di abbandono dell’istruzione scolastica e la deriva tecnicistica dell’insegnamento, esemplificata nelle procedure di valutazione quantitativa; la conseguenza più grave del declino delle humaniora rispetto agli studi tecnico-economici sarebbe la «crisi del “politico” che è oggi uno dei problemi più urgenti che abbiamo di fronte», «perché in Italia il politico è stato costituito alle sue radici proprio da quel sapere» umanistico.
Se le parole hanno un senso e il linguaggio non è mai neutrale, qualcosa vorrà dire se l’incipit di questo Appello è una excusatio non petita introdotta da una litote – «Forse non è inutile partire da una considerazione che riguarda gli autori di questo testo» –, figura retorica che Pasolini considerava propria di quei “borghesi bocciofili in doppio petto” che erano i dirigenti delle sezioni del PCI nel ’68. Perché hanno un bel respingere l’accusa «di una qualche “larga intesa”, di una improvvisa cancellazione di confini»: tutto, in questo testo, dice il contrario. Si prenda la sbrigativa affermazione sull’assenza di una «qualsiasi discussione pubblica appena impegnativa sulle forme, i contenuti e i fini che l’istruzione stessa dovrebbe avere»: dove hanno vissuto, questi signori, per non accorgersi, in questi anni, della discussione, pubblica e conflittuale, all’interno e all’esterno del mondo della scuola, dei movimenti di protesta e di rivolta in difesa del diritto al futuro, dell’ampia letteratura prodotta “dal basso” (ma anche dall’Accademia)2?
In realtà di uno dei tre sappiamo con certezza dove viveva (e tutt’ora vive): all’interno di quella lobby reazionaria che ha cercato di esercitare un’egemonia di destra sul dibattito sull’istruzione. Parlo di Ernesto Galli della Loggia, in buona compagnia in questi anni sulle pagine del “Corriere della Sera” con Panebianco, Sartori, Giavazzi, Ichino (Andrea), Zingales: con interventi che hanno spesso dato la caratura della preparazione e della competenza dell’editorialista, che ha discettato di scuola senza saperne un’acca3 – come si sul dire, “dimmi con chi vai, e ti dirò se vengo”.
Basti pensare a quale idea di apprendimento, ma anche di mente umana, sottende questo appello: la scuola contenutistica della “testa ben piena” (purché di contenuti espressi in lingua italiana) piuttosto che della “testa ben fatta”. Una didattica che ritorna all’epoca pre-Dewey, alla quale sembrano risalire le cognizioni epistemologiche dei Tre. Davvero davanti alla conflittualità, ma anche alla metamorfosi delle soggettività, che si dà in una società plurilinguistica, i cui processi mentali corrispondono ai processi socio-economici che determinano lo spostamento, quando non lo sradicamento, la migrazione e la con-fusione dell’umanità, i Tre credono centrale la difesa dell’omolinguismo nazionale4? Sarà che hanno nella testa un maledetto muro…
La crisi dell’istruzione viene ricondotta dai tre autori non allo scarto tra le mutazioni sociali, economiche e tecnologiche dell’ultimo quarantennnio; non all’attacco diretto al diritto all’istruzione in favore delle lobby economiche dell’istruzione privata e dell’e-learning; non alla reazione avversa al contributo dato dalla diffusione della conoscenza e del sapere critico alla crisi dello Stato-piano; non all’ingresso della dimensione di crisi permanente della finanziarizzazione anche nelle istituzioni scolastiche, e nemmeno all’introduzione di strumenti di governance disciplinare nella scuola – nulla di tutto ciò. La crisi dell’istruzione è ricondotta all’attacco dei saperi scientifici – anzi: anglo-scientifici: «Le discipline scientifiche, infatti, le matematiche o l’ingegneria elettronica, la biologia molecolare o la geologia, sono dovunque le medesime, dovunque eguali a se stesse, e non a caso tendono sempre di più a esprimersi dovunque in una medesima lingua: l’inglese. Che però si dà il caso che non sia la nostra lingua»5.
 Allungando come il chewing-gum una distinzione di Isaiah Berlin6 tra cultura umanistica e cultura scientifica, i Tre affermano che «Mettere al bando nell’apparato scolastico il sapere umanistico per privilegiare il sapere fondato sulle scienze naturali, significa mettere al bando interi territori e dimensioni dello spirito e della conoscenza umani. […] Significa squalificare “lo specifico e l’unico di contro all’iterativo e all’universale, il concreto di contro all’astratto, il movimento perpetuo di contro alla quiete, l’interiore di contro all’esteriore, la qualità di contro alla quantità, ciò che è culturalmente condizionato di contro ai principi atemporali, la lotta mentale e l’autotrasformazione come una condizione permanente dell’uomo di contro alla possibilità (e desiderabilità) della pace, dell’ordine, di un’armonia finale e delle soddisfazioni di tutti i desideri umani razionali”».
Allungando come il chewing-gum una distinzione di Isaiah Berlin6 tra cultura umanistica e cultura scientifica, i Tre affermano che «Mettere al bando nell’apparato scolastico il sapere umanistico per privilegiare il sapere fondato sulle scienze naturali, significa mettere al bando interi territori e dimensioni dello spirito e della conoscenza umani. […] Significa squalificare “lo specifico e l’unico di contro all’iterativo e all’universale, il concreto di contro all’astratto, il movimento perpetuo di contro alla quiete, l’interiore di contro all’esteriore, la qualità di contro alla quantità, ciò che è culturalmente condizionato di contro ai principi atemporali, la lotta mentale e l’autotrasformazione come una condizione permanente dell’uomo di contro alla possibilità (e desiderabilità) della pace, dell’ordine, di un’armonia finale e delle soddisfazioni di tutti i desideri umani razionali”».
C’è da rimanere sbalorditi davanti a questa caricaturale rappresentazione dei saperi “scientifici”, della quale, scrostando la muffa e la polvere che la ricoprono, si scorgono barlumi della polemica dell’intellettualità guglielmina Kultur Vs Zivilisation, un attacco all’inglese come lingua tecnocratica che sa di wagneriano. Sembra che nessuno abbia spiegato a questi fini umanisti che, per limitarci al contributo della fisica alla concezione attuale del mondo, le “leggi scientifiche” cosiddette “esatte” non esprimono relazioni tra oggetti esterni; che gli atomi non sono cose, ma tendenze (con le parole di Heisenberg: “Atome keine Teilchen sind, sie sind nur Tendenzen“) e possibilità; né quale sia il ruolo dell’osservatore all’interno del sistema. O quale rivoluzione epistemologica rappresentino le neuroscienze, al cui iniziale sviluppo nel nostro paese contribuì tra gli altri Camillo Golgi, e il cui lustro è stato rinnovato da Rita Levi Montalcini; quale sia il ruolo svolto dall’astrofisica, per la quale Margherita Hack qualcosa ha pur contato, per la comprensione del posto dell’uomo nel cosmo; delle indagini multidisciplinari tra generica, linguistica e biologia sulla natura del linguaggio, delle quali Luca Cavalli-Sforza è stato un protagonista di rilievo. Ma di Golgi, Hack, Levi Montalcini e Cavalli-Sforza, in questa chiamata alla riscoperta dell’italianità, non c’è menzione: e del resto, nell’Appello ci sono De Sanctis, Croce e Gentile, e persino la Controriforma, ma non Galileo. Il “paradosso del gatto di Schrödinger” sembra essere l’esemplificazione del rapporto che questi studiosi hanno col sapere scientifico: finché ne restano all’esterno, non ne sanno alcunché; se provassero ad entrare all’interno del campo scientifico, rischierebbero di ucciderlo.
Chiediamoci allora: qual è il senso di questo rinchiudersi nell’ambito delle scienze umane all’interno dei confini, linguistici e culturali, di un’identità nazionale? Non starò a psicanalizzare il desiderio recondito di questi studiosi di raccogliere dal fango le bandiere nazionali da altri gettate, perché la questione va oltre le singole soggettività. Davvero non ci sarebbe bisogno, di ricordare a una parte del Trio (e di spiegarlo all’altra parte davvero non c’è tempo né usta), che i confini nazionali, ben prima della globalizzazione, della circolazione mondiale delle merci, dei saperi e dei corpi messi, come il sapere stesso, a valore, sono cosa utile a nascondere ben altre, più radicali divisioni: tra chi sa e chi non sa, tra chi detiene il possesso dei mezzi di produzione e circolazione del sapere e chi ne è asservito o assoggettato, tra chi esercita l’egemonia culturale e chi la subisce, tra chi pone il sapere al servizio delle istituzioni disciplinari e di governance, e chi lo usa come leva per sovvertire lo stato di cose presente.
Ciò che qui si esprime è un’intelligenza accademica incapace di uscire dai confini stessi dell’Accademia, ed anzi intenzionata a difenderli, questi confini, sino a trarne un’ulteriore rendita di posizione: un’Accademia che proietta all’esterno i propri muri mentali, come reazione pavloviana contro il trasformarsi “comunicativo” dei saperi in relazione. Stiamo parlando di un’Accademia capace di reiterare uno stanco dibattito sul “realismo” senza mai menzionare la rivoluzione, in termini di Weltanschauung e di ontologia, della comprovata esistenza del Bosone di Higgs; ma anche, senza mai affrontare la questione dell’assunzione di oggetti, non importa se “esistenti” o “inesistenti”, «come ancoraggi delle pratiche, dati, cose, soglie, alle quali il “discorso” si riferisce»7 – e senza porsi in termini concreti, cioè politici, il problema dei giochi di veridizione, ma anche di opposizione (attraverso la forza del vero) al discorso costitutivo degli effetti di verità. Un’Accademia capace di titillare la biopolitica senza sapere cosa, in anni recenti, la paleontologia ha avuto la forza di dire su che cosa può essere considerato costitutivo dell’umano, ma anche di masturbare Foucault per anni continuando a pensare che le strutture epistemiche sono eterne e atemporali; di reiterare la distinzione tra “analitici” e “continentali” come randello buono ad avvalorare ogni pratica del “terzo escluso” (soprattutto se il terzo incomodo è la pop filosofia8), senza mettere in questione la pochezza euristica che tanto gli uni quanto gli altri hanno da dirci sulla comprensione (e se possibile la sovversione) dello stato di cose presente – a fronte rielaborazioni concettuali radicate tanto nelle prassi delle lotte, quanto nella tradizione di una critica dell’economia politica (che è altra cosa dall’economia, che secondo i Tre avrebbe soppiantato con la sua egemonia l’origine umanistica della politica), disciplina notoriamente trasversale alle distinzioni accademiche, ma non certo agli interessi di classe. Per tacere del depotenziamento dell’esercizio del sapere critico attraverso quel meccanismo autoreferenziale cui nessuno dei Tre in questi anni è sfuggito.
 In un’Accademia che periodicamente discute del nazismo di Heidegger con gli stessi toni con cui a Downton Abbey si sarebbe potuto discutere, dividendosi tra libertini e bacchettoni, delle nozze di lady Mary Crawley che andò all’altare col velo bianco pur non essendo più illibata – come se le implicazioni e le determinazioni sociali e classiste del Dasein non fossero oggi drammaticamente attuali –, non c’è da stupirsi se i rapporti tra saperi umanistici e scientifici vengono riproposti negli stessi termini (già all’epoca reazionari non solo in senso politico) dei seminari del “mago di Messkirch”.
In un’Accademia che periodicamente discute del nazismo di Heidegger con gli stessi toni con cui a Downton Abbey si sarebbe potuto discutere, dividendosi tra libertini e bacchettoni, delle nozze di lady Mary Crawley che andò all’altare col velo bianco pur non essendo più illibata – come se le implicazioni e le determinazioni sociali e classiste del Dasein non fossero oggi drammaticamente attuali –, non c’è da stupirsi se i rapporti tra saperi umanistici e scientifici vengono riproposti negli stessi termini (già all’epoca reazionari non solo in senso politico) dei seminari del “mago di Messkirch”.
Quello che è certo è che non v’è traccia di autocritica, o di disponibilità all’autoriforma, da parte di una siffatta Accademia. I nostri Accademici sono ben fermi nel criticare le pratiche di valutazione quantitativa cui l’Università (e, ci permettiamo di dar loro notizia, la scuola tutta) sono sottoposte, fingendo di non sapere che se la medicina è pessima, non è per ciò rimossa la malattia: come se prima dell’istituzione dell’ANVUR le pratiche concorsuali di selezione e assegnazione di cattedre, borse e quant’altro non fossero sovradeterminate da una diffusa prassi che legittimerebbe l’uso di una abusata e poco esplicativa parola come “casta”9.
Ma soprattutto: le prassi di omogeneizzazione e suddivisione analitica dei saperi in unità discrete e misurabili ha ben poco a che vedere con l’egemonia degli studi scientifici10. Quel che è in atto è piuttosto la messa in opera di svuotamento dell’accesso ai saperi in funzione di una loro riproducibilità meramente esecutiva, cosa per la quale più che i saperi scientifici sono quelli tecnico-comunicativi di nuova generazione ad avere la meglio, permettendo la creazione di nuove élite, ma anche di nuove masse analfabetizzate.
Non si fa molta strada se ci si limita a riconoscere che il paradigma di valutazione è la cifra generale del nostro tempo, e «costituisce di fatto una modalità di denazionalizzazione della cultura e di omologazione ai parametri globalizzati dell’attuale idolatria ideologica del mercato», senza entrare nel merito della natura dei processi di governance, senza tematizzare quella società del controllo di cui parlavano Deleuze e Foucault; senza approfondire la critica ai processi di decostituzionalizzazione attraverso l’introduzione di atti amministrativi con valore di norma la cui valenza deriva non dai processi decisionali costituzionali, ma dal valore performativo di “valori” quali efficienza, performatività, economicità11. Per stigmatizzare l’effetto senza agire sulla causa non c’è bisogno di Tre accademici: basta qualche demagogo, poco importa se pentastellato o forcone.
E ancor meno strada in avanti – ma molta all’indietro – si fa riconducendo l’attuale crisi della politica12 alla crisi del sapere umanistico: come se la politica fosse espressione di un ceto culturale, e non di processi economico-sociali che al tempo stesso chiedono di essere governati, e si oppongono alle pratiche di messa a norma. Come se la crisi della politica non fosse la conseguenza della continua tensione tra questi due poli, tensione che oggi non riesce a rispondere in termini effettuali alle richieste (ai claims) provenienti dalla società. Come non ricordare, allora, i versi del Poeta: Al tutto si ridea Camminatorto / Di sì fatte commedie, e volentieri / Ai topi permettea questo conforto13.
Nella prima stesura dell’Appello si citava, in modo avventato, il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, attribuendolo al «nostro più grande poeta». Se non ché nel discorso leopardiano di poesia ce n’è poca: c’è un’analisi comparata dei costumi che determinano l’affermazione di nuovi valori morali e civili, e che a loro volta sono derivati dall’appartenenza a determinate classi sociali – quella che altri chiamerebbero composizione di classe. Rudimentale quanto si vuole, la lettura delle strutture economiche e delle sovrastrutture sociali (e della retroazione di queste su quelle) che tenta Leopardi è a fondamento di quei valori etici che verranno descritti in forma di satira negli argutissimi Paralipomeni alla Batracomiomachia, e nella forma di un’epica senza eroi nella Ginestra: non certo il contrario. Vale la pena di ricordarselo, dentro e fuori le Accademie, per chi ne abbia abbastanza di chi tiene i suoi anni al guinzaglio e si ferma ancora ad ogni lampione, e di chi protesta contro il fatto che il sole non gira più attorno alla propria testa. Di chi ne ha abbastanza anche del girare intorno senza futuro all’interpretazione del mondo, e vorrebbe senz’altro passare alla sua trasformazione: il che ha poco a che fare con appelli e Accademie e con le loro rappresentazioni del mondo, e molto con tutto quello che c’è al di fuori dello schermo, cioè col mondo stesso. Ma questa, direbbe l’indimenticabile Moustache, è un’altra storia…
“Il Mulino” n. 6/2013, pp. 1076-1085, leggibile on line qui. È tuttavia circolata in rete (ad es. su “ROARS”, qui) una versione diversa, che appare essere una prima bozza nella quale, pur in presenza delle tre firme, l’appello si autodefiniva redatto «a quattro mani». In questa (prima?) stesura, della quale non è difficile comprendere quali siano le mani originarie, e quali quelle successivamente aggiunte, il passo sulla crisi della politica suonava così: «Dopo anni di recessione e di crisi siamo divenuti completamente avvezzi all’idea che l’alfa e l’omega della politica sia l’economia. La riscossa liberista di origine anglo-sassone degli anni ’80 si è innestata sul vecchio tronco marxista europeo-continentale accreditando questo che ormai, almeno a livello ufficiale, è un pensiero assolutamente dominante». Viene da dire, davanti a questa improvvida pubblicazione di una Ur-stesura che consente divertenti confronti: è l’inconscio, bellezza, e tu non puoi farci niente! ↩
Senza pretesa di completezza, e senza neanche ricorrere alle schede di lettura: Chiara Valerio, Nessuna scuola mi consola; Cosimo Argentina, Beata ignoranza; Mila Spicola, La scuola s’è rotta; Girolamo De Michele, La scuola è di tutti; Giuseppe Caliceti, Una scuola da rifare; Andrea Bajani, Domani niente scuola; Davide Montino, Con il grembiule siamo tutti più buoni; Carlo Bernardini, Apologia della scuola pubblica laica; Salvo Intravaia, L’Italia che va a scuola; Valeria Pinto, Valutare e punire; Giancarlo Visitilli, E la felicità, prof?; e ancora, le molte giornate di studio promosse dal CESP (dalle quali è stato prodotto il volume I test Invalsi: contributi a una lettura critica), la settimanale rubrica su “Internazionale” di Tullio De Mauro, gli articoli di Mila Spicola su “l’Unità”, quelli di Marina Boscaino su “MicroMega” e quelli di Girolamo De Michele su “www.carmillaonline.com”, le riedizioni degli scritti di don Milani, e da ultimi i fascicoli di fine 2013 delle riviste “Gli Asini” (rivista peraltro attiva dal 2010) e “Nuova rivista letteraria”. Più in generale, mi permetto di rinviare al mio Per farla finita con Shylock. Dalla scuola del privatus alla scuola del comune, qui. ↩
Vedi l’articolo Una scuola per l’Italia, “Corriere della Sera”, 21 agosto 2008, con cui Galli della Loggia diede il la alla campagna d’agosto di Gelmini e Tremonti. È degno della più tipica tradizione italiana, quella del Brindisi di Girella del Giusti e dei Filosofi salariati dello Stecchetti – ma che te lo dico a fare? – che quel Galli della Loggia che ieri, mosca cocchiera di Gelmini proponeva di riformare la scuola «facendo piazza pulita delle troppe materie e degli orari troppo lunghi che affliggono la nostra scuola, e ricentrando con forza i nostri ordinamenti scolastici intorno a due capisaldi: da un lato la lingua italiana e la storia della sua letteratura, cioè intorno alla voce del nostro passato, e dall’altro le matematiche», oggi si lagni della diminuzione delle ore di latino, geografia e storia dell’arte (ed anche di diritto e informatica) effettuate dal suo ministro, e tuoni contro l’eccessivo spazio dei saperi scientifici. ↩
Su questo tema appena abbozzato, ma di capitale rilevanza, rimando a Sandro Mezzadra, “Vivere in transizione. Verso una teoria eterolinguale della moltitudine”, in La condizione postcoloniale, Ombre corte, Verona 2008, pp- 106-126. Citando Naoki Sakai, Mezzadra scrive che la moltitudine è «una comunità al cui interno ci rivolgiamo l’un l’altro attraverso l’attitudine all’indirizzo eterolinguale» (p. 125). ↩
Bisognerebbe ricordare ai Tre che il Monarchia di Dante, da loro citato, è un formidabile trattato di logica sillogistica attraverso le cui strutture atemporali sempre uguali a se stesse Dante può liberarsi del fardello della teologia. E che, vivaddio, dai tempi di Galileo sappiamo che il linguaggio della scienza è non l’inglese, ma la matematica. ↩
La citazione è tratta da Isaiah Berlin, “Il divorzio tra le scienze e gli studi umanistici”, in Controcorrente, Adelphi, Milano, 2000, pp. 119-163. Avendo voglia di celiare, se quandoque bonus dormitat Homerus, anche Berlin sarà scusabile per aver dormito sui banchi durante le lezioni di matematica e scienze: ma far proprie le sue vetuste distinzioni in un’epoca nella quale si può apprendere qualche sensato fondamento di cultura scientifica anche leggendo piacevoli romanzi o guardando sitcom o crime drama d’intrattenimento è imperdonabile. ↩
Sandro Chignola, “Phantasienbildern”/”histoire fiction”. Weber, Foucault, in La forza del vero, a cura di Pierpaolo Cesaroni e Sandro Chignola, Ombre corte, Verona 2013, p. 43. ↩
Sulla pop filosofia rimando, oltre che alle mie due note del 2012 Oltre l’accademia: le strade, 2012, qui, e La pop filosofia spiegata a un accademico (e non solo a lui), qui, al mio Filosofia. Corso di sopravvivenza, Ponte alle Grazie, 2011, nel quale credo di aver dimostrato che la pop filosofia è ben più che il bullismo sofistico di qualche tricoteuse su facebook, o le magliette di Žižek e le biciclettate di Sloterdijk; da ultimo segnalo su “Jura Gentium” Giulio Itzcovich, La sofistica della guerra al terrorismo. Discutendo Stato di legittima difesa di Simone Regazzoni (qui, in corso di stampa sul n. 2/2013), esemplare nel separare il grano dal loglio nell’ambito pop-filosofico. ↩
Da cui l’espatrio, o meglio, la migrazione, dei nostri studenti, dai Tre interpretata come una moda tra i rampolli della classe dirigente, come un bisogno di brioches per disprezzo del pane nostrano. Sembra che i tre autori non riescano a distinguere tra viaggio turistico e viaggio di formazione – ma soprattutto, sembra che il sapere sia nazionale. Non c’è bisogno di essere fan di Kant per comprendere che il sapere (sia esso “letterario” che scientifico) è sovranazionale: lo era già nell”800, figurarsi nel terzo millennio. ↩
Come se anche dal campo delle matematiche non fossero giunte critiche durissime e approfondite ai test di valutazione che riducono le matematiche alla mera dimensione strumentale, bypassando la sua dimensione problematica: per fare qualche nome, dall’insegnante Carlo Salmaso al filosofo della matematica Gabriele Lolli e al logico Piergiorgio Odifreddi. ↩
Vedi il fondamentale intervento di Sandro Chignola Appunti sulla potenza giuridica della moltitudine, qui. ↩
“Della politica” o “del politico”? Tra una stesura e l’altra, sei mani e tre teste non sembrano essersi messi d’accordo. Poiché “il politico”, das Politische, al neutro, denota la sintassi politica di Carl Schmitt, l’ambiguità espressiva dei Tre ha un suo rilievo. ↩
Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia, VI, vv. 137-139 ↩