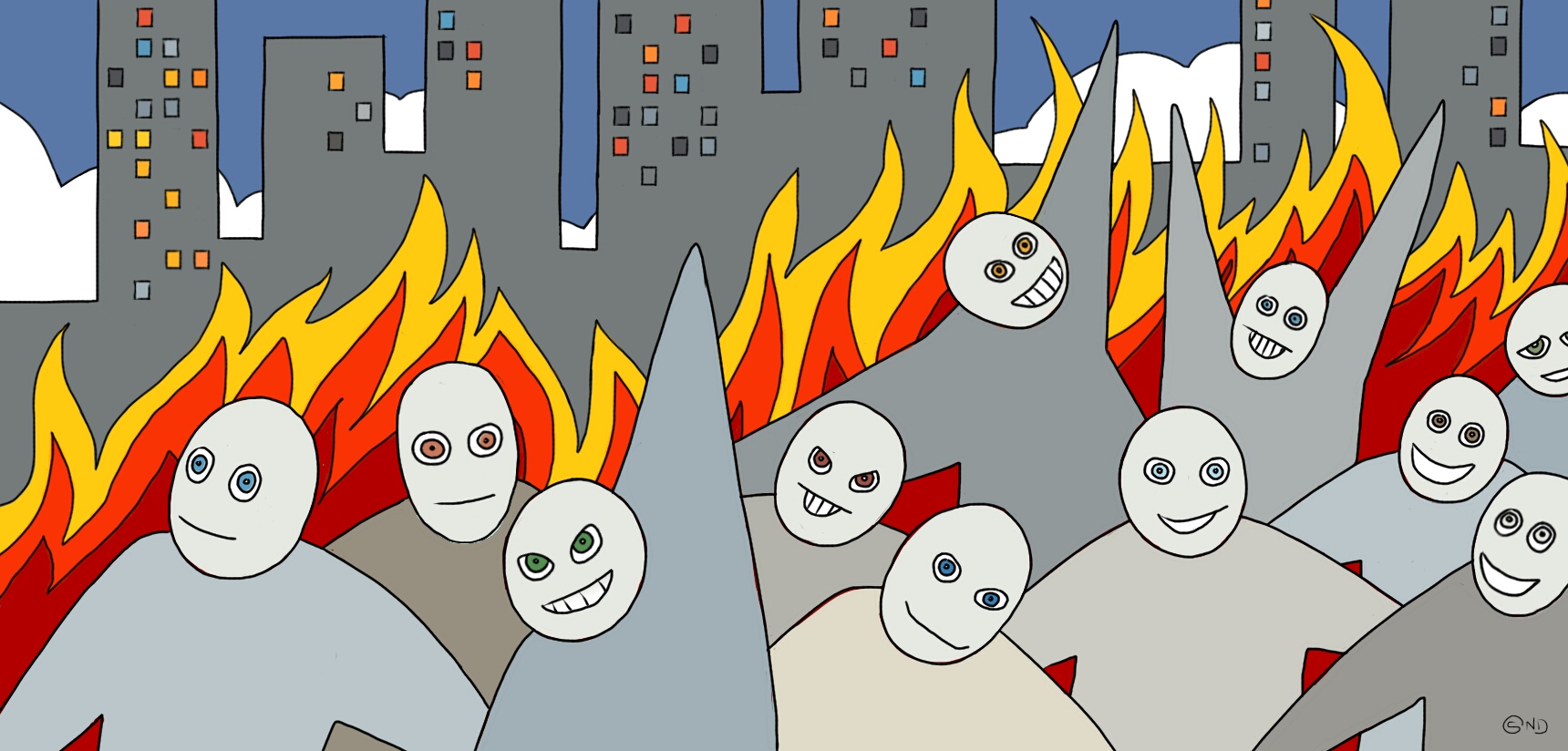di SIMONE PIERANNI.*
Negli ultimi tempi gli equilibri asiatici sembrano essere completamente in via di ridefinizione. La scintilla diplomatica del nuovo presidente filippino Rodrigo Duterte, che ha tuonato contro gli Usa e si è avvicinato alla Cina, ha costituito la prova che qualcosa sta cambiando. A stretto giro la Malesia è apparsa seguire lo stesso percorso, mentre la Birmania cerca il modo migliore per avvicinarsi a Pechino, così come farà presumibilmente la Thailandia una volta superata la fase di successione dinastica a seguito della morte del proprio re.
Si tratta di segnali che indicano un cambiamento negli equilibri asiatici o il sintomo di qualcosa di più grande? E come interpretare un recente articolo di Foreign Affairs, nel quale viene esaminato il maestoso piano «One Belt One Road» della Cina, la nuova via della Seta tanto marittima quanto terrestre che punta Asia, Medioriente, Europa e perfino gli stessi Stati uniti, nel quale si suggerisce agli Usa di non porsi «contro» Pechino, ma di provare a entrare in una sorta di collaborazione con il gigante cinese?
Siamo di fronte a segnali di modifiche paradigmatiche degli equilibri mondiali, oppure si tratta di scosse parziali che non metteranno in discussione la principale potenza mondiale? Sono domande sulle quali da tempo si pubblica svariato materiale di studio, principalmente rivolto a due argomenti: ci si chiede se gli Stati uniti sono nella loro fase discendente e se la Cina riuscirà a non crollare sotto i colpi delle proprie contraddizioni proprio nel momento di maggior debolezza del suo rivale.
Naturalmente, come sempre accade, le cose sono più complicate.
Sul primo punto è intervenuto di recente Joseph S. Nye jr, considerato il teorico del «soft power» (con i suoi Soft Power, Einaudi, 2005 e Smart Power, Laterza, 2012) con un volume di recente pubblicazione, Fine del secolo americano? (Il Mulino, pp.136, euro 13, con un’introduzione di Angelo Panebianco) nel quale viene sostanzialmente analizzato il rapporto tra Cina e Stati uniti.
Senza paura di spolier, Nye non ritiene che sia già giunto il momento di decadenza dell’impero americano, anzi: Washington sembra ben salda in sella. L’analisi si completa di elementi politici, economici e culturali; naturalmente non manca il soft power che dimostrerebbe come in realtà gli Usa non siano in un momento di grande difficoltà, specie rispetto al sorgere di potenze che, prima tra tutte la Cina, benché in ascesa non sembrano ancora in grado di reggere il confronto (Nye sembra maggiormente preoccupato circa il dato del raddoppio della popolazione africana nei prossimi decenni). Per Nye è confermata l’espressione: «Il secolo americano: data di nascita 1941, morte: incerta».
Il professore della John F. Kennedy School of government di Harvard vede l’attuale mondo diviso in tre enormi scacchiere, simboli della rinnovata complessità del mondo multipolare. Sulla «scacchiera superiore» Nye pone il potere militare, «in gran parte unipolare, in quanto è probabile che gli Stati uniti ne mantengano il primato ancora per molto tempo».
Sulla seconda, quella «di mezzo», Nye pone il potere economico, quello ancora «multipolare con gli Stati uniti, l’Europa, il Giappone e la Cina quali principali giocatori e altri paesi che guadagnano posizioni». Infine c’è la scacchiera «in basso», ossia «il regno delle relazioni transazionali, che attraversano i confini, fuori dunque dal controllo del governo». Su questa piattaforma si confrontano «i giocatori non statali, i più disparati, dai banchieri, che trasferiscono fondi elettronicamente, ai terroristi, che trasferiscono armi, dagli hacker, che costituiscono un pericolo per la sicurezza informatica, a minacce quali pandemie e cambiamenti climatici».
Secondo Nye quest’ultima scacchiera è quella determinante per il futuro e nessuna potenza potrà esercitare una vera egemonia al riguardo: «da solo nessuno può affrontare con successo questi problemi transazionali, nemmeno una superpotenza, che dovrà dunque ricorrere alla collaborazione di altre realtà». Gli Stati uniti non starebbero perdendo un’egemonia; è la loro centralità a non bastare più: «sul piano di gioco della scacchiera bassa, il potere è ampiamente diffuso e non ha senso parlare di unipolarismo, multipolarismo o egemonia. Molti di questi problemi non sono risolvibili grazie a soluzioni militari, per cui diventeranno indispensabili reti di cooperazione».
Nye conclude la sua riflessione citando il documento del National Intelligence Council, «le cui stime sono valutate attentamente dal presidente degli Stati uniti», secondo il quale nel 2030 gli Usa saranno ancora «il paese più potente al mondo» ma non ci saranno paesi egemoni. Il merito della riflessione di Nye è duplice; da un lato evidenzia i problemi attuali di percezione di sé degli americani, dall’altro allarga il campo: è davvero importante capire chi tra Cina e Usa sarà più potente, a breve o nel lungo periodo, o stiamo solamente posticipando una riflessione più generale su un mondo nel quale conteranno sempre meno gli stati e sempre più gli organismi transnazionali (fossero pure alleanze tra stati)?
Nye mette sul tavolo questa riflessione, mentre gli analisti più focalizzati sulla Cina tentano di uscire da quel buco nero orientalista che è la «visione occidentale» della Cina.
A questo proposito appare connesso con il volume di Nye l’opera dell’analista della George Washington University Bruce J. Dickson, The dictator’s dilemma, the chinese communist party’s strategy for survival (Oxford university press), non tanto perché il libro indaga – anche – il rapporto con gli Stati uniti da parte di Pechino, quanto perché costituisce un importante documento per una comprensione più dettagliata della potenza cinese.
Al riguardo bisogna specificare due punti fondamentali: innanzitutto il titolo del volume non corrisponde in modo preciso all’oggetto del libro. Dickson non perde tempo a chiedersi se la Cina sopravviverà o collasserà a breve – il professore è da annoverare tra i teorici della prima ipotesi – ma si focalizza sulla concezione che i cinesi hanno rispetto al partito comunista. Ne emerge come il colosso politico cinese sia in grado di aprire spazi di riflessione e garantire ricchezza e stabilità economica al paese (anche attraverso meccanismi ambigui e poco ortodossi) ed essere percepito come il motore di una maggiore «democrazia».
Dickson sfonda un argomento considerato basilare nelle critiche alla Cina, specie nel suo paragone con gli Stati uniti. I fautori della «teoria del collasso» ritengono infatti che la Cina crollerà perché non sarebbe in grado di democratizzare le sue istituzioni a fronte di uno sviluppo economico clamoroso. Dickson dimostra – al contrario – che i cinesi ritengono di vivere un periodo di grande apertura democratica rispetto al passato. Naturalmente, e questo viene specificato da Dickson, dipende molto da cosa si intenda per democrazia. Il professore si focalizza su alcuni filoni occidentali di analisi del concetto e delle sue dinamiche e ne analizza alcune sue correnti cinesi, ricordando con grande enfasi il filone della «nuova sinistra» che avvicinava molto il concetto di democrazia a quello di eguaglianza economica.
Riagganciandosi a quanto scritto da Nye, il volume di Dickson fornisce un quadro molto dinamico delle realtà sociali e civili cinesi, aprendo alla possibilità che nello «scacchiere basso» di Nye, alla fin fine, se non conterà tanto Pechino per il suo peso «nazionale», potranno invece contare apparati transazionali – banche, società informatiche, operatori della logistica – cinesi. Nel continuo apprendimento delle proprie logiche di sopravvivenza, in fondo, sembrano ritrovarsi quelle organizzazioni civili e sociali in grado di uscire dai confini cinesi e giocarsi le proprie carte nella scacchiera «di sotto», fondamentale per determinare chi sarà egemone nel futuro del mondo multipolare.
*recensione pubblicata l’8 novembre 2016 su il manifesto.