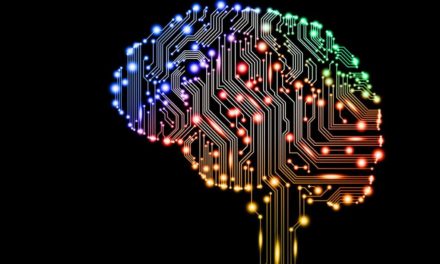di INDIPENDENTI.EU. I mesi estivi hanno portato alla ribalta delle cronache il caso UberPop, il sistema di condivisione che mette in rete il trasporto privato con eventuali clienti, creando, non del tutto a torto, il malumore dei tassisti di professione che in più di una città europea hanno contestato l’introduzione del servizio sul proprio territorio, arrivando al blocco dell’applicazione UberPop in Italia. La mediatizzazione del caso, ha portato a una legittima e crescente attenzione per i fenomeni di business centrati sulla sharing economy, attraverso i quali è possibile condividere dall’automobile all’appartamento fino agli incarichi professionali per i free lance.
In ognuno dei casi più citati dalle inchieste giornalistiche, è stata data particolare attenzione alla rete come dispositivo necessario per l’adeguato sviluppo delle imprese che forniscono la piattaforma di informazione e in alcuni casi si è giustamente fatto anche riferimento alle diseconomie che la diffusione di questa modalità di business produce su settori produttivi e territori. Tuttavia, il tema del cosiddetto “capitalismo collaborativo” si sta rapidamente sviluppando al di là di servizi utili, ma non essenziali, espandendo il concetto di condivisione fino a settori strategici, implicando la trasformazione stessa del tessuto urbano in funzione di scenari del futuro prossimo, ben più concreti di quello che può sembrare. Le varie piattaforme UberPop, AirBnB, Twago, ecc. vanno visti come la punta dell’iceberg: il capitalismo collaborativo, l’architrave della Terza rivoluzione industriale teorizzata da Jeremy Rifkin1, è oggi forse l’ultimo salvagente per un sistema economico in piena crisi e alla frenetica ricerca della direzione per una salutare ristrutturazione, la cui portata potrebbe essere non diversa dal transito dall’economica industriale a quella dei servizi avvenuto, almeno nell’area euroatlantica, tra i Settanta e gli Ottanta.
A proposito di “green capitalism”
Al di là delle banalizzazioni, a cui concetti complessi sono spesso soggetti anche negli ambienti militanti, lo sviluppo di un capitalismo “verde” è un processo in corso di perfezionamento da più di un decennio e non è fermo alla generica dichiarazione di principi, come siamo abituati a considerare gli stracitati Protocolli di Kyoto o le dichiarazioni di Barack Obama nel suo recente viaggio in Alaska.2
Non è sufficiente riconoscere che il capitalismo verde è un tentativo di riconversione produttiva su scala globale, né fermarsi all’idea che il “green-washing” sia solo una strategia di marketing.
Sostenibilità e utilizzo di energie alternative sono ormai campi di investimento economico concreto, su cui sono messe in campo ingenti risorse, economiche e umane, competenze, strategie trasversali al mondo della grande impresa, della governance e dell’amministrazione del territorio.
Gli obiettivi del Programma Quadro europeo Horizon 2020 sono in larga parte orientati all’efficienza energetica, alla risposta al cambiamento climatico, all’identificazione di alternative all’economica degli idrocarburi. In concreto, questo significa che l’Unione Europea sta concretamente mettendo in campo risorse per attuare una trasformazione radicale del modo di produrre e consumare nel Vecchio Continente: l’innovazione promossa dal Programma Horizon2020 implica infatti un tessuto produttivo adeguato a recepire e applicare le soluzioni tecnologiche e organizzative proposte, un sistema integrato tra ricerca, impresa e domanda che diventi egemone scalzando processi e mercati considerati, non del tutto a torto, obsoleti e nocivi. Il Piano strategico per le tecnologie energetiche, adottato dall’UE nel 2008 ha un budget stimato di 71,5 miliardi di euro e si basa su sei “iniziative industriali europee” (EELS), in cui vengono riunite industria, comunità di ricerca e stati membri, finalizzati allo sviluppo di alcuni settori chiave: eolico, solare, reti elettriche, carbone, fissione e fusione nucleare, bioenergie, smart cities e idrogeno.3 significa dare impulso a nuove professionalità e a nuovi ambiti di business, come le ESCo, Energy service companies, che pianificano gli interventi di efficientamento energetico e si candidano, in un futuro di “internet dell’energia”, su cui si tornerà, a diventare le UberPop dell’elettricità e del riscaldamento. Significa, infine, cambiare del tutto il paradigma con cui si parla di sostenibilità dal punto di vista abitativo e immobiliare: per i grandi fondi di investimento, ad esempio, sono ormai fuori mercato quegli edifici che non rispettano parametri avanzati di efficienza, che sono oggi una voce di bilancio a cui i grandi investitori stanno assai attenti, tanto sull’immobiliare residenziale, che su quello commerciale e perfino logistico.4 Per i piccoli proprietari (che comunque rappresentano una quota importante del mercato) significa dover sostenere costi di riqualificazione per poter sperare di rientrare, un domani, dell’investimento sostenuto per l’acquisto. Come si vedrà, questo processo è prossimo a influire in maniera profonda sul nostro tessuto urbano.
Da “green” a “share”
Una trasformazione di questa portata, secondo quanti svolgono ricerca nel campo dell’innovazione orientata alla pianificazione urbanistica, non può prescindere dai processi di apprendimento collettivo e ad un sistema relazionale adeguato a far circolare tecnologie e know-how. Introdurre una tecnologia complessa all’interno del mercato non è cosa da poco, specialmente quando si parla di soluzioni “distribuite”, ovvero di dispositivi orientati non soltanto ai professionisti di un determinato settore, ma destinati a entrare sul mercato del singolo consumatore. La differenza, per capirci, è quella che intercorre tra un Ibm System/360 grande come una stanza e uno smartphone qualsiasi. A proposito di smartphone, l’esempio è ancora più calzante se pensiamo alle possibili funzioni di un telefono di nuova generazione e a quanto realmente riusciamo a fare: perché le soluzioni di gestione energetica previste dalle innovazioni orientate alla sostenibilità abbiano un’applicazione effettiva, il consumatore medio non potrà più limitarsi a usare le sole app di comunicazione, ma dovrà saper gestire da remoto i consumi e i possibili problemi energetici dell’abitazione. Non è fantascienza, ma la realtà dei sistemi di domotica attualmente presenti sul mercato immobiliare (e non parliamo di top di gamma).
Per tornare al nocciolo della questione, quindi, senza il fattore umano e relazionale, molte soluzioni per l’efficienza energetica potrebbero non avere applicazione concreta. Ma soprattutto, verrebbe meno uno dei pilastri della Terza rivoluzione industriale: l’”internet delle cose”. Nello scenario proposto da Rifkin ed effettivamente in via di applicazione, la produzione di energia dovrà affrancarsi dalle grandi corporation e sarà un processo distribuito all’interno dei singoli edifici, che si trasformeranno in mini-centrali. L’effettiva realizzazione di questo programma, preso molto sul serio dagli operatori del sistema delle costruzioni, implica ancora alcuni passaggi quali la messa a punto dei sistemi di accumulazione, ma soprattutto un network sociale in grado di far incontrare domanda e offerta energetica a partire dai piccoli produttori. Le possibili conseguenze di questo scenario sono varie, contraddittorie e di difficile valutazione: ad esempio, viene da chiedersi, su quale piattaforma viaggerà questo tipo di relazione di scambio? Chi vincerà la sfida di questa nuova forma di accumulazione originaria? Chi guiderà l’offerta di questo tipo di servizi, facendo profitti sulla costruzione di rete tra i piccoli produttori di energia e chi ne avrà bisogno? In questa ottica possiamo immaginare un domani che nel ventaglio di servizi offerti dalle ESCo rientri anche la gestione di una piattaforma à-la-UberPop per l’energia.
E’ possibile a questo punto introdurre un altro tema dirimente, ovvero come questi scenari influiranno sulla forma delle nostre città e sul modo di vivere urbano prossimo venturo, facendo il punto sulle proposte che sono state messe in campo e che interrogano non solo la questione delle tecnologie, ma anche la rete sociale che dovrebbe supportarle.
Come cambierebbero le nostre città?
Sgomberiamo subito il campo da un’ ulteriore banalizzazione: smart city non significa avere wifi disponibile e fibra ottica ovunque. O almeno non solo e l’efficienza della rete internet è uno strumento più che un fine dei progetti di evoluzione smart dello spazio urbano. Come scritto dal sociologo Aldo Bonomi, è dall’intreccio tra soggetti invisibili, «privi di cittadinanza», che lavorano «nei servizi, nel commerci, nella logistica minuta», e gli «smanettoni […] che uniscono l’artigianato alla tecnologia (makers) e si associano nei coworking, puntano all’auto-impresa, creano comunità di mutuo-aiuto, di cura e relazione»,5 che la pratica della smart city prende corpo.
Quando parliamo di smart city, dobbiamo quindi ragionare in termini di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi urbani in base alle condizioni ambientali e alla domanda effettiva di questi stessi servizi. Significa essere in grado di raccogliere e processare una enorme mole di dati, in tutto differenti, per rendere più efficienti alcune funzioni riproduttive delle metropoli contemporanee: dalla gestione del traffico, all’utilizzo dell’illuminazione stradale, alla raccolta e smaltimento differenziato dei rifiuti. Ovviamente, efficienza va intesa in due termini, complementari, ma anche antitetici rispetto al fine ultimo a cui puntano: da un punto di vista delle risorse, significa ottimizzare e ridurre al minimo l’eventuale spreco. Un obiettivo che è difficile non considerare meritorio là dove tra le diseconomie più evidenti che l’economia della conoscenza ha ereditato dal mondo fordista è l’incapacità di evitare sprechi di risorse non riproducibili, come il suolo e le fonti energetiche derivanti dagli idrocarburi. Ma efficienza va inteso anche in termini di bilancio: e qui “green” e “share” si incontrano, interrogando la nozione stessa di “Comune”, al di là del pubblico e del privato. La diffusione di applicazioni smart per le città richiede infatti sempre meno attività da parte degli enti locali e una sempre maggiore responsabilizzazione dei cittadini per il loro pieno funzionamento: capacità di accogliere e diffondere le competenze necessarie all’uso delle tecnologie, la disponibilità a farsi rintracciare ed essere costantemente connessi, lo sforzo individuale a puntare alla massima efficienza possibile dal punto di vista energetico per i propri beni immobili e veicoli. Tutto ciò, richiederebbe prevedibilmente un intenso sforzo iniziale, dal punto di vista della sensibilizzazione, dell’informazione e della formazione, ma in prospettiva esenterebbe gli enti locali dal gestire numerose attività e servizi. Uno degli obiettivi dichiarati è rendere i territori del tutto autosufficienti dal punto di vista della gestione dei servizi di prossimità e responsabilizzarli per un loro corretto funzionamento. Tra i progetti attualmente in fase sperimentale, ci sono forme cooperativistiche di gestione del trasporto pubblico del quartiere, degli spazi collettivi e della raccolta dei rifiuti, che l’Enea sta vagliando per una periferia romana. Inoltre, sempre all’interno dei progetti in fase di studio da parte dell’Enea, si sta vagliando l’evoluzione dell’intero patrimonio immobiliare verso una rete di “interactive buildings”, dove non è solo il singolo edificio ad essere efficiente, ma l’intero tessuto urbano a strutturarsi secondo il modello della Smart Grid (rete elettrica intelligente) verso quello dello Smart district in connessione con uno più Urban data centres che elaborano e gestiscono le informazioni relative ai fabbisogni e ai consumi energetici.6 Non solo trasformazione urbanistica, ma sociale, che porta il concetto di “rigenerazione urbana”, oggi praticamente il mantra di qualsiasi amministrazione locale europea, ad un livello di complessità inedito dal quale non possiamo più sottrarci.
La rigenerazione urbana, specialmente nella prospettiva della Smart city, implica infatti la completa ristrutturazione di un quartiere coinvolgendo non solo l’aspetto esteriore o elementi infrastrutturali visibili come la rete stradale: significa ridisegnare la connettività del territorio, i suoi consumi, lo stile di vita dei suoi abitanti. A spingere verso questa esigenza concorrono numerosi fattori, non tutti astratti né estranei alla domanda di qualità della vita dei cittadini: messo da parte l’ambigua questione del “degrado”, non è un mistero che specie in alcune periferie urbane italiane, esista l’esigenza di migliorare i collegamenti, la salubrità e la funzionalità del territorio. Inoltre, la rigenerazione può essere una risposta a due problemi concreti, come il consumo di suolo e il recupero di aree abbandonate in seguito al restringimento demografico o alle ristrutturazioni produttive. Le contraddizioni possono diventare enormi: dal favore con cui l’industria delle costruzioni guarda ai piani di rigenerazione per uscire dalle secche della crisi (in Italia qualcosa come il 70% degli interventi attualmente sono di ristrutturazione, mentre le nuove costruzioni restano invendute e con valori dimezzati rispetto al decennio scorso), nonostante la quale in territori come il Lazio continua a rappresentare il 4-5% del Pil; al rischio gentrificazione a cui sono sottoposti i territori rigenerati; alla stessa dispersione di identità che l’eventuale abbattimento e ricostruzione potrebbe comportare specie per i centri storici (un processo non diverso da quello degli sventramenti monumentali del fascismo, o della ricostruzione delle aree berlinesi un tempo sul confine BRD-DDR).
Il rischio espulsione, l’ingerenza di attori privati nei processi di ristrutturazione, la dispersione di tessuti produttivi e sociali diversi da quelli standardizzati del capitale, sono tuttavia terreni più o meno consolidati di conflitto, su cui i movimenti per il diritto all’abitare e contro la gentrificazione sono già attivi e hanno strumenti di critica più o meno adeguati.
Tuttavia, dalla rigenerazione in chiave sostenibile, con il diretto coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei servizi urbani ristrutturati in chiave sostenibile, arriva una sfida che è difficile raccogliere senza trasformarsi automaticamente in forza conservatrice o reazionaria. Così come l’incrocio di “green capitalism” e “sharing economy” applicato all’energia ribalta il senso di due piani di ragionamento oggi al centro del dibattito dei movimenti: il mutualismo e il comune.
Per una democrazia energetica e un nuovo diritto alla città
Il piano del confronto è complesso e al momento è difficile proporre alternative strutturate per fronteggiare un processo al tempo stesso avanzato, ma in divenire. Tanto più se ci confrontiamo con la realtà di un paese, come l’Italia, ancora stretto tra economia della conoscenza e fattori di arretramento, oggi aggravati dall’austerity e dalle strette regole di bilancio a cui sono sottoposti le amministrazioni locali. Inoltre, tutto si può dire tranne che il nostro sistema formativo sembri all’altezza della transizione verso il comando dell’ICT. Eppure, siamo forse il paese europeo con la maggiore dotazione di smartphone, il sistema delle costruzioni si sta, seppur lentamente adeguando ai parametri richiesti dalle normative in fatto di sostenibilità, e conta al suo interno delle eccellenze sul livello europeo. Non a caso, anche per Expo si è puntato non solo sul tema portante del cibo, ma anche sull’ottenimento di certificazioni di sostenibilità particolarmente esigenti, in termini non solo di energia, ma anche di gestione dei cantieri. Solo fumo negli occhi? Certamente in un paese con una stringente emergenza abitativa e, rispetto ad Expo, di fronte al ricorso costante a quote di lavoro nero insostenibili, parlare di Terza rivoluzione industriale sembra fantascienza e mero marketing. Eppure, come credo mostrato dalle pagine precedenti, il processo è globale e anche l’Italia non può sottrarsi, al costo, questo è il punto, di enormi forzature.
Ora, come movimenti sociali, le sfide che ci si pongono davanti sono varie: la riarticolazione di un nuovo diritto alla città deve essere in grado di mettere in discussione le dismissioni di servizi essenziali, ma allo stesso tempo deve saper costruire una contro-narrazione del comune, alternativa a quella che ci verrà proposta dai piani di riorganizzazione dei servizi di prossimità. Come si trasforma questa devoluzione di poteri verso la cittadinanza in “contropotere”? E’ difficile dirlo, tanto più se parliamo di ambiti complessi, la cui comprensione e pieno controllo richiede competenze e qualifiche: saremmo in grado di produrre e gestire in maniera orizzontale e democratica l’energia? Sembra una domanda fuori dal tempo, ma non è escluso che verremo presto chiamati a ragionare su forme di “democrazia energetica” e distribuzione indipendente da soggetti imprenditoriali. Altra domanda: le nostre forme di mutualismo, quando è che finiscono di essere strumenti di autorganizzazione e rischiano di trasformarsi in spazi di autoesclusione oppure di legittimazione per la dismissione dei servizi e forme, per quanto “altre”, di capitalismo collaborativo?