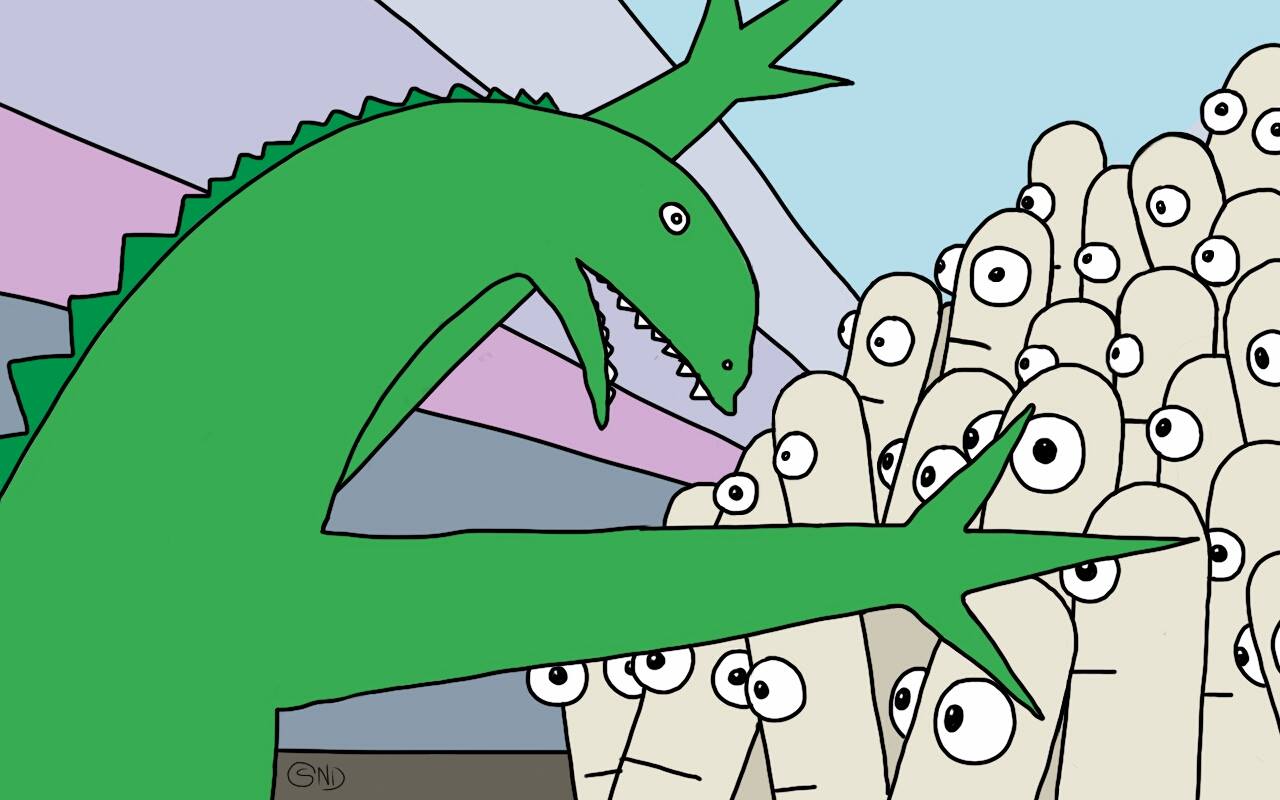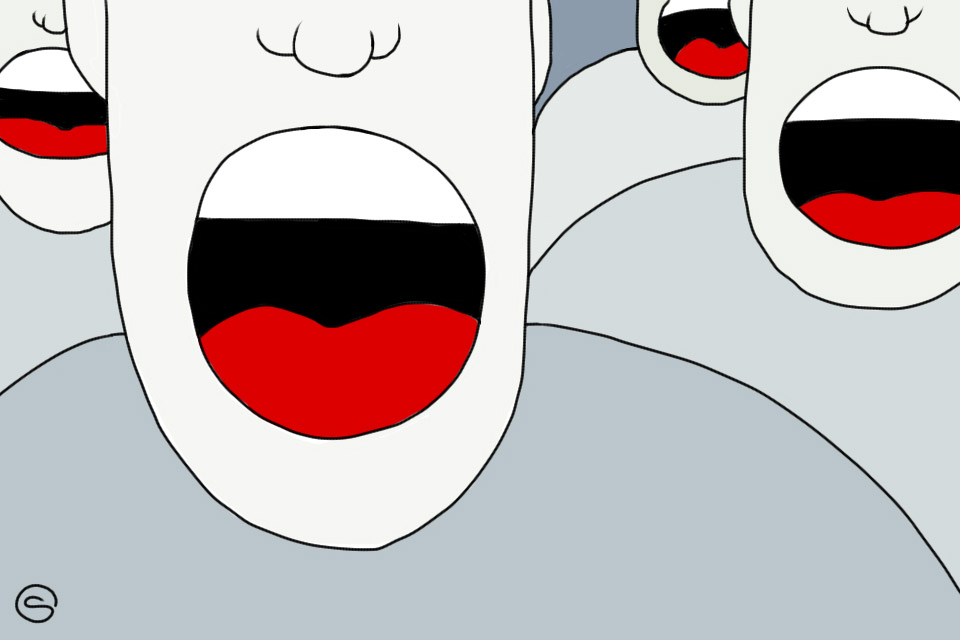di LORENZO RUSTIGHI.
D’ora in poi i servizi museali saranno considerati servizi pubblici essenziali, come scuole, ospedali e trasporti. Questo l’oggetto del decreto approvato in tutta fretta da Palazzo Chigi, a seguito delle polemiche sollevate attorno alla sospensione degli ingressi al Colosseo per circa tre ore nella giornata del 18 settembre. Un decreto che ha di mira, evidentemente, un ulteriore passo verso la delegittimazione dell’iniziativa sindacale e un nuovo attacco al diritto di assemblea, di sciopero e di organizzazione da parte dei lavoratori. Siamo già ben abituati a questi dispositivi di desertificazione politica, di polverizzazione della solidarietà, di squalifica sociale delle lotte. Nel caso in questione – lo sottolinea Massimo Malerba – gli operatori dell’anfiteatro Flavio si erano riuniti per discutere di una condizione di precariato che si trascina da molto tempo, all’insegna del ricatto, di orari massacranti e del mancato pagamento degli stipendi dovuti.
Ciò che colpisce di più, però, è il clima di indignazione e di denuncia che si è rapidamente prodotto a ridosso dell’episodio. Le istituzioni e l’opinione pubblica si sono scagliate con incredibile violenza e con estrema risolutezza contro i custodi del Colosseo riuniti in assemblea, dichiarandoli senza riserve colpevoli di un crimine inaccettabile: quello di aver bloccato migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo dinanzi ai cancelli chiusi dell’anfiteatro, impedendo loro di accedervi. I lavoratori in sciopero hanno cioè illegittimamente eretto una barriera, creato un confine, questa è la grave colpa di cui si sono macchiati, interrompendo così il flusso ineluttabile della libera circolazione dei corpi sul mercato globale della cultura. Un servizio, questo, che secondo Renzi l’Italia sarebbe economicamente e moralmente tenuta a rendere senza soluzione di continuità, e che solo nei termini dell’eccezione e dell’emergenza può essere sospeso.
Libertà e necessità, appunto, o meglio la libertà come una necessità nella narrazione neoliberale cui vengono indicizzati gli apparati dello Stato. Dove il carattere emergenziale dello sciopero e dell’assemblea, dunque, diventa il marchio di qualcosa che non può più essere tollerato e in fondo neppure compreso, perché appare consegnato alla logica dell’eccesso: l’eccesso di ciò che eccede, che deborda, che è in più, ma anche l’eccesso del capriccio, dell’intemperanza, dell’illegalismo di chi si oppone e si organizza. Il premier ha dichiarato con sdegno che è inammissibile negare a migliaia di persone il diritto di varcare la soglia dei nostri musei, di godere di ciò per cui hanno pagato e per cui pagheranno. Perché questo è il nostro piccolo segreto, occorre difendere ad ogni costo le esigenze della circolazione e il desiderio di godimento che essa porta con sé. Se ne fa una questione di diritti e di libertà fondamentali: se i diritti del mercato sono inalienabili, lo Stato non può che intervenire a tutelarli, a renderli sempre più coestensivi alla nostra concezione del diritto in quanto tale, fino a polarizzarla e assorbirla completamente, a costo di relegare nella sfera della criminalità tutto ciò che ne ostacola le correnti, la vitalità, l’espansione. Marx lo aveva capito molto bene, che la forma del diritto e quella della merce sono sorelle. Del resto non ci hanno insegnato che la libertà, il bene più prezioso, non è che assenza di ostacoli e di impedimenti?
 Talvolta la verità si riflette negli specchi che la deformano. In questi stessi giorni, in queste settimane, stiamo assistendo altrove – non troppo lontano – all’erezione di barriere di altro tipo, a migliaia e migliaia di altri corpi bloccati, respinti e confinati. Abbiamo visto la stazione Keleti di Budapest assediata da migranti e polizia, i binari chiusi, i treni sospesi, l’impossibilità di ripartire. In quel caso, però, la logica del pubblico servizio non ci è stata raccontata come subordinata alle insondabili e irresistibili leggi della circolazione. Al contrario, il principio della tutela sovrana e nazionale dei confini, saldamente sostenuto dalle retoriche e dai dispositivi della sicurezza, ha prevalso su quello della libertà e della mobilità. Abbiamo visto poi il filo spinato sulle frontiere ungheresi, migliaia di profughi contenuti dai manganelli di Orbán, i riservisti richiamati a difendere il limes, il governo di Zagabria che ricaccia i migranti verso i paesi vicini. Ma il lessico delle istituzioni e dell’informazione non assomiglia a quello impiegato a proposito dello scandalo del Colosseo. È ancora l’ideologia della necessità a farla da padrone, certo, ma non è più quella necessità che innerva la libertà per imprimerle la forma sacra e perpetua della merce. È invece quella necessità che si erge come un muro invalicabile contro la libertà. Contro la libertà illegale di chi varca i confini, e a tutela della libertà legale di chi sta dentro i perimetri della cittadinanza. La stampa e i governi continuano ad utilizzare il registro della fatalità: le migrazioni come una triste e ingovernabile fatalità; la scelta di fare muro come un’altrettanto triste ma necessaria fatalità; i corpi ammassati sui barconi, affamati alle frontiere, annegati nel Mediterraneo, un’altra terribile, sciagurata fatalità. Il disegno di un Dio malvagio.
Talvolta la verità si riflette negli specchi che la deformano. In questi stessi giorni, in queste settimane, stiamo assistendo altrove – non troppo lontano – all’erezione di barriere di altro tipo, a migliaia e migliaia di altri corpi bloccati, respinti e confinati. Abbiamo visto la stazione Keleti di Budapest assediata da migranti e polizia, i binari chiusi, i treni sospesi, l’impossibilità di ripartire. In quel caso, però, la logica del pubblico servizio non ci è stata raccontata come subordinata alle insondabili e irresistibili leggi della circolazione. Al contrario, il principio della tutela sovrana e nazionale dei confini, saldamente sostenuto dalle retoriche e dai dispositivi della sicurezza, ha prevalso su quello della libertà e della mobilità. Abbiamo visto poi il filo spinato sulle frontiere ungheresi, migliaia di profughi contenuti dai manganelli di Orbán, i riservisti richiamati a difendere il limes, il governo di Zagabria che ricaccia i migranti verso i paesi vicini. Ma il lessico delle istituzioni e dell’informazione non assomiglia a quello impiegato a proposito dello scandalo del Colosseo. È ancora l’ideologia della necessità a farla da padrone, certo, ma non è più quella necessità che innerva la libertà per imprimerle la forma sacra e perpetua della merce. È invece quella necessità che si erge come un muro invalicabile contro la libertà. Contro la libertà illegale di chi varca i confini, e a tutela della libertà legale di chi sta dentro i perimetri della cittadinanza. La stampa e i governi continuano ad utilizzare il registro della fatalità: le migrazioni come una triste e ingovernabile fatalità; la scelta di fare muro come un’altrettanto triste ma necessaria fatalità; i corpi ammassati sui barconi, affamati alle frontiere, annegati nel Mediterraneo, un’altra terribile, sciagurata fatalità. Il disegno di un Dio malvagio.
Qui è la tragedia a dare il passo alla nostra capacità di comprensione del reale. Perché fatale e tragico è il campo di questa lotta epocale per la libertà, dove l’Europa con il cuore infranto e gli occhi gonfi di lacrime si racconta suo malgrado costretta da una legge superiore a costruire barricate, a prendere le armi contro chi le contende gli spazi della vita libera.
Due diverse frontiere, porte chiuse in modi diversi e che mobilitano discorsi diversi. E due modi di costruire, pensare, difendere, obliterare diritti. Perché il confine, come ci è stato efficacemente insegnato, non è qualcosa che sta fermo sui limiti economici e geopolitici delle nazioni, ma è qualcosa che ci portiamo dentro. Dentro casa, dentro il linguaggio, dentro il corpo. Le frontiere non stanno soltanto tra uno stato e l’altro, tra una guerra e l’altra. Fluide, mobili, cotraddittorie, percorrono le strade e le piazze delle nostre città, serpeggiano nel vocabolario del dibattito pubblico, si attaccano agli scudi antisommossa della polizia che doma cortei, respinge opposizioni, incanala dissensi. Confini come questi li abbiamo visti di recente anche laddove si è trattato di pensare il dialogo e l’integrazione tra cittadini e migranti non già sulle soglie della nazione, ma dentro il cuore delle città e dei comuni. Basti pensare ai fatti di Quinto di Treviso, e poi ai manifestanti cui sono state sbarrate le porte della Prefettura e che sono stati trascinati via e arrestati dalle forze dell’ordine. Ma ancora più emblematici, mi sembra, sono stati gli eventi del 17 luglio a Casale San Nicola, in provincia di Roma, dove i residenti ed alcuni militanti neo-fascisti sono stati al centro di violente cariche da parte della polizia, impegnata a difendere una manciata di profughi che erano stati ivi destinati per l’accoglienza. Emblematici, quei fatti, perché in qualche modo sono stati capaci di mettere a nudo la complessità e la contraddittorietà di quei confini che danno forma alle nostre vite, ai modi in cui decidiamo di governarle e di lasciarle governare. Molti degli agenti di polizia intervenuti hanno infatti esitato ad entrare in azione, non se la sentivano di manganellare quelle teste che la pensavano proprio come loro, di colpire coloro che avrebbero preferito invece difendere: cittadini scontenti, residenti delle periferie, razzisti, camerati. Ma come servitori dello Stato non potevano non obbedire agli ordini, alla voce del sovrano che parla dentro di loro – dentro tutti noi – che comanda di impugnare il manganello quando si tratta di neutralizzare ogni claim, ogni agentività concreta da parte dei governati, siano essi lavoratori in sciopero o fascisti in rivolta. Del resto gli stessi residenti di Casale hanno lamentato l’intrusione non gradita da parte di Casa Pound e la strumentalizzazione della loro protesta. Un altro confine instabile.
È la schizofrenia costitutiva di quel simulacro che chiamiamo cittadinanza ad emergere qui in trasparenza, ma anche la schizofrenia dello Stato stesso, del sovrano che piega il capo dinanzi alla ragione governamentale del mondo e alle leggi del mercato (leggi che prendono in carico e definiscono le traiettorie della circolazione dei soggetti), ma che ad un tempo non esista a creare muri e confini per bloccare e dislocare le forze in eccesso. Ed è proprio su tutti questi confini, mi sembra, che tra il migrante e il cittadino dovrebbero prodursi le condizioni del reciproco riconoscimento, della cooperazione e dell’alleanza. “Non è lo Stato a comandarci ma siamo noi a comandare lo Stato!! Basta volerlo”, scrive qualcuno in un commento sulla pagina web di Casa Pound, solidale con i fascisti picchiati dalla polizia. Dichiarazione reazionaria e concettualmente assai confusa – sul volere astratto dei governati è stata costruita storicamente proprio la macchina della sovranità capace di monopolizzare la violenza legittima – ma tuttavia capace di rilevare, perfino a destra, lo sfrangiarsi sempre più evidente e drammatico del quadro di rappresentazione dello Stato nella misura in cui da un lato non è in grado di offrire una risposta soddisfacente alle politiche dei governati, e dall’altro è inesorabilmente stretto nella morsa di un’agenda governamentale non più pensabile attraverso le forme della legittimazione. Uno Stato, cioè, che non ci fornisce gli strumenti per comprendere, vivere e attraversare le norme e i confini che esso ora produce, ora abbatte, ora trasforma, ora riassorbe e subisce. “Abbiamo reagito solo quando abbiamo visto che la polizia picchiava le donne”, hanno dichiarato i fascisti di Casa Pound a proposito delle cariche del 17 luglio. Perché c’è appunto una rigida gerarchia di segni che percorrono le anime e i corpi; i corpi forniti di buoni passaporti e quelli che non ce l’hanno, ad esempio. Ma allo stesso modo non si può certo toccare una donna per difendere un negro, per i fascisti. Il corpo della donna, come sempre, che diventa campo di battaglia, arma retorica, bandiera che sventola “qual piuma al vento”, e che ora viene appropriato dal discorso razzista e fatto giocare contro i corpi dei migranti. Appena pochi giorni fa – a proposito dello scandalo della coppia omosessuale che negli Stati Uniti ha rifiutato il bambino di colore frutto di un errore della banca del seme – l’informazione conservatrice ha fatto invece appello proprio ad un antirazzismo patinato e di seconda mano per giustificare il proprio livore omofobo e misogino. Confini. Ma i confini sono friabili, porosi, carsici, estremamente duttili.
 E, soprattutto, i confini hanno una incredibile capacità di ricomposizione, di resistenza, di ibridazione. Riescono a stare insieme anche quando sembrano escludersi a vicenda. Basti pensare ad un’altra schizofrenia, cioè alla contraddizione – quantomeno apparente – tra le politiche comunitarie e quelle degli Stati membri. “Io difendo i confini dell’Europa” ha sostenuto Orbán a Bruxelles, rispondendo alle accuse mossegli in seguito al blocco delle frontiere ungheresi, ma cogliendo a mio avviso anche un punto essenziale dei processi di cui ci troviamo ad essere investiti. Perché se Vienna e Berlino hanno temporaneamente aperto le porte ad alcune migliaia di migranti che costituiranno una fonte preziosa di manodopera qualificata (si stima che la Germania abbia bisogno di circa 5 milioni di persone da impiegare come forza lavoro), non è però possibile immaginare che si deroghi ai meccanismi di smistamento, filtraggio, blocco ed espulsione che caratterizzano sempre di più le frontiere della cittadinanza europea e del suo progetto di integrazione dei mercati. Merkel, sotto la spinta del governo della Baviera, ha già prontamente sospeso in via temporanea l’applicazione di Schengen, tornando a chiudere quelle porte che erano state provvidenzialmente aperte. Il rozzo nazionalista Orbán in fondo ha fatto un buon lavoro. Sul fronte della produzione, delle difesa e della gestione dei confini, attraverso le loro funzioni di presa in carico differenziale di corpi, capitali e lavoro, l’Europa sembra essere più che mai unita, più che mai perfettamente coordinata.
E, soprattutto, i confini hanno una incredibile capacità di ricomposizione, di resistenza, di ibridazione. Riescono a stare insieme anche quando sembrano escludersi a vicenda. Basti pensare ad un’altra schizofrenia, cioè alla contraddizione – quantomeno apparente – tra le politiche comunitarie e quelle degli Stati membri. “Io difendo i confini dell’Europa” ha sostenuto Orbán a Bruxelles, rispondendo alle accuse mossegli in seguito al blocco delle frontiere ungheresi, ma cogliendo a mio avviso anche un punto essenziale dei processi di cui ci troviamo ad essere investiti. Perché se Vienna e Berlino hanno temporaneamente aperto le porte ad alcune migliaia di migranti che costituiranno una fonte preziosa di manodopera qualificata (si stima che la Germania abbia bisogno di circa 5 milioni di persone da impiegare come forza lavoro), non è però possibile immaginare che si deroghi ai meccanismi di smistamento, filtraggio, blocco ed espulsione che caratterizzano sempre di più le frontiere della cittadinanza europea e del suo progetto di integrazione dei mercati. Merkel, sotto la spinta del governo della Baviera, ha già prontamente sospeso in via temporanea l’applicazione di Schengen, tornando a chiudere quelle porte che erano state provvidenzialmente aperte. Il rozzo nazionalista Orbán in fondo ha fatto un buon lavoro. Sul fronte della produzione, delle difesa e della gestione dei confini, attraverso le loro funzioni di presa in carico differenziale di corpi, capitali e lavoro, l’Europa sembra essere più che mai unita, più che mai perfettamente coordinata.