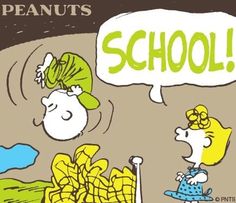Di GIROLAMO DE MICHELE
Due eventi pubblici fra ottobre e novembre, il “Festival della partecipazione” (Bologna, 16-18 ottobre) e gli “Stati generali della scuola digitale” (Bergamo, 27 novembre) hanno messo in luce, fra i molti e differenziati contenuti, un ruolo della scuola nel contesto della crisi economica e pandemica che rischia di passare inosservato dalla pubblica opinione e dalla stampa mainstream: la scuola come destinatario di fondi europei, dal Recovery Fund-NextGenerationEU al MES (forse). Si tratta dell’ultimo lascito, della coda avvelenata dell’autonomia scolastica – o del modo in cui è stata, non certo casualmente, intesa e attuata: la scuola, priva della protezione di un effettivo sistema d’istruzione nazionale pubblico (gli stessi insegnanti sono soggetti a un contratto di diritto privato, grazie alla riforma Bassanini), e quindi di un sistema di finanziamento pubblico, anche per lo spezzettamento dello Stato in enti locali, si trova indifesa davanti all’assalto che il settore privato, talvolta formalmente indistinguibile dal “pubblico” (grazie al principio di sussidiarietà) porta ai suoi fondi. La novità consiste nel fatto che, dopo essere per anni stata depredata, la scuola si trova oggi a essere possibile destinatario di risorse: che, al di là delle formule retoriche, richiedono decisioni esplicite sulle destinazioni. In altri termini, si tratta di decidere, in base a quale idea di scuola si propone, quale sarà la scuola del futuro.
La crisi ha messo in luce debolezze croniche e strutturali della società in quasi tutti i settori. Fra questi, non fa certo eccezione il cosiddetto Terzo Settore, quell’area dai confini labili che va dal volontariato e dalle cooperative più o meno virtuose, fino, al limite ma non troppo, a realtà come FICO. Terzo Settore che, sotto i colpi delle politiche di austerity, ha (con eccezioni) scelto di limitare i danni approfittando delle esternalizzazioni, senza distinzione di colore politico delle giunte locali, invece di fare massa critica con i settori colpiti dai tagli alla spesa pubblica. E che adesso, attraverso i “patti territoriali”, mira ad attingere alla scuola e ai suoi progetti, in quell’area grigia che è l’ex alternanza scuola-lavoro, ora PCTO. In questo caso la formula d’uso è che “la scuola da sola non ce la può fare”: attraverso progetti scolastici proiettati sul territorio, si mira a delocalizzare fette di didattica, sub-appaltandone l’effettuazione a personale in genere privo di titolo didattico, ma il possesso di estemporanee “competenze”. Che poi competenze effettive, acquisite in anni di insegnamento, non siano riconosciute ai docenti precari in nome del mito del “concorso pubblico”, è solo uno dei tanti paradossi di una scuola priva di una direzione politica, e perciò soggetta a sbandamenti eterodiretti da portatori di interessi privati: proseguendo nei fatti il processo di decostituzionalizzazione in atto da tempo.
Meno suadenti e amichevoli, e più esplicite, le intenzioni di chi, da Confindustria ad Assolombarda ai gruppi imprenditoriali, da Epson ad Acer, passando per associazioni tecnocratiche come Impara Digitale e Base Italia, fino ai referenti politici bypartisan (a Bergamo il padrone di casa non certo disinteressato era Giorgio Gori) punta all’istituzionalizzazione della didattica digitale. Considerazione non secondaria, che vale a spiegare la durezza di certi interventi: si è vista in disinvolta opera la catena di comando che a fine febbraio lanciò lo slogan delle riaperture – “Bergamo, Milano, Lombardia riapre” – con per esito quello che Zerocalcare ha definito “un’operazione d’ingegneria demografica che passerà alla storia come Il Grande Sterminio dei Vecchi del 2020“, dai mandanti (Assolombarda, nella persona del suo vicepresidente Guindani) agli esecutori (Gori, sindaco della Bergamo che doveva riaprire).
Nessuno dei responsabili di quelle scelte scellerate si è dimesso: e adesso eccoli lì a parlare di scuola, un po’ come se Lady MacBeth fosse assunta come consulente al MIUR. Che la scuola sia stata in grado di reggere l’urto della quarantena, compiendo dall’oggi al domani un aggiornamento professionale impensato e impensabile, stante le caricaturali rappresentazioni del personale scolastico che per anni sono circolate, passa rapidamente in cavalleria. Così come viene bypassata la constatazione che la didattica digitale (come ha argomentato Tito Boeri, l’unico a fornire dati documentati e verificabili) sostitutiva della didattica in presenza, ha abbassato il livello degli apprendimenti e creato un pericoloso gap, che rischia di proiettarsi nel futuro se la scuola rimarrà “a distanza”, nonostante i dati dimostrino che le scuole non sono state focolai di contagio, come ha ancora sostenuto Boeri, che in quel contesto è apparso un pericoloso estremista.
Con agile sillogismo, si premette che i limiti della didattica digitale sono emersi perché si è voluto fare con essa quello che faceva la didattica in presenza; ne consegue, con un capovolgimento dei termini, che con la didattica a distanza si deve fare solo ciò che essa è in grado di fare. La conclusione, sottintesa, è che quel differenziale fra didattica in presenza e didattica digitale, non potendosi effettuare a distanza, deve cadere. Da questo sillogismo consegue che, in primo luogo, i fondi europei devono concentrarsi sull’innovazione digitale, dunque sull’impresa che deve sedere ai tavoli di concertazione fra enti locali e scuole, piuttosto che in edilizia, stabilizzazione del personale, didattica in sicurezza, spazi didattici adeguati, recupero dei tagli al personale e al finanziamento della didattica degli ultimi 10 anni. In secondo luogo, ne segue che la digitalizzazione deve concretizzarsi in un allargamento illimitato del lavoro cognitivo e intellettuale, che grazie alle connessioni “in orari inconsueti”, “da cui non si potrà tornare indietro” può avvenire h24, superando la scansione istruzione / lavoro / pensione in favore di un’istruzione digitale long life. Quanto all’allargamento della forbice sociale, sarà la stessa innovazione a riequilibrare le discriminazioni: una distribuzione degli strumenti digitali più ampia consentirà alle donne di conciliare vita familiare e lavorativa (così Gori, il nuovo che avanza nel PD).
La scuola deve quindi essere attraversata da cambiamenti di lungo periodo per “favorire il match fra domanda e offerta”: orientamento fin dalle scuole medie in favore dell’istruzione professionale, miglioramento della conoscenza del lavoro con l’alternanza scuola-lavoro (così Guindani), percorsi universitari differenziati con laurea breve professionalizzante. La scuola, insomma, deve assumersi l’onere della formazione all’impresa, in altri termini di fornire manodopera minorile a costo zero al mondo industriale: ma questa formazione non deve pesare sull’impresa, ma essere finanziata con i fondi europei. Confindustria e Assolombarda – ma anche Bentivogli, per il quale il sistema di istruzione è “l’ultimo residuo del fordismo da smantellare” – non hanno mutato lessico: lo squalo ha i denti, così come Meckie Messer ha il coltello, diceva Brecht. Nei giorni in cui il lancio della “Netflix della cultura” apre scenari inquietanti per la circolazione di quella cultura che la scuola si ostina a voler contribuire a creare, la ripartizione dei fondi nella bozza di #NextGeneration Italia spiega molto, se non tutto: 9.8% per “Istruzione e Ricerca”, quasi la metà dei quali “Dalla ricerca all’Impresa”, contro il 24.9% per “Digitalizzazione Innovazione Competitività e Cultura”. È bene saperlo, e sapersi regolare.
questo testo è pubblicato anche sul manifesto con titolo “Scuola e impresa: il non detto del fondo Next generation Eu”