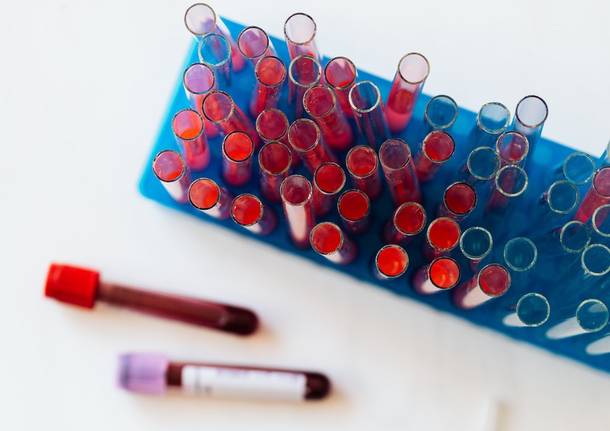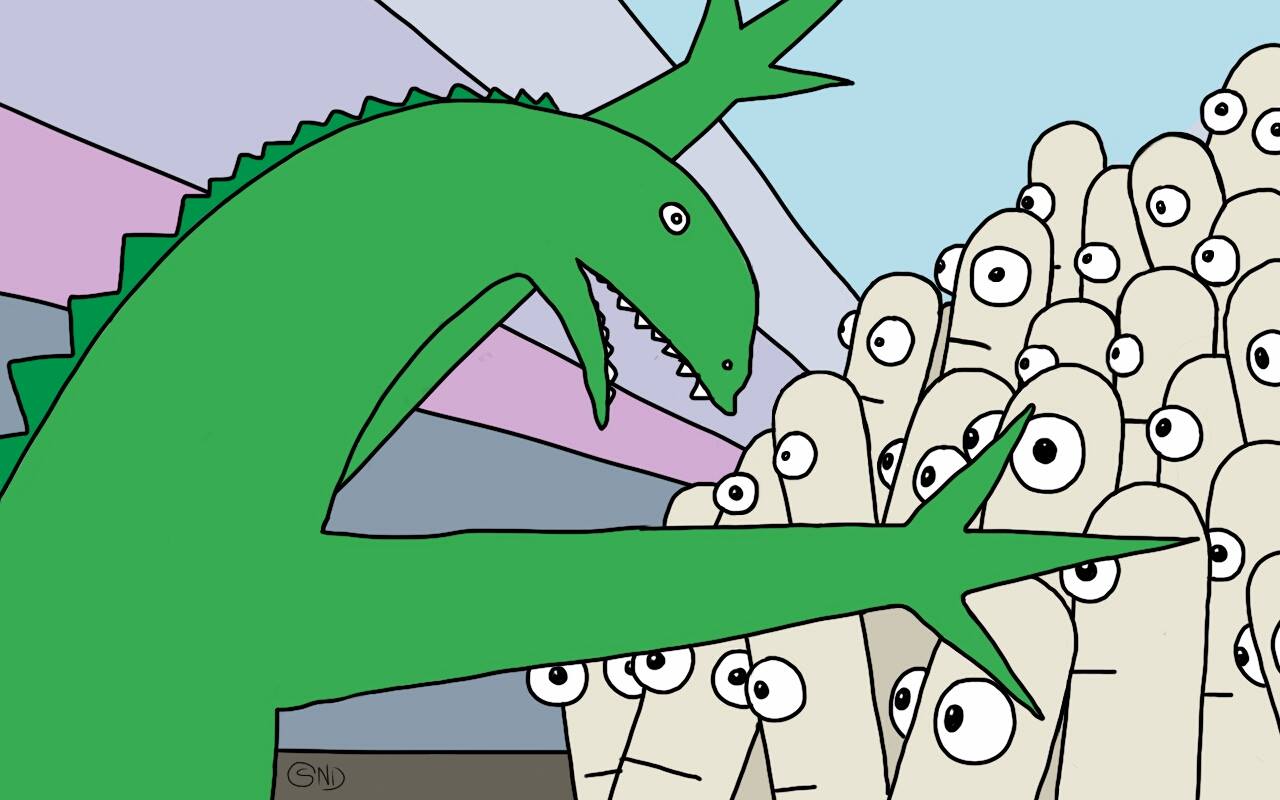Di MARCO BASCETTA
Stando alla definizione che ne da il suo premier Mario Draghi, a guidarci in questo anno secondo della pandemia sarà un governo senza aggettivi. Il governo in quanto governo, una funzione, una struttura decisionale, un sistema di neutralizzazione delle spinte centrifughe, una centrale operativa. Converrà prenderla sul serio questa definizione. E dunque, senza attardarsi nel giudicare le forme politiche sempre piuttosto truffaldine e ipocrite dell’“unità nazionale”, rivolgere l’attenzione alle trasformazioni di lungo periodo che il nuovo premier si accinge a incardinare. Alle operazioni e agli strumenti che a questo scopo verranno messi in campo.
Non poteva esserci contesto migliore della crisi pandemica per testare in tutti i suoi risvolti un vasto programma di riforma del capitalismo europeo che vede al suo centro la grande riconversione energetica. Uno “stress test” in grado di misurare dal livello di disciplina della cittadinanza al grado di sopportazione delle categorie economiche, dal congelamento del conflitto sociale all’affidamento nei confronti dei governanti, indipendentemente dal loro colore e dalla loro storia. Riducendo al minimo il ritmo delle interazioni sociali, il virus ha trasformato l’intera società in una cavia da laboratorio. O, se si preferisce, in un paziente del cui male ignoto si sperimentano le cure. E questo già durante l’esperienza del precedente governo che, per gran parte della sua esistenza, si è di fatto confuso con la “cabina di regia” impegnata nell’affrontare l’emergenza epidemica.
La pandemia non è stata la causa della riconversione sempre più veementemente predicata dalle economie forti dell’Unione europea, ma funziona da acceleratore e soprattutto determina il clima psicologico e sociale adatto ad abbattere le resistenze e a conquistare i favori dell’opinione pubblica. A differenza dal passato, l’urgenza riformista non appare determinata da un alto tasso di conflittualità sociale, ma da una competitività globale non incalzata dalle lotte di classe. La lamentata eclissi della politica a vantaggio della tecnocrazia non è che il rispecchiamento di questo fenomeno tutt’altro che impolitico.
Questa competizione globale ruota intorno a una radicale riconversione energetica e l’Unione europea, ossessionata dal culto tedesco del pareggio di bilancio e della sicurezza finanziaria, rischiava di rimanere indietro, per non parlare del dissestato capitalismo italiano. Covid 19 ha dato una mano a neutralizzare i falchi del risparmio che già non godevano più di ottima salute. Dal dogma che voleva ogni debito pubblico irrimediabilmente “cattivo” (l’epoca della crisi greca e del governo Monti) siamo passati ad ammettere anche l’esistenza di un debito “buono”. Mario Draghi e la sua politica alla testa della Bce hanno aperto la strada a questo passaggio.
Ma se al “debito cattivo” si rispondeva piuttosto rozzamente con i tagli, i ricatti, il terrorismo finanziario, le svendite e le privatizzazioni, quando si tratti di contrarre debiti “buoni” serve un potere pienamente radicato nel progetto di riconversione europeo, capace di sottrarsi a pressioni corporative e di esercitare un efficace controllo sociale. Fronteggiare la sofferenza sociale quando le risorse vengono negate è un conto, farlo mentre si spende e si investe è tutt’altra e ben più delicata questione.
Quando si parla di industrie decotte, di imprese obsolete, di attività fuori gioco, non si parla di poca cosa ma, nei tempi non più lunghissimi della riconversione energetica, di intere filiere produttive, di centinaia di migliaia di posti di lavoro. A meno di schierarsi tra i negazionisti della crisi ecologica e del cambiamento climatico non è possibile assumere posizioni puramente conservative di forme del lavoro divenute insostenibili sul piano oggettivo come su quello soggettivo. Qualunque “progressismo” e comunque lo si voglia connotare nel bene e nel male, quindi anche Draghi, si colloca dentro questa prospettiva.
Che il vecchio lavoro possa essere interamente sostituito dal nuovo, che la green economy sia destinata a riassorbire l’esercito mobilitato dalla rivoluzione industriale è una promessa decisamente illusoria. Tutta la parabola del postfordismo e dell’innovazione tecnologica ha ampiamente dimostrato come questo travaso della vecchia occupazione nella nuova non sia avvenuto e non potesse avvenire. Già solo perché una più grande ricchezza viene oggi prodotta con molto minore impiego di lavoro salariato. Il “debito buono” difficilmente riuscirà a compensare gli “scarti” prodotti dalla rinuncia al “debito cattivo”.
Si può anche ricondurre a quest’ultima definizione il dispendioso mantenimento di forme di lavoro divenute frustranti e improduttive, ma non certo un welfare di carattere universalistico che garantisca le condizioni di una riproduzione e di una cooperazione sociale libera, autonoma e autorganizzata che vive e produce dentro e fuori dal mercato del lavoro. Per la quale svolge una funzione decisiva il reddito di cittadinanza, allargato e riformulato tuttavia rispetto all’impostazione moralistica e ricattatoria conferitagli dall’M5S, in grado di sostituirsi alla logica corporativa dei bonus e dei “ristori” limitati ed emergenziali.
Quale opposizione saprà misurarsi con le politiche di spesa di questo governo e con i dispositivi di controllo sociale che le accompagneranno non è dato vedere. Il punto di vista critico va semmai costruito fuori dall’orizzonte esausto delle forze politiche.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 25 febbraio 2021.