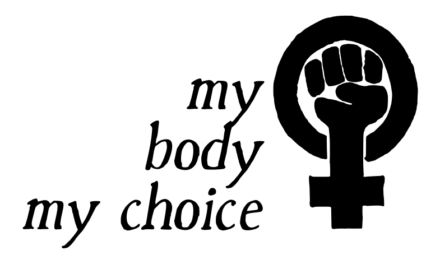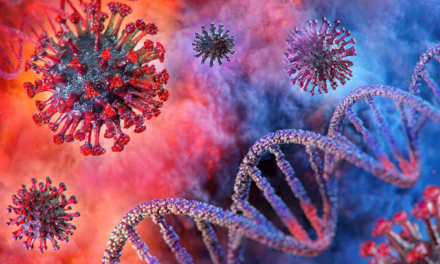Di ALESSANDRO TERRA.
Nelle ore successive alla notizia del disimpegno di Arcerol Mittal, la solfa della politica e del mondo sindacale ha ruotato attorno alla salvaguardia dei posti di lavoro e (soprattutto) alla difesa della credibilità del sistema Paese. La retorica della difesa dell’insediamento produttivo di Taranto – considerato strategico per la sopravvivenza del settore manifatturiero nazionale e per la salvaguardia dei livelli occupazionali in un Mezzogiorno sempre più impoverito e svuotato dalle migrazioni – si è scontrato però con due elementi. Il primo è la rapacità delle multinazionali e, più in generale, delle logiche che governano il mercato (in questo caso dell’acciaio). La classe dirigente nazionale ha scoperto che non esiste più nessun vincolo di obbedienza tra mercati e governi nazionali. Il liberismo della globalizzazione, contestato dai movimenti sociali a cavallo tra il vecchio e il nuovo millennio, ha mostrato per intero la sua natura anarchica. Il secondo elemento è invece tutto politico e viene da Taranto, dalla sala del consiglio di fabbrica in cui è avvenuto il confronto tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i sindacati e gli operai.
Quando una «tuta blu» ha preso la parola e ha chiesto la chiusura delle fonti inquinanti, la bonifica e un accordo di programma sul modello di quello riservato allo stabilimento di Genova, il presidente Conte lo ha ascoltato con attenzione. Le prime file dei presenti (occupate da dirigenti e rappresentanti sindacali) sono rimaste impassibili, mentre dalle retrovie scrosciavano gli applausi. Sotto gli occhi del Premier si è manifestata per la prima volta la saldatura tra i movimenti ambientalisti e gli operai. Quello che nel 2012 sembrava un miraggio, oggi, seppur in una forma non definitiva, ha iniziato a prendere forma. La crisi del sindacato è sintetizzata in quei pochi frame che evidenziano la distanza tra chi lavora negli impianti e chi dovrebbe rappresentarli, quel sindacato che ha dimenticato che il tema della salute è patrimonio delle inchieste operaie. Andrebbe ricordata ad esempio l’esperienza di Medicina Democratica nella costituzione dell’Associazione italiana degli esposti all’amianto (Aiea) a Casale Monferrato. Se oggi in Italia c’è una legislazione avanzata su questo tema, lo si deve al lavoro comune portato avanti da medici e lavoratori.
A Taranto le cose però sono andate diversamente. Il sindacato confederale si è ritrovato a chiedere lo scudo penale per i padroni della fabbrica in cambio dei posti di lavoro. Uno schema che ha riprodotto e legittimato la subalternità a cui la politica nazionale ha condannato il Mezzogiorno, che si basa su un semplice assunto. In cambio di qualche salario, il Sud può essere sistematicamente depredato, stuprato e avvilito. Salvo poi riscoprirne la centralità quando rischia di mettere in crisi il settore manifatturiero, del Nord. Nessuno – tra leader politici, sindacalisti e opinionisti – si era mai posto il problema della messa in discussione di questa formula. E nessuno nei partiti (tutti) sembra prendere sul serio quello che la città sta chiedendo. Taranto è la prima comunità in Italia che sta mettendo fortemente in discussione i rapporti di produzione a partire dai diritti riproduttivi, intendendo come tali il diritto alla riproduzione della vita, alla sua sostenibilità all’ interno di un territorio.
Questo tipo di rivendicazione si inserisce nella tradizione delle lotte operaie e del lavoro, pari del diritto alle ferie retribuite o alla maternità. A Taranto, però, queste rivendicazioni vanno oltre il perimetro del lavoro. Invadono la società.
Le rivendicazioni dei cittadini sono le stesse che stanno mobilitando milioni di persone nel mondo per gli scioperi climatici, che esprimono l’urgenza di un cambiamento dei rapporti di produzione a livello globale. Quella sensibilità che oggi esprimono giovanissimi ragazzi e ragazze in giro per il mondo è la stessa di chi partecipò – come chi scrive, poco più che ventenne – al primo corteo di AltaMarea nel novembre del 2008. Taranto non ha anticipato i temi posti da Greta per particolare capacità predittiva delle tendenze politiche, ma perché le contraddizioni di quel modello di sviluppo le abbiamo tatuate addosso. In particolare, chi, come la quasi totalità della mia generazione, dalla fabbrica non ha ricevuto niente, se non malattie e morte.
La città con il reddito pro-capite più alto del Mezzogiorno, la Milano del Sud, la crescita demografica, ma anche le sezioni di fabbrica, i circoli dove gli operai facevano teatro e vedevano gli spettacoli dei più grandi attori italiani, sono racconti sempre più sbiaditi di un mondo che non c’è più, che non è mai appartenuto alla nostra generazione e che si fa fatica a credere sia mai esistito alla luce delle macerie che invece abbiamo davanti. Un mondo che già allora portava con sé delle storture, fotografate da Antonio Cederna in due inchieste scritte per il «Corriere della Sera» nel 1972 e recentemente riprese da Girolamo De Michele come incipit del suo nuovo romanzo ambientato a Taranto («Le cose innominabili», Ed. Rizzoli). Se da un lato quindi il dibattito in città negli ultimi dieci anni ha fatto passi da gigante, la politica è rimasta ferma, delegando la soluzione di un problema enorme a una multinazionale che ora sembra pronta a fare le valigie e ad andare via senza salutare. Mentre tutti cercano di trattenerla, a quanto pare invano. Ammesso che Arcelor Mittal fosse costretta dalla magistratura a rispettare il contratto e a tenere attivo lo stabilimento di Taranto, quale fiducia potrebbero mai lavoratori, cittadini, governi e sindacati riporre nell’azienda? Se il rapporto è compromesso e viene paventato il ritorno al commissariamento, è possibile che il Governo autoproclamatosi del Green New Deal temporeggi in attesa di un nuovo acquirente (ammesso che vengano bloccate le procedure di spegnimento dell’area a caldo)? Perché, invece, non aprire una partita in merito alla chiusura dello stabilimento e alla conversione ecologica? Possiamo avere l’ambizione di scrivere una nuova storia e fissare altri obiettivi o dobbiamo essere schiavi dello spauracchio della nuova Bagnoli e continuare a ingoiare amaro e a morire per il prodotto interno lordo? L’Italia è il Paese delle grandi opere incompiute, se non inutili (dal Tav al Mose). Pensare a un investimento di svariati miliardi di euro per bonificare e riconvertire l’area dello stabilimento siderurgico di Taranto comporta una serie di rischi. Ma vale probabilmente la pena di correrli, se l’alternativa è l’immobilismo o il ricatto perenne in nome di un’ambientalizzazione tecnicamente ed economicamente impossibile. La palla a questo punto passa nelle mani della città. Imporre nel dibattito pubblico il tema della riconversione e degli investimenti a essa legati non è affare delegabile a nessuno degli attori politici e sindacali in campo.
Taranto adesso ha l’opportunità di discutere e decidere il suo futuro dopo l’imposizione dall’alto dei processi di industrializzazione che tra la fine dell’800 (cantieristica navale e Arsenale) e gli anni Cinquanta del ‘900 (Italsider) ne hanno definito l’assetto attuale. Il quarto sciopero climatico del 29 novembre, undici anni dopo quel primo corteo di AltaMarea, potrebbe essere l’occasione di mostrare una città determinata a cambiare il destino a cui è stata condannata. Alcune realtà sindacali di base hanno già proclamato lo sciopero generale, non è ipotizzabile che le sigle confederali facciano lo stesso. Sarà compito di tutte le realtà associative, dei comitati e dei collettivi studenteschi lavorare affinché si determini una grande mobilitazione in grado di aprire un tavolo di trattative. L’unico davvero utile, tra Governo e città.
Questo articolo è stato pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno il 19 novembre 2019.