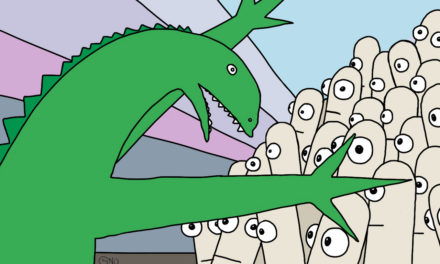pubblichiamo il seguito della corrispondenza da Macerata, la cui prima parte è qui
«Se uno è stato affetto da un altro, appartenente a una classe o nazione diversa dalla sua, con gioia o tristezza accompagnata come causa dall’idea di quello sotto la denominazione universale della classe o della nazione, egli amerà o odierà non soltanto lui, ma tutti quelli che appartengono alla stessa classe o nazione» (B. Spinoza, Etica 3 P46)
Lo sviluppo conflittuale delle reazioni ai fatti di Macerata non è la conseguenza di conflitti nuovi. È l’effetto della strumentalizzazione politica della violenza di genere e della xenofobia durante la campagna elettorale. I pezzi del corpo di Pamela continuano a tirarseli da una parte all’altra come se fossero diventati il pallone della partita di calcio alla quale è stata ridotta la discussione politica sulla migrazione: o tifi bianco-italiano oppure i neofascisti ti trattano come trattano i neri, i musulmani, le persone LGBTI+ e tutte le donne che non rientrano nel loro canone di donna da possedere. Determinatissime continuano a essere le risposte del blocco antifascista in ogni città d’Italia dove le guardie inviate dal ministero dell’interno proteggono i comizi elettorali dei neofascisti anziché schierarsi dalla parte chi tenta di impedire la rivalsa dell’eredità di un passato del quale, in teoria, non si avrebbe più neanche il diritto di parlare se non per scongiurarne il ritorno.
2. Gli antifascismi, la manifestazione di Macerata, il risentimento xenofobico e quello xenofilo
La prima parte di questo lungo testo fornisce dati etnografici e anche autoetnografici per dare l’idea del risentimento che, accumulato nel corso del tempo, caratterizza alcune delle categorie sociali che abitano l’entroterra marchigiano. Tra gli elementi descritti spero di essere riuscita a farne emergere alcuni che possano rendere l’idea degli sforzi compiuti per sublimarlo in desiderio di rivalsa. Anche con questa seconda parte intendo contribuire al dibattito sulla politica degli affetti ma, a questo punto della discussione, ritengo necessario mettere in chiaro perché, secondo me, l’antifascismo non può non essere razionale. Con l’aggettivo razionale intendo introdurre il discorso sulla necessità di liberarsi proprio da quel risentimento che ho tentato di descrivere, nella misura in cui si tratta del sentimento fondamentale che permette la strumentalizzazione di paura e odio e, per estensione, permette la strumentalizzazione di politiche razziste e securitarie al fine di legittimare politiche neoliberali ispirate da una morale neoschiavista. La diffusione di odio profondo e paura condivisa è un dato di fatto innegabile e, a maggior ragione, l’antifascismo non può non mirare ad altro che alla sublimazione di odio e paura in passioni attive tali non solo da scuotere i qualunquisti dall’immobilismo e dall’indifferenza ma anche i risentiti dalla competizione che impedisce la condivisione equa di risorse e libertà. Alla luce di questo preambolo, è chiaro perché la manifestazione del 10 febbraio a Macerata ha contribuito a riscattare parte della popolazione locale dalla rappresentazione parziale e distorta che è emersa nella scena mediatica, dominata dal revisionismo storico e dalla polemica sui cori.
Chi propone scelte narrative intenzionalmente riduzioniste nega la molteplicità che caratterizza l’identità delle Marche come delle altre regioni d’Italia, ovvero un’identità che non può assolutamente essere racchiusa nella dicotomia che pone i trainiani da un lato e i caranciniani dall’altro. Parte della popolazione locale è infatti scesa in strada insieme alle altre migliaia di persone che hanno risposto all’appello degli organizzatori per ribadire che era e continua a essere antifascist* e antirazzist*. Anche nel locale, l’antifascismo contemporaneo affonda le radici in una tradizione globale segnata dalla transnazionalità della resistenza partigiana. A questo proposito la ricerca dello storico maceratese Matteo Petracci sulla partecipazione straniera alla resistenza antifascista nel maceratese è interessante, perché la figura di Carlo Abbamagal spicca tra gli altri partigiani non italiani proprio per il colore della sua pelle. Penso però che siamo in tant* a condividere l’idea che ispirarsi al passato sia importante ma non sia sufficiente, a patto di condividere l’idea che l’antifascismo avrebbe bisogno di essere adattato ai principi dei movimenti antifascisti contemporanei, dai femminismi al movimento per i diritti dei migranti passando anche per l’antimilitarismo. Mi chiedo dunque: che significati assume oggi l’antifascismo?
L’antifascismo ha bisogno di inventare linguaggi e metodi comunicativi nuovi, anziché limitarsi a tentare di riappropriarsi di quelli che i neofascisti gli stanno già rubando o gli hanno già rubato. Concetti come razzismo e terrorismo vengono risignificati e strumentalizzati a mo’ di boomerang. Il concetto di razza viene fatto coincidere con quello di nazione (in questo caso italiana), mentre il concetto di migrante viene ridotto a quello di straniero nemico. Per questo penso che oggi l’antifascismo non possa permettersi di riproporre simboli, seppur risignificati, che richiamano al patriottismo, nonostante la patria dei partigiani fosse il mondo intero. Come “terra dei padri”, il concetto di patria è troppo carico di significati che si rifanno all’idea che il mondo sia un bene comune che però ci tramandiamo come se l’eredita del concetto di proprietà patriarcale non fosse già abbastanza problematica di per sé. Tanto più che sono proprio i neofascisti a rivendicare la proprietà sulle donne bianche che pretendono di difendere solo nel caso in cui a minacciarle sia lo straniero nero e/o musulmano. Se ne fossimo tutt* pienamente consapevoli, non ci sarebbe neanche il bisogno di ripeterlo che le rivendicazioni dei trainiani non hanno nulla a che vedere con la lotta quotidiana per l’autodeterminazione delle donne. Anzi, è palese che si tratta solo della riprova che il maschio italico tenta di rivendicare il proprio diritto di proprietà sulla terra ereditata dai propri padri e sulle donne che la abitano, bianche e a capo scoperto o nere e velate che siano.
Oltre all’abbandono di simboli patriottici che rimandano necessariamente al significato tradizionale di nazione, l’antifascismo ne richiede anche altri di accorgimenti. Ad esempio penso che la spettacolarizzazione della guerra sia controproducente, perché rischia di condurre al feticismo. Non penso che le armi non possano essere usate laddove strettamente necessario, ma non penso ci sia bisogno di romanticizzarle, perché non trovo molto coerente riempire i programmi politici di antimilitarismo e allo stesso tempo far circolare foto di brigate internazionali con le armi in spalla. Lo dico solo per rispetto di chi veramente si dichiara obiettore di coscienza e anche alla luce della recente proposta di Macron di reintrodurre il servizio di leva obbligatorio. Sono consapevole anch’io del posto riservato nella memoria collettiva alla classica foto delle donne partigiane con il fucile in mano, ma penso che le immagini di donne che lottano per la propria liberazione e per la liberazione dei propri territori sono potenti di per sé, anche senza la messa in mostra dei fucili. Ad essere potenti sono quelle donne e i fini che perseguono, non il mezzo che usano.
A meno che non pensiate che le immagini di Tess Asplund in Svezia o delle donne che in Iran si tolgono il velo e lo sventolano appeso ad un bastone non siano tanto potenti quanto le immagini delle donne che combattono in zone di conflitto armato o delle migliaia di altre donne che riempiono le strade di molte città nonostante la repressione e il clima di terrore che le caratterizza. A tutte queste donne il partigiano oggi non può più permettersi di dire “ciao, bella”, a meno che pensiate che sia giusto che le lasci a casa ad aspettare che torni lui, vivo o morto per la libertà. In altre parole, l’antifascismo non può permettersi di essere machista perché, senza nulla togliere all’efficienza del servizio di sicurezza della Fiom, di donne che trovano il coraggio di mettere il proprio corpo a difesa di quello delle altre e degli altri ce ne sono già.
Anch’io che, ad esempio, non sono così audace, riconosco che sono ancora troppo poche, ma allo stesso tempo non posso non riconoscere che sono talmente audaci che chi si dichiara antifascista non ha nessun diritto di sminuirle facendo paragoni tra loro potenza e quella delle donne del Rojava, anche perché ancora troppe sono le donne e le persone LGBTI+ che combattono quotidianamente per la sopravvivenza nonostante non abbiano a disposizione né fucili da imbracciare né fotoreporter che le immortalino a casa propria o altrui prima che siano brutalmente ammazzate e perfino fatte a pezzi. Magari potremmo pensare di scriverne uno nuovo di canto antifascista, consapevol* che “le tradizioni inventate” (Hobsbawn, 1983) non sono necessariamente tutte da buttare. Magari potrebbe ispirarsi proprio allo slogan delle donne che combattono in Rojava: “Jin, jiyan, azadi” (“donna, vita, libertà”).
 Infine, penso che l’antifascismo abbia bisogno anche di profonda consapevolezza del ruolo della leadership, ma la reazione delle varie sezioni dell’A.N.P.I. e dei movimenti che hanno partecipato alla manifestazione a Macerata ha mostrato chiaramente che non si obbedisce a leader istituzionali che tentano di rappresentare l’irrappresentabile anziché farsi portavoce di decisioni prese in conformità a dinamiche ispirate dal principio della decentralizzazione, soprattutto date la gravità del caso e l’urgenza della situazione. A questo punto penso che sia importante elencarli ancora una volta i motivi per i quali non c’è nessuna manipolazione politico-mediatica che tenga, perché’ è innegabile che la manifestazione di Macerata abbia raggiunto gli obiettivi prefissi sia da chi l’ha organizzata sia da chi l’ha resa possibile.
Infine, penso che l’antifascismo abbia bisogno anche di profonda consapevolezza del ruolo della leadership, ma la reazione delle varie sezioni dell’A.N.P.I. e dei movimenti che hanno partecipato alla manifestazione a Macerata ha mostrato chiaramente che non si obbedisce a leader istituzionali che tentano di rappresentare l’irrappresentabile anziché farsi portavoce di decisioni prese in conformità a dinamiche ispirate dal principio della decentralizzazione, soprattutto date la gravità del caso e l’urgenza della situazione. A questo punto penso che sia importante elencarli ancora una volta i motivi per i quali non c’è nessuna manipolazione politico-mediatica che tenga, perché’ è innegabile che la manifestazione di Macerata abbia raggiunto gli obiettivi prefissi sia da chi l’ha organizzata sia da chi l’ha resa possibile.
Come le manifestazioni nelle altre città d’Italia, anche quella di Macerata ha dimostrato il netto rifiuto dell’uso ideologico del concetto di giustizia sociale, strumentalizzato allo scopo di legittimare la spesa pubblica per la militarizzazione delle strade, una strategia che molte persone le terrorizza anziché rassicurarle. Al contrario, ha posto chiaramente l’accento sulla necessità di strategie completamente opposte, mirate alla risoluzione delle cause del conflitto sociale e non dei suoi effetti collaterali. Ha confermato che l’urgenza della questione richiede tempi di reazione brevi, perché temporeggiare in attesa di chissà quali circostanze migliori equivale a regalare tempo ai neofascisti per conquistare ancora più spazio di quello che si sono presi già. Ha dimostrato che ogni violazione del diritto alla libertà d’espressione del dissenso è inaccettabile. Anzi, l’autorizzazione last-minute della manifestazione di Macerata ha dimostrato che rivendicare la legittimità di un tale diritto è stata una strategia efficace a garantirne perfino la legalizzazione, nonostante l’immediata sostituzione del questore è un chiaro segno di intensificazione della centralizzazione del controllo nell’esecuzione delle politiche securitarie. Ha infine dimostrato la necessità dell’unità del blocco antifascista, e questo ce lo ricordano perfino gli aspetti più prettamente logistici della manifestazione.
Vorrei infatti ricordarvi che la piazza centrale di Macerata si chiama per l’appunto Piazza della Libertà. A forza di continuare a camminare insieme e unit* attorno alle mura che la tenevano barricata all’interno della zona rossa ce la faremo ad aprire un varco largo abbastanza da farci entrare tutt* per andare a riprendercela. Per questo è fondamentale continuare a non stare zitt*, soprattutto quando non si può stare zitt*. Siccome però non siamo tutt* professionisti della comunicazione e, anzi, a volte è proprio la sottoscritta a non essere capace di reagire adeguatamente alle provocazioni mediatiche, penso possa essere molto utile organizzarsi meglio anche su questo di fronte. Mi rivolgo dunque alle esperte e agli esperti di comunicazione invitandoli a produrre e diffondere materiale didattico sulle tecniche migliori per rispondere ad accuse e/o provocazioni fascio-razziste e fascio-sessiste. Ma torniamo alla manifestazione. Quali erano esattamente gli obiettivi? Ne erano almeno tre e vorrei brevemente richiamarli alla memoria prima di passare alla discussione dettagliata della concatenazione di cause che li hanno resi tali.
1. Dimostrare solidarietà a Jennifer, Mahamadou, Wilson, Festus, Gideon e Omar. Punto e basta, senza “se”, senza “ma” e senza “ne riparliamo dopo”.
2. Reagire agli svariati tentativi di sabotaggio della manifestazione e mostrare chiaramente che l’unità del blocco antifascista è la via più efficace per fronteggiare il terrore provocato dalla violenza e dallo stato di polizia.
3. Mettere in chiaro che l’esatta dinamica della morte di Pamela non incide sugli obiettivi della manifestazione e che, al contrario, li conferma, perché la denuncia resta la stessa: no alla violenza patriarcale e no a ogni tentativo di strumentalizzarla per finalità razziste, sessiste e fasciste.
Tento allora di analizzarli questi obiettivi, precisando che procedo cominciando dai primi due e che invece preferisco discutere il terzo obiettivo a parte, in un contributo separato da questo per un motivo ben specifico: la questione della violenza di genere strumentalizzata dalla retorica razzista richiede una discussione più approfondita, tale che possa evidenziare il filo diretto che connette la manifestazione di Macerata allo sciopero globale dell’8 marzo, perché la manifestazione del 10 febbraio è stata solo un inizio, mentre la lotta per la sublimazione di risentimento xenofobico e xenofilo in antifascismo antisessista continua.
L’abbraccio collettivo che i manifestanti hanno mandato a Jennifer, Omar, Gideon, Mahamadou, Kofi e Festus si è distinto per modalità sia dalle visite semi-silenziose delle tante persone che hanno inviato messaggi al direttore dell’ospedale di Macerata sia dalle visite ufficiali di figure istituzionali, queste ultime tanto invocate quanto arrivate troppo tardi, compresa – secondo me – anche la visita ufficiale del candidato maceratese di Potere al Popolo1. Se il superamento della paura (e del terrore come sua forma più estrema) costituisce un obiettivo prioritario, allora la solidarietà dimostrata è stata sicuramente di natura politica ma molto probabilmente l’effetto è stato anche psicologico. Gideon, Mahamadou, Jennifer, Omar, Festus e Wilson e anche tutto il resto della popolazione che non ha “la pelle italiana” lo sanno già da prima del 10 febbraio che non sono sol* quando camminano per strada sia di giorno che di notte, ma ora magari ne sono un po’ più consapevoli di prima e il che di certo non guasta. In fondo è lo stesso tipo di solidarietà e sicurezza che donne e persone LGBTI+ si infondono a vicenda non solo in strada ma anche attraverso i centri antiviolenza.
Tra l’altro l’effetto psicologico della manifestazione non si è fermato al locale ma ha contribuito a rafforzare anche gli animi di chi resiste laddove ogni tipo di manifestazione di dissenso è stato già vietato, come ad esempio qui in Turchia, dove – almeno per me – l’effetto del referendum costituzionale del 16 aprile 2017 è stato simile a quello della manifestazione di Macerata. Premesso che non mi capita di camminare in quartieri abitati a maggioranza da sostenitori di erdoğan, quando cammino per strada e alzo la guardia a ogni ombra o silhouette che incontro di notte, penso: “beh, dai, spera solo che sia uno della metà del Paese che non pensa che lo stato di emergenza sia rassicurante”. Poi che la maggioranza di quella metà promuove lo stesso nazionalismo e la stessa xenofobia che condividono le destre in Italia e in Europa è un altro discorso. Anzi, mi sa che si tratti proprio dello stesso discorso, lo stesso avvalorato dai media che hanno preferito dare spazio alla questione dei cori, confermando che la strategia del silenzio del sindaco Carancini è stata presa fin troppo alla lettera.
Almeno stavolta Carancini l’ha definito “temporaneo” il silenzio, mentre nel 2015 aveva già espresso la sua opinione circa le manifestazioni organizzate da soggetti altri dalle istituzioni ufficiali. Nell’occasione, una cinquantina di richiedenti asilo avevano dato vita a una manifestazione spontanea nel centro di Macerata per richiedere tempi più rapidi delle procedure di valutazione delle loro pratiche. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine, il blocco del traffico continuò fino all’arrivo del sindaco che commentò dichiarando che occupare le strade per ottenere l’ascolto delle autorità competenti è “un modo sbagliato” per reclamare diritti perché “non è possibile che, anche se fosse una giusta protesta, ne debbano andare di mezzo gli altri cittadini” (https://www.youtube.com/watch?v=I3vuzXLQOl0). È comprensibile quindi che la manifestazione ufficiale del 18 febbraio a Macerata è stata accolta con poco entusiasmo e parecchio silenzio da parte dei media di movimento, visto che è stata indetta proprio dagli stessi soggetti politici che avevano inizialmente vietato la manifestazione della settimana precedente.
L’unico silenzio che invece avremmo apprezzato sarebbe stato quello dei giornalisti sciacalli. Uno dei tanti esempi è la reazione del direttore di un quotidiano marchigiano (Picchio News) che ha addirittura esultato pubblicamente, perché l’eccezionale numero di visite alla pagina ha reso la giornata memorabile. Anche per Festus, Wilson, Omar, Jennifer, Gideon, Mahamadou e tutt* noi è stata una giornata memorabile e, anzi, a molte persone avrebbe fatto molto piacere se fosse stato dichiarato il lutto nazionale, se proprio avessimo voluto parlare di silenzi ufficiali. Neanche Minniti ci è andato a trovarli in ospedale, invece lo scorso dicembre accorse immediatamente alla sede del quotidiano “La Repubblica” in seguito al “blitz fascista” di un gruppo di forza nuova. Nel bel mezzo di tutto questo silenzio invocato per fini politici non possiamo però dimenticarci che parte della popolazione locale ha sinceramente invocato il silenzio per riprendersi dal terrore scatenato sia dalla possibilità reale di un’escalation di violenza sia dall’instaurazione “temporanea” dello stato di polizia in quella che fino a poco tempo prima sembrava una tranquilla cittadina di provincia. Che pensare di loro?
Personalmente mi dichiaro disposta a comprendere che, se la paura era diventata terrore, può aver realmente paralizzato anche chi la voce l’avrebbe pure alzata. Magari trovarsi per la prima volta a una distanza così ravvicinata con forme estreme di espressione fisica della violenza sessista e razzista può aver determinato uno shock tale da (far) richiedere una pausa di riflessione. Sto invocando comprensione nei confronti di chi non è abituato a fronteggiare quotidianamente la violenza e per questo la teme? In parte sì e in parte no, perché in fondo la teme anche chi è abituat* da più tempo ad affrontarla, ma non per questo può arrogarsi il diritto di giudicare i limiti della paura altrui, così come chi ha paura (o prova perfino terrore) non ha nessun diritto di impedire a chi a meno paura di manifestare liberamente la propria solidarietà e di esprimere dissenso, né tantomeno ha il diritto di diffonderla la propria paura. Il principio dell’autodeterminazione docet anche in questo caso.
Questo è un aspetto fondamentale di cui io ad esempio ho preso piena coscienza durante la manifestazione globale contro la violenza sulle donne lo scorso 25 novembre a Istanbul. Stavamo gridando lo slogan “susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” (“non stiamo zitte, non abbiamo paura, non obbediamo”) quando io, terrorizzata dalla presenza massiccia della polizia e incoraggiata solo dalla presenza delle altre donne e delle persone LGBTI+, mi sono rivolta a un’altra donna e le ho detto: “sì, diciamo che non abbiamo paura ma io in realtà ne ho tantissima”. Lei si è immediatamente voltata dall’altra parte senza neanche rispondermi, facendomi chiaramente capire che quello che si aspettava da me, soprattutto in quella situazione, era supporto e non un commento ansiogeno.
 La manifestazione di Macerata è stata importante anche per un altro motivo, e cioè per distanziarsi nettamente dalle reazioni inconsciamente e consciamente razziste di chi avrebbe appoggiato l’idea di un’iniziativa anti-violenza promossa dalla comunità nigeriana maceratese, come se ci fosse stato bisogno di dimostrare innocenza e giustificarsi di un reato mai commesso onde evitare il linciaggio fisico, anche perché non sarebbe comunque stata sufficiente a ridurre gli effetti del linciaggio mediatico. Chiaramente anche per la comunità nigeriana vale lo stesso discorso anti-islamofobico che è valso per le comunità musulmane in Europa in precedenza: non avevano nessun dovere morale di dimostrare la propria innocenza nelle occasioni in cui è stato l’Isis ha rivendicare gli attacchi terroristici. Capisco però che si tratta sempre dello stesso obiettivo quando si tratta di dimostrazioni di innocenza e non di dimostrazioni di solidarietà: scongiurare l’esecuzione sommaria perpetrata dal Luca Traini di turno che, nel caso specifico, è accusato di strage aggravata da finalità di razzismo e porto abusivo di armi.
La manifestazione di Macerata è stata importante anche per un altro motivo, e cioè per distanziarsi nettamente dalle reazioni inconsciamente e consciamente razziste di chi avrebbe appoggiato l’idea di un’iniziativa anti-violenza promossa dalla comunità nigeriana maceratese, come se ci fosse stato bisogno di dimostrare innocenza e giustificarsi di un reato mai commesso onde evitare il linciaggio fisico, anche perché non sarebbe comunque stata sufficiente a ridurre gli effetti del linciaggio mediatico. Chiaramente anche per la comunità nigeriana vale lo stesso discorso anti-islamofobico che è valso per le comunità musulmane in Europa in precedenza: non avevano nessun dovere morale di dimostrare la propria innocenza nelle occasioni in cui è stato l’Isis ha rivendicare gli attacchi terroristici. Capisco però che si tratta sempre dello stesso obiettivo quando si tratta di dimostrazioni di innocenza e non di dimostrazioni di solidarietà: scongiurare l’esecuzione sommaria perpetrata dal Luca Traini di turno che, nel caso specifico, è accusato di strage aggravata da finalità di razzismo e porto abusivo di armi.
Per chiarire qualche dubbio che è circolato sui social sarebbe opportuno precisare che, secondo l’art. 422 del codice penale italiano, il reato di tentata strage non esiste. Non è infatti l’esito ma il fine dell’azione che conta per la legge in vigore. In altre parole, se i giudici confermeranno che il suo scopo è stato uccidere, Traini potrebbe essere condannato non all’ergastolo ma a 15 anni, anche se Omar, Mahamadou, Jennifer, Gideon, Wilson, e Festus non sono mort*. I giuristi parlano di pubblica incolumità mentre io preferisco non entrare in tema di punizioni e certezza delle pene. Vorrei piuttosto ripetere quanto è stato già detto da molt*: il ricorso alla follia non può assolutamente giustificare la violenza razzista e sessista di Traini. A proposito di follia, mi vengono in mente le parole di un caro amico col passaporto nigeriano bloccato a Istanbul da anni perché anche lui è un sans papiers: “La violenza in Libia è una follia, cara mia!”. Se/quando ricapita che mi mostra la cicatrice sul ginocchio gli ripeto più forte e più chiaro che quella pallottola non era follia ma che quella follia è effetto del fascismo. Pare invece che la linea difensiva degli avvocati di Traini – notoriamente spesati dai neofascisti – sarà proprio incentrata sull’“infermità mentale temporanea”, come se l’attentato terroristico fosse stato l’effetto di un raptus di follia. L’incapacità di gestire le emozioni implicata dal disturbo borderline della personalità non può in nessun modo giustificare un’azione che è comunque coerente con un preciso percorso politico che l’ha preceduta e determinata. Con questo però non voglio assolutamente sminuire l’importanza di tener conto delle cause sociali che possono influire sulla salute mentale di una persona, tutt’altro.
L’“allarme sicurezza” è reale ma, quando è strumentalizzato dalle politiche securitarie e xenofobe, non può non condurre ad altro che all’affermazione di stati di emergenza, col rischio che la gente rimanga terrorizzata a casa anche dopo la cattura dell’attentatore fascista, soprattutto se ha “la pelle non italiana”. Sui social c’è anche chi ha scritto che il rumore degli elicotteri ha fatto riaffiorare alla memoria il terrore dei giorni del terremoto. Non sono un’esperta di psicologia ma mi sembra che in gergo si chiami trauma secondario e c’è assolutamente da evitare che diventi contagioso, anche perché tra l’altro potrebbe essere usato da tutti gli avvocati dei potenziali Traini come attenuante. La paura è funzionale finché si limita a essere sinonimo di prudenza, invece continua a essere strumentalizzata politicamente per dividere e dominare più facilmente. Paura e terrore sono contagiosissimi e lo è anche la xenofobia proprio in quanto forma di paura.
Sia la violenza di genere che la xenofobia dipendono da cause sia psicologico-culturali che sociali. Come effetto di cause psicologico-culturali si materializza in paura della diversità etnica, fondata sull’idea che le persone straniere sono necessariamente nemiche. Ma siccome la xenofobia dipende anche da cause sociali, sappiamo benissimo che anche chi ne è affetto non teme tutte le persone straniere alla stessa maniera, poiché la strumentalizzazione politica del conflitto sociale determina la deviazione della paura in canali preferenziali che cambiano a seconda del momento storico e della fase di sviluppo dei sistemi di governo così come del sistema di produzione. Oggigiorno in Europa tocca ai migranti neri e a quelli musulmani, mentre ieri in Italia toccava ai “terroni” e a questo proposito consiglio la lettura del testo di Carla Panico, utilissimo per ricordarci di come quelli che ora chiamiamo “neo”-fascisti strumentalizzano l’idea di razza già da molto tempo e non solo per categorizzare i bianchi e i neri ma anche per accusare il sud sottosviluppato di invadere il produttivissimo nord. Nonostante pensi che il binomio sud-nord non sia sufficiente a cogliere la complessità implicata dal suprematismo di alcuni regionalismi su altri, sono assolutamente d’accordo con Carla quando pone l’accento sulla necessità di uscire dal pensiero dicotomico che caratterizza la storia del pensiero europeo.
In Turchia ad esempio tocca ai migranti neri ma anche ai rifugiati siriani, questi ultimi attaccati sia dai cosiddetti turchi bianchi sia dai turchi neri. “Turchi bianchi” è un’espressione usata dall’élite “occidentalizzata” e “modernizzata” dei seguaci del secolarismo religioso per distinguersi dai cosiddetti “turchi neri”, vale a dire i migranti (per lo più musulmani) che dalle province “sottosviluppate” dell’Anatolia si sono riversati nelle grandi metropoli in cerca di lavoro, curdi compresi. Ma anche in Turchia certe categorie cominciano a non essere più sufficienti per descrivere i processi migratori, dal momento che a migrare in Germania o in Grecia è stata proprio una buona parte dell’élite che non è finita in galera dopo il “tentato” colpo di stato. Ultimamente a questa categoria di migranti si stanno aggiungendo famiglie con il passaporto che è turco ma che è anche bloccato dai decreti governativi emanati durante lo stato di emergenza, anche se queste ultime non fanno ancora troppa notizia sulla scena internazionale, perché sono ancora troppo poche quelle che finora sono morte in mare mentre tentavano di arrivare sulle coste greche col gommone.
Anche se mi rendo conto che parlare di neofascisti e antifascist* in qualche modo riproduce il pensiero dicotomico, vorrei porre l’accento ancora una volta sull’urgenza di trovare alternative a questo modo di pensare, perché è proprio lo stesso pensiero dicotomico a permettere la distinzione delle persone straniere in due categorie: quelle da temere/cacciare e quelle di cui fidarsi e perfino invitare/attirare. Per dirla in altri termini, penso che non possiamo capire la strumentalizzazione politica della xenofobia se non la analizziamo insieme alla strumentalizzazione politica della xenofilia. La dinamica della polarizzazione sociale contemporanea è evidente. Da un lato ci sono i migranti che scappano non solo dalle guerre ma anche dalla povertà delle ex-colonie europee o che, molto più semplicemente, vorrebbero poter reclamare il diritto a viaggiare e anche a vivere da cosiddetti “expat” tanto quanto ne abbiamo il diritto noi che i documenti ce li abbiamo. Dall’altro lato non ci sono solo i turisti ma anche gli studenti stranieri che, nel caso di Macerata, sono per lo più cinesi e non sono per niente diversi da me che venni a studiare in Turchia grazie a uno dei programmi più prestigiosi e meglio remunerati dell’Unione Europea. L’arrivo di capitale finanziario attraverso flussi di investimenti stranieri, turisti ed expat determina una xenofilia che, tanto quanto la xenofobia, viene strumentalizzata dalle amministrazioni cittadine per tenere il passo con i processi di globalizzazione. L’odio di classe, invece, è sublimato in xenofobia, perché le classi dirigenti hanno bisogno (in Italia come altrove) di offrire un capro espiatorio in pasto all’elettorato che aspira al benessere economico per motivi che possono essere diversi e che non si escludono necessariamente a vicenda.
Recentemente Alberto De Nicola ha fornito un’ottima analisi dei gruppi sociali che si neofascistizzano. Criticando la semplificazione della questione e rifiutando la generalizzazione diffusa della teoria della guerra tra poveri, De Nicola ha spiegato che all’interno del blocco dei sostenitori del neofascismo non ci sono solo soggetti poveri ma anche categorie sociali che aspirano a una maggiore inclusione nelle dinamiche di riaccumulazione di ricchezza che sono seguite alla crisi del 2007-2008 . Quello che penso io è che la teoria della guerra tra poveri non escluda l’analisi proposta da De Nicola, anzi, sono complementari, proprio perché la molteplicità di identità sociale caratterizza le realtà delle periferie romane, dell’entroterra marchigiano e delle altre regioni europee, Berlino est compresa (come ad esempio mostra anche questo interessante reportage).
Nel primo caso – nel caso della guerra tra poveri – la xenophobia e l’odio che ne conseguono possono dipendere dalle conseguenze dell’impoverimento dovuto alla crisi ma anche da una povertà economico-culturale da cui alcuni gruppi sociali non si sono mai emancipati se non limitatamente attraverso il sostegno di politiche sociali del welfare state. Nel primo caso si tratta dunque di una guerra per la sopravvivenza tra più poveri sans papiers e meno poveri con la cittadinanza. Pur non conoscendo direttamente Roma, mi permetto di azzardare che la guerra tra poveri delle periferie romane non sia molto diversa (se non per livelli di povertà ovviamente) dalla guerra tra poveri in alcune inner city slum delle metropoli turche, dove perfino curdi filo-HDP e sans papiers nigeriani pensano che la gentrificazione brutale dei loro quartieri sia colpa delle ondate di rifugiati siriani.
Nel secondo caso – nel caso descritto da De Nicola – si tratta invece di una guerra che i benestanti hanno dichiarato ai poveri e a certe categorie di stranieri perché, secondo loro, intralciano la loro corsa, quella del “loro Paese” e della “loro Nazione” verso la ricrescita economica. Nel secondo caso si tratta della parte dell’elettorato che include al suo interno anche “lu scarpà” della prima parte di questo contributo e gli stessi imprenditori che lo scorso 5 febbraio hanno discusso con erdoğan di investimenti nel settore delle grandi infrastrutture in una cena d’affari che è seguita all’incontro con papa Francesco prima e con Gentiloni e Mattarella dopo. Come se discutere di investimenti nel settore della difesa con uno dei principali responsabili delle violazioni dei diritti umani in corso in Turchia non fosse complicità col neofascismo e fosse meno riprovevole dell’attentato di Macerata, condannato spudoratamente anche da Erdoğan, che lo ha paragonato al terrorismo che affligge anche la Turchia, praticamente paragonando giornalisti e accademici in galera a Luca Traini. Ma tanto lo ripetiamo fin da troppo tempo che il “refugee deal” con la Turchia è stato uno degli strumenti principali per permettere a Paesi come la Germania di “accogliere” i rifugiati più professionalmente utili da “integrare”/assimilare. Le distinzioni di classe fanno chiaramente comodo quando si tratta di accaparrarsi i rifugiati migliori da “accogliere” dalla Siria, ingegneri e medici compresi.
Ci sono soluzioni possibili alle guerre globali tra poveri e anche alle guerre tra i migranti e i non-piu-benestanti-come-prima? Aivoglia! C’è chi le propone da tempo e le ha perfino incluse nel proprio programma politico per candidarsi alle elezioni del prossimo 4 marzo. La sinistra radicale è d’accordo su un punto basilare, al di là di ogni dibattito sui rischi della partecipazione alle logiche e ai meccanismi della rappresentanza che avevano iniziato a occupare la discussione nei giorni precedenti ai fatti di Macerata. Rilanciare l’anticapitalismo è la soluzione più plausibile per sublimare la xenofobia in indignazione capace di mobilitare i soggetti sfruttati economicamente, compresi i migranti con il permesso di soggiorno e quelli senza papiers, compresi i poveri bianchi e i benestanti impoveriti che usufruiscono dei privilegi della cittadinanza, e comprese dunque anche le donne con o senza papiers che lottano per l’uguaglianza anche sul piano economico. Reddito minimo garantito pagabile attraverso la redistribuzione di ricchezze, beni comuni, decrescita ed economie alternative sono solo alcune delle parole chiavi che possiamo usare per scegliere in quale tipo di società preferiamo vivere in base alla rosa di modalità disponibili per la produzione di valore. Per capire però fino in fondo perché quella che chiamiamo neofascistizzazione dell’Italia in realtà non è realmente un processo nuovo se non per le dinamiche con cui è tornato alla ribalta, non possiamo non tenere conto del ruolo fondamentale svolto dai media negli ultimi anni, soprattutto alla luce della trasformazione radicale degli stessi.
Negli anni ’90 mi ricordo che “marocchino”, “albanese”, “zingaro” e “rumeno” avevano più o meno lo stesso significato che ha ora “spacciatore nigeriano”, ma fino a qualche anno fa i neofascisti non avevano la possibilità di essere così visibili, anche perché fino ai primi anni 2000 i programmi di satira mandavano i fascisti su Marte, mentre ora mi pare di aver capito che i programmi televisivi in prima serata non fanno ridere più. In fondo il successo dei pentastellati ha dimostrato proprio che anche chi votava a sinistra pensando di poter essere rappresentat* in realtà ce l’ha sempre avuto qualche grosso problema coi migranti. È per questo che temo tantissimo per tutt* quell* che passano ore e ore davanti alla TV o sui social, pensionati e disoccupati compresi. Spero solo che le relazioni di quartiere siano sufficienti a smorzare l’effetto del bombardamento mediatico e bastino per non indurre almeno mia madre alla tentazione di generalizzare. Mi ha raccontato di essere stata positivamente impressionata dalla gentilezza del gesto di una bambina pakistana che la saluta sempre ogni volta che si incontrano affacciate alla finestra. Vive nella casa a fianco a quella dove abitava John, il primo vicino di casa nigeriano della mia vita e una persona altrettanto gentile che mi sorrideva sempre quando ero io a essere una bambina. Pensiamo allora a come riappropriarci di spazio mediatico usando anche l’ironia e la satira intelligenti. Le manifestazioni sono fondamentali ma purtroppo, ogni volta che la polizia le attacca, perdono il potenziale che hanno di attivare le passioni utili.
Lo scontro è reale e occupa anche le strade. Difendiamole e riprendiamocele ma evitiamo di farci strumentalizzare dai paladini della retorica della legalità, che sono gli stessi che – come i (neo)fascisti – ostacolano il processo di legalizzazione delle droghe leggere, una battaglia che va riproposta con più determinazione e che va ovviamente affiancata da campagne di sensibilizzazione sull’uso delle droghe, alcool compreso, mirate non solo ai più giovani ma anche a tutti quelli della mia generazione che pare non si ricordino degli anni ’80 e degli effetti delle dipendenze patologiche, soprattutto quella da eroina. Quando riparlarne, se non ora che i media pompano storie di cannibalismo e riti voodoo? Iniziamo intanto dal liberarli i territori occupati dalla mafia, sia essa pakistana, albanese, nigeriana o italiana, sottraendole il controllo della produzione e la distribuzione di canapa sativa. Proviamo a vedere di quanto realmente la criminalità organizzata può effettivamente diminuire e la qualità delle sostanze aumentare. Di campi di canapa ce ne sono già tanti ed esistono già anche progetti come EasyJoint che, proprio nella regione Marche, commercializza canapa sativa legale di elevata qualità allo scopo di contribuirne la legalizzazione, un processo che in Italia è ostacolato non solo dalla presenza massiccia delle mafie ma anche da motivazioni di carattere socio-culturale.
Iniziamo a riproporre chiare distinzioni tra uso ricreativo, dipendenze patologiche e dipendenze che patologiche non lo sono. Lo so che sono tutt* accorsi a pippare sigarette elettroniche non appena lo stato ha deciso quale droga propinare ai propri cittadini. Ben venga chi ce l’ha fatta a smettere di bruciarsi i polmoni e i soldi che riesce a malapena a guadagnare come me, ma che almeno ci vengano risparmiati i giudizi di carattere morale. A meno che non vogliano fare come gli americani di alcuni degli Stati Uniti o, peggio ancora, seguire il modello dei tanto temuti musulmani fondamentalisti al punto da vietare pure la produzione e la distribuzione del vino, che invece è da sempre promosso come uno degli elementi portanti dell’identità culturale italiana. Se abusato, sappiamo benissimo che anche il vino porta tranquillamente a dipendenze tanto patologiche tanto quelle causate dalle slot machine, proprio perché qualche pubblicità progresso non è sicuramente sufficiente a risolvere i problemi economici e psicologici delle persone che ne abusano. Ma al momento siamo tranquilli, perché in Italia non si rischia il divieto del vino, dato che produce profitto e attira pure turisti, appunto perché è una droga leggera e non è nemmeno monopolio di stato né della mafia.
 I paladini della legalità sono anche le stesse persone che al nigeriano di turno contestano non solo lo spaccio di stupefacenti ma anche l’illegalità e so quanto siamo stanch* di ripeterla la differenza con la nostra posizione politica in merito alla questione dell’irregolarità dei documenti. A loro sarebbe il caso di ripetere ancora una volta che la nostra solidarietà con i sans papiers comincia proprio dalla ridefinizione dei margini di legalità a partire dalla discussione della legittimità delle richieste, compresa quella di manifestare il dissenso il 10 febbraio scorso a Macerata, mentre i caranciniani hanno invece preferito lasciare le/i manifestanti “temporaneamente” sol* con i fascisti che dominavano i media e pure le strade. L’irregolarità dei sans papiers è infatti un problema che cerchiamo di risolvere già da tanto tempo ma in maniera diversa da come fa la maggioranza dei gruppi politici, siano essi quelli che propinano ronde fasciste, espulsione immediata e aiuto a casa loro o quelli che propongono blocco degli sbarchi, rimpatrio più o meno volontario, esternalizzazione dei confini, militarizzazione delle strade, integrazione economica e accordi bilaterali. Prendiamo esempio da loro, perché non proviamo a riappropriarci noi del linguaggio loro? Tutti, noi compres*, concordiamo infatti sull’urgenza di rivedere e rinnovare gli accordi bilaterali per l’integrazione economica e sociale. Siamo d’accordo perfino sull’aiutarli a casa loro, ma in un’accezione completamente diversa, perché sostituiamo i termini “difesa” e “invasione” con proposte alternative come blocco del commercio di armi e cooperazione transnazionale.
I paladini della legalità sono anche le stesse persone che al nigeriano di turno contestano non solo lo spaccio di stupefacenti ma anche l’illegalità e so quanto siamo stanch* di ripeterla la differenza con la nostra posizione politica in merito alla questione dell’irregolarità dei documenti. A loro sarebbe il caso di ripetere ancora una volta che la nostra solidarietà con i sans papiers comincia proprio dalla ridefinizione dei margini di legalità a partire dalla discussione della legittimità delle richieste, compresa quella di manifestare il dissenso il 10 febbraio scorso a Macerata, mentre i caranciniani hanno invece preferito lasciare le/i manifestanti “temporaneamente” sol* con i fascisti che dominavano i media e pure le strade. L’irregolarità dei sans papiers è infatti un problema che cerchiamo di risolvere già da tanto tempo ma in maniera diversa da come fa la maggioranza dei gruppi politici, siano essi quelli che propinano ronde fasciste, espulsione immediata e aiuto a casa loro o quelli che propongono blocco degli sbarchi, rimpatrio più o meno volontario, esternalizzazione dei confini, militarizzazione delle strade, integrazione economica e accordi bilaterali. Prendiamo esempio da loro, perché non proviamo a riappropriarci noi del linguaggio loro? Tutti, noi compres*, concordiamo infatti sull’urgenza di rivedere e rinnovare gli accordi bilaterali per l’integrazione economica e sociale. Siamo d’accordo perfino sull’aiutarli a casa loro, ma in un’accezione completamente diversa, perché sostituiamo i termini “difesa” e “invasione” con proposte alternative come blocco del commercio di armi e cooperazione transnazionale.
Capito perché sostengo che il problema inizia con il pensiero dicotomico che alimenta narrative eurocentriche? Secondo me, il punto è proprio ripensarla radicalmente l’idea di Europa e fare un po’ quello che sta facendo erdoğan con le vecchie province dell’impero, ma ovviamente senza ricorrere ai rigurgiti imperialistici, romani o ottomani che siano. Sono d’accordo anch’io che l’Europa non finisce a Melilla e Lampedusa né tantomeno a Edirne, ma per scrollarci di dosso il passato coloniale non possiamo non ripensarla come Afri-Europa. So che suona perfino più utopico della degna accoglienza – se non addirittura visionario –ma penso che, per superare il dibattito sullo ius soli, una via d’uscita potrebbe essere estenderlo anziché ridurlo, proponendo la cittadinanza afro-europea a tutt* coloro che sono nat* nelle ex-colonie. Ovviamente bisognerebbe prima chiederlo ai diretti interessati per evitare di ricadere nel solito rischio di parlare a nome loro, ma propongo questo semplicemente ispirata dalle parole di una giovane donna che ha partecipato all’incontro tra una rappresentanza degli studenti del Burkina Faso e Macron durante il suo recente Tour d’Afrique. Mentre una mosca volava in tondo sulla sua faccia, lei si è rivolta alla platea, ovviamente a stramaggioranza nera, e gli ha detto a chiare lettere: “Monsieur le President, ça c’est la France!”.
Se si potesse reclamare cittadinanza nei paesi d’origine – e non solo diritto d’asilo come vorrebbe invece il processo di Khartoum – allora magari gli sbarchi e il traffico di umani via mare potrebbero davvero diminuire. La logica del discorso è la stessa di quando proponiamo la legalizzazione delle droghe leggere. Per la vecchia Europa sarebbe anche un modo per avere accesso più facile alle risorse, con la fondamentale differenza che il principio del “io ti do le armi, tu dammi le risorse” potrebbe essere sostituito con il principio “io ti riconosco la cittadinanza, tu mi faresti usare le tue risorse?”. La libera circolazione delle merci e delle persone mi sembra l’unica prospettiva per evitare conflitti maggiori, i quali in futuro potrebbero davvero diventare delle vere e proprie invasioni, e a quel punto poi starebbe a noi decidere da che parte stare, se con l’invasore vecchio o con l’invasore nuovo, dato che la mancata presa di posizione sarebbe un po’ come il silenzio proposto da Carancini.
Non sono esperta di economia per poter capire fino a che punto la libera circolazione delle merci potrebbe essere libera nel senso di libera dalle logiche neoliberiste. Mi rendo conto però della necessità di trovare soluzioni adeguate in modo da poter disporre equamente delle risorse, comprese le miniere di cobalto per la produzione degli smartphone, dato che ormai sembrano essere diventati indispensabili, e compresi pure i campi di cannabis nigeriana, solo che con i nigeriani maschi e nazionalisti prima sarebbe utile farci un bel discorsetto visto che, da quel poco che so, non è bastato neanche il cavaliere nero Fela Kuti a far fumare anche le donne. Ma ovviamente in tutto questo discorso rischiavo di dimenticare un problema importante: la Nigeria non era una colonia né francese né italiana ma britannica, e Brexit invece è una realtà ormai. Infine ce n’è anche un altro di problema a cui non so rispondere senza l’aiuto delle persone più esperte in materia. Fino a che punto il concetto di cittadinanza sovranazionale contraddice i tentativi di ridurre la scala dei processi decisionali relativi alla produzione dei territori? Non ho una risposta, ma immagino che una soluzione possibile sia proprio il rifiuto del concetto di cittadinanza come appartenenza a uno stato nazionale e/o sovranazionale su base etnica, vale a dire l’opposizione a ogni tipo di nazionalismo così come lo conosciamo ora.