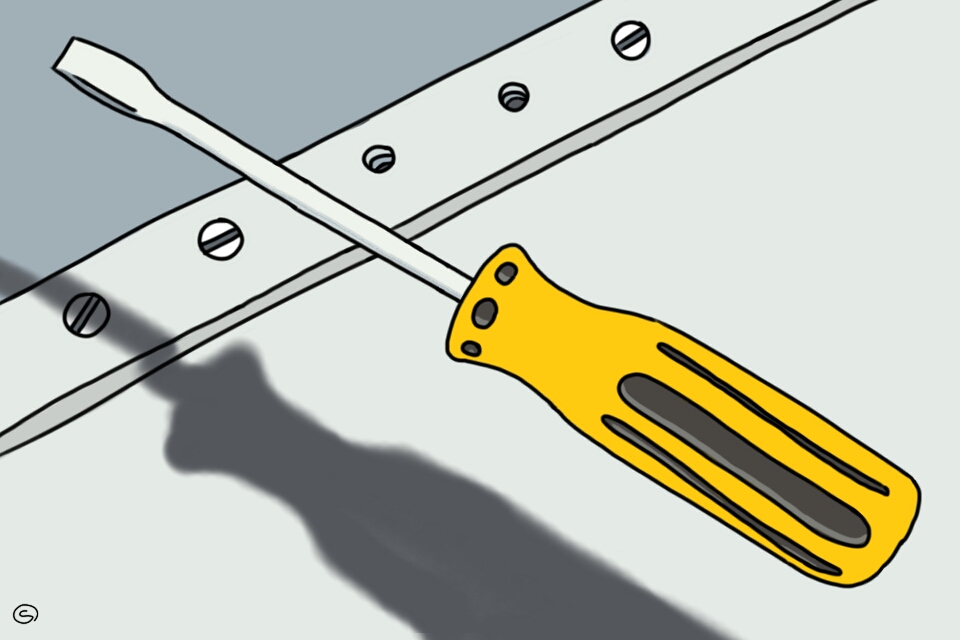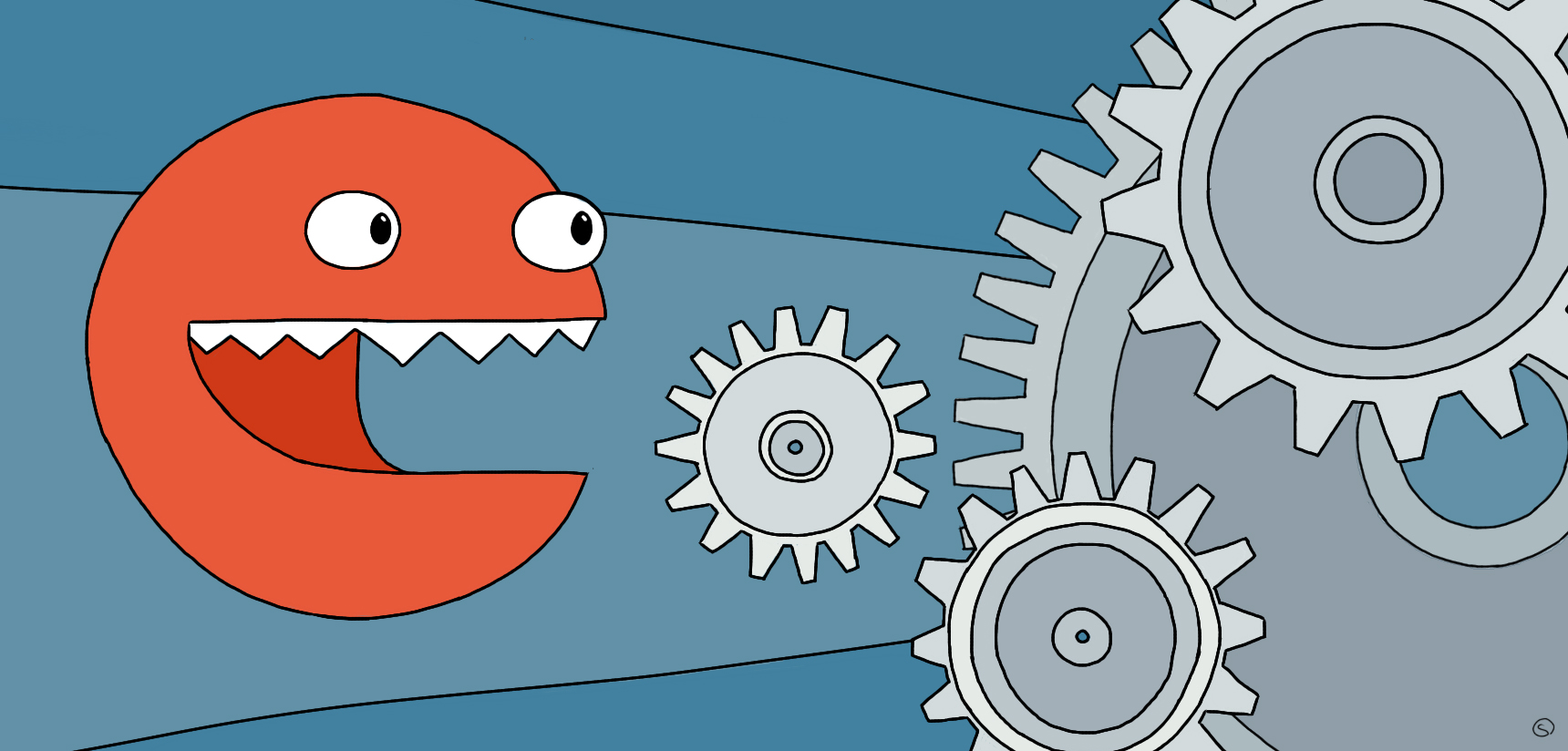di MARCO BASCETTA*. Qualche anno fa Pierre Dardot e Christian Laval ci avevano proposto un ampio affresco del neoliberismo come «nuova ragione del mondo». In un testo assai più breve e decisamente meno ambizioso Paul Ginsborg e Sergio Labate (Passioni e politica, Einaudi, pp.130, euro 12) ce lo descrivono come potente governo delle passioni, capace di farle confluire in una nuova, pervasiva forma di «servitù volontaria». Nell’un caso e nell’altro il neoliberismo non viene considerato solo come un modo di produzione e un sistema economico, sia pure munito degli apparati ideologici e giuridici necessari al suo funzionamento, ma anche come una forma di vita e un insieme di processi di soggettivazione capaci di integrare l’intera società e la pluralità dei suoi componenti nel processo di accumulazione del capitale.
L’argomentazione di Ginsborg e Labate muove dalla distinzione storica tra la sfera della razionalità e quella delle passioni e dalla convinzione che la prima risulti del tutto impotente di fronte a quello che gli autori definiscono il «romanticismo neoliberista» che ha progressivamente colonizzato i nostri desideri e condizionato i nostri comportamenti, portando a compimento nella più insidiosa delle forme quell’«integrazione» della personalità di cui Herbert Marcuse scriveva già mezzo secolo fa. E subito insorge qui un primo problema nell’isolare il tema delle passioni.
Il neoliberismo ha infatti reso assai permeabile il confine (da sempre problematico) tra razionalità e irrazionalità (basti pensare al vitalismo, tra analisi e superstizione, che anima il capitale finanziario) e tradotto in raffinati algoritmi desideri e aspirazioni. E, del resto, la «ratio» stessa è sempre stata a sua volta una passione, desiderio irrefrenabile di dominare il caos del mondo privato del suo ordine divino. Di questo ordine razionale il neoliberismo si pretende custode rigoroso non meno che seduttore delle nostre passioni. Quando afferma perentoriamente di essere privo di alternative non blandisce certamente alcun «romanticismo», ma si pone, appunto, come unica e indiscutibile «ragione del mondo».
La gabbia del merito
Non si può negare, tuttavia, come sostengono gli autori, che attraverso una serie molto articolata di strumenti (e anche qualche processo involontario) il neoliberismo sia riuscito a penetrare a fondo nella vita intima dei singoli e metterne a profitto passioni, desideri, talenti e inclinazioni. Non avrebbe dunque alcun senso opporre un catalogo di passioni positive ad un altro di passioni negative, e non solo per l’ambiguità che tutte le attraversa, ma perché le une e le altre possono essere messe al servizio del processo di accumulazione e a salvaguardia delle gerarchie sociali esistenti
Il neoliberismo non fa altro che includere ogni passione umana nel dispositivo, razionale (funzionale cioè alla crescita dei profitti) ed emotivo al tempo stesso, che gli è proprio: la competizione, non di rado declinata nella categoria morale del «merito» a sua volta imparentata con l’antica idea di «virtù». All’interno della quale il «capitale umano» di ogni singolo riceve l’occasione per accrescersi in quanto tale. Il matrimonio di interessi, per fare un solo esempio, esiste dalla notte dei tempi, ma dubito che qualcuno prima degli anni 80 del secolo scorso abbia mai sentito parlare di una relazione amorosa in termini di «investimento affettivo».
Ora, caratteristica ineludibile di ogni competizione è che essa comporta vincitori e vinti. E sospinge i secondi, salvo conceder loro la possibilità di provarci una seconda volta, verso un unica «passione» (o grumo di passioni): il risentimento. Di questo stato d’animo Nietzsche e Max Scheler ci hanno spiegato l’essenziale: si tratta di una passione «reattiva» che non trae da sé alcuna forza, ma rovescia la sua impotenza vittimaria in virtù e in colpa il successo altrui. Consumandosi in un rancore incapace di agire, la massa dei perdenti invoca un vendicatore dei torti subiti. Che si tratti di un dio, di una religione, di una comunità immaginaria o dell’uomo forte. Di questa deriva Hans Magnus Enzensberger ci ha offerto una efficace descrizione in un breve scritto di alcuni anni fa intitolato Il perdente radicale.
I perdenti globali
Il risentimento è, insomma, la passione politicamente mobilitabile per eccellenza. La delega portata alle sue estreme conseguenze. Il mondo contemporaneo, dall’Isis alle destre identitarie e xenofobe che avanzano in Europa, ci offre una infinità di esempi della forma velenosa che lo stesso antiliberismo (ovviamente con tutti i compromessi del caso, stipulati dagli smaliziati condottieri di questi diseredati) può assumere tra i numerosi perdenti nella competizione globale. Il gioco di specchi tra competizione e risentimento domina, dunque, la scena, né può venirci in soccorso la distinzione tra passioni individuali e passioni collettive, potendo entrambi assumere l’una o l’altra forma. La prima come concorrenza tra nazioni (senza escludere l’eventualità della guerra) oltreché tra individui. Il secondo come frustrazione privata oltreché come odio razziale o «scontro di civiltà».
Ginsborg e Labate propongono di opporre alla colonizzazione liberista dei desideri e dei comportamenti una sorta di «autogoverno» delle passioni che ne privilegi l’inclinazione verso l’armonia sociale e il rispetto per il bene comune. Magari coltivando combinazioni «equilibrate» di passioni diverse come fermezza e temperanza o «curiosità e privacy» ed escludendo quelle decisamente impresentabili. Quanto ai governanti poi, si suggerisce loro di mitigare il proprio narcisismo ricordando le severe virtù prescritte da Max Weber. Il rapporto tra politica e passioni prende insomma, nelle conclusioni degli autori, la forma di un galateo, se non proprio di un catechismo, delle relazioni sociali e del potere statale.
Stendardi sanfedisti
Una diffidenza di fondo nei confronti della libertà individuale (non a caso il tema della libertà è del tutto assente in questo testo, se non come sottrazione alle lusinghe del mercato) consegnata senza residui al neoliberismo conduce Ginsborg e Labate a prediligere come sede delle passioni migliori, e come interlocutore privilegiato dello Stato, le famiglie. Quelle per bene, naturalmente, che non giocano l’affettività interna contro il mondo esterno, aperte e solidali, bridging, secondo una terminologia sociologica che rimedia coi neologismi all’inconsistenza dei concetti. Ma soprattutto nucleo sociale nel quale la libertà di scelta dei singoli è limitata per definizione e fin dall’origine. La parola d’ordine che conclude questo viaggio disincarnato, contraddicendo ogni materialismo spinoziano e non, attraverso le passioni è «connettere la politica con la sfera familiare».
Questa politica è lo Stato che, se saprà dimostrarsi «accogliente e incoraggiante», le famiglie sapranno rispondere positivamente appassionandosi alla causa comune. Se non fosse che, per questa volta, non si è voluto disturbare il padreterno non saremmo poi così lontani dallo stendardo sanfedista del Dio, Patria e Famiglia (lo Stato si suppone infatti essere quello nazionale). E siffatte conclusioni non dovrebbero affatto dispiacere a quei campioni dell’antiliberismo che rispondono ai nomi di Matteo Salvini e Victor Orban.
*Questo articolo è stato pubblicato da il manifesto il 17 giugno 2016.